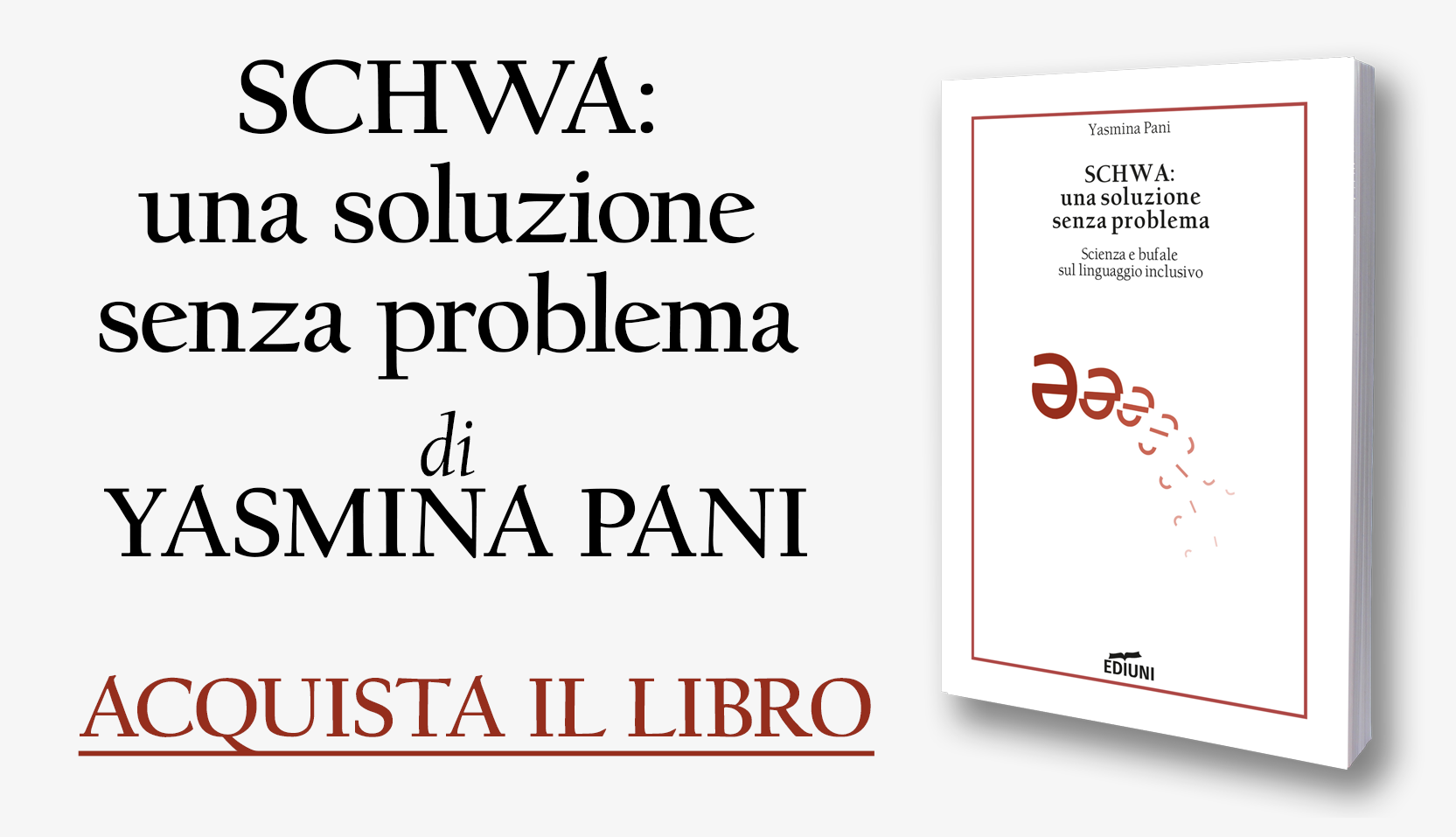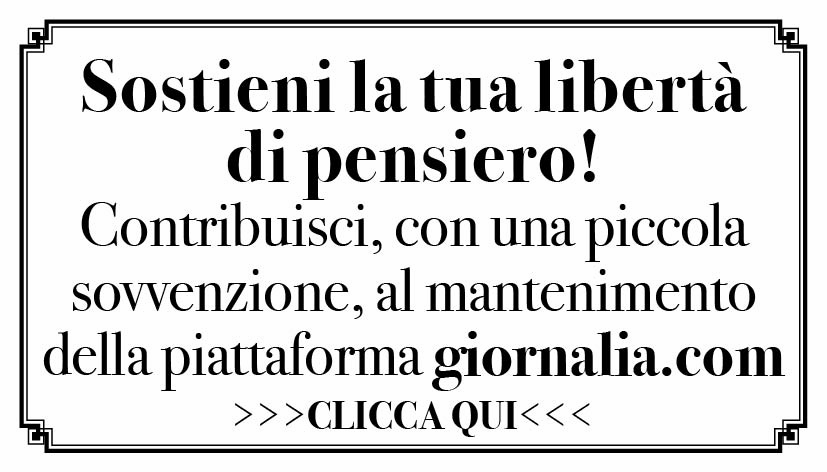Bachisio Zizi, lo scrittore che non s’arrese. A sette anni dalla sua scomparsa, rivisitando la sua bibliografia (fra risvolti e quarte di copertina, premesse, dediche ed eserghi) – parte prima
di Gianfranco Murtas

Debbo, debbo sempre onorare la grande memoria di Bachisio Zizi, intellettuale fra i maggiori sul versante letterario (ma nutrito di competenze economiche ed esperienze bancarie di prim’ordine) della Sardegna del secondo Novecento e dell’inizio di questo nuovo secolo e millennio.
Siamo arrivati al settimo anniversario della sua dolorosa scomparsa e fervido rimane il ricordo grato e affettuoso dell’uomo complesso, anche contraddittorio, ma ricco di talenti e di una superiore morale, che fu come un ponte fra mondi diversi: il mondo remoto – quello sociale della sua infanzia barbaricina, della sua infanzia e adolescenza spesa nel lavoro materiale e duro delle cave di pietra orunesi e dei cantieri edili d’una Carbonia in boccio, della primissima giovinezza approdata, negli anni della guerra, nell’azienda-omnibus dei nobili nuoresi Guiso Gallisai (società di persone non ancora di capitali!) – ed il mondo nuovo dell’economia avanzata che egli, dal suo osservatorio privilegiato di bancario divenuto, nel tempo, banchiere (nel board di alta direzione del Banco di Napoli allora multinazionale del credito e della finanza), intravede coinvolgente per taluni aspetti anche la Sardegna. La sua e la nostra Sardegna d’un tempo ormai in scavalco appunto di secolo e di millennio.
Cosa scrivere di lui quest’anno, come riproporlo alla considerazione dei tanti che l’hanno conosciuto e magari anche frequentato e di quegli altrettanti, magari delle giovani generazioni, che invece di lui hanno soltanto una memoria vaga legata ai titoli, soltanto ai titoli, della sua bibliografia passata magari in rapidità? Ho pensato sarebbe stato bene ricostruire la sua scheda appunto bibliografica e marcare le diverse tappe delle sue ristampe, con il passaggio dei titoli da un editore all’altro.
E qui bisogna dire la verità: per quanto riconosciuto anche dalla critica, non soltanto dal pubblico più affezionato o attento alle sue produzioni narrative, egli non ebbe la fortuna che meritava né nell’Isola né, tanto meno, fuori dell’Isola. Ne era consapevole e forse segretamente rammaricato, ma non imputava ad alcuno né lentezze né parzialità… I suoi libri – meglio quelli dei primi anni ’80 (Il ponte di Marreri, Erthole e Santi di creta) – ebbero discreta diffusione soltanto quando sostenuti da alcune indovinate recensioni uscite sulla stampa e le televisioni nonché, in un caso e paradossalmente, da improvvide vicende giudiziarie. Gli editori sardi, nei diversi momenti, furono con lui complessivamente avari, così come con altri autori dell’Isola, non riuscendo a combinare, magari con il mondo associativo, quegli “eventi” culturali che avrebbero potuto avere una funzione moltiplicatrice nella pubblica illustrazione di tanta fatica creativa e dunque anche nella ricezione di contenuti letterari assolutamente originali.
Zizi è rimasto creditore, è rimasto nostro creditore, e noi dovremo – trovando i giusti modi – saldare quel suo credito. Dovremo intanto saperlo ricollocare nel quadro dei romanzieri sardi del suo tempo, ben utilizzando anche le piste interpretative del suo lavoro, della sua fertilità inventiva cioè, offerteci negli anni da critici importanti come Mario Ciusa Romagna, Giuseppe Marci, Leandro Muoni, Giovanni Mameli, Antonio Romagnino, Leonardo Sole e altri ancora. Sarà compito dei competenti, magari anche dei professori di lettere delle scuole medie!... a noi e a me toccherà altro, toccherà di ripresentare, con schede di facile abbordo, il tanto prodotto, fra racconti e romanzi, versi poetici e articoli o saggi brevi di costume.
Non tutto potrà essere esitato subito, ma conto di riuscirci, con qualche minima compiutezza, in quattro o cinque tempi.
Non considererò, in questo mio ritorno all’opera ziziana, gli ultimi cinque titoli: Le dolenti cure, 2009; La voce dell’anima. Frammenti di un discorso amoroso ricomposti da Bachisio Zizi, 2009; Dialoghi a distanza, 2010; Un’isola nel mondo, 2011; Fughe e ritorni, 2011. Essi, tutti autoprodotti, rimontano a una stagione di vita dell’autore che ispirava in lui motivi del tutto speciali, sui quali mi piacerebbe potermi diffondere in altra prossima circostanza, non adesso.
Lo scrittore aveva superato abbondantemente allora i suoi ottant’anni, ed erano anni che sentiva tutti. Al carico loro proprio s’erano aggiunti altri pesi – i pesi dell’anima per la lunga e martirizzante malattia e poi la morte (nel gennaio 2004) della moglie carissima Maria Francesca Baldessari – una professoressa di lettere di squisita sensibilità e mossa sempre da spirito sociale e finemente democratico –, e per la malattia e poi la morte in quel di Biella (nell’autunno 2008) della figlia, talentuosissima e sfortunata, Antonietta – musicista e critica musicale –, questi pesi e altri ancora faticosi, troppo faticosi da portare.
Potrei dire – ma sarebbe un esprimersi improprio – che l’arco inventivo di Bachisio Zizi s’era manifestato, concludendosi, essenzialmente in tre stagioni (il quarto sarebbe stato quello post 2009 del quale ho sopra accennato).
La prima fase prende il lustro (arrotondato) 1968-1974 e comprende il racconto Marco e il banditismo, il romanzo autobiografico (puntato sulla sua infanzia e adolescenza) Il filo della pietra, ed il romanzo d’ambiente Greggi d’ira, usciti rispettivamente nel 1968, nel 1971 e nel 1974, tutti e tre pubblicati dalla Editrice Sarda Fossataro.
La seconda include i lavori che coprono gli anni ’80: i tre romanzi pubblicati da La Voce Sarda editrice, vale a dire il ponte di marreri (tutto al minuscolo sulla copertina della prima edizione), Erthole e Santi di creta, rispettivamente del 1981, 1984 e 1987. Ad essi aggiungerei Mas complicado, raccolta di racconti pubblicata da i girasoli (altra minuscola, con composizione IBM della Passamonti) nel 1988.
La terza, forse più estesa temporalmente, andando dal 1994 al 2002, ma soprattutto miscelata ad una intensa attività pubblicistica come collaboratore di prestigio sia de L’Unione Sarda che de La Nuova Sardegna, comprende un maggior numero di titoli: il cammino spezzato (insiste Zizi a preferire i titoli al minuscolo) è del 1994, Cantore in malas è del 1997, Lettere da Orune è del 1999, da riva a riva è del 2001, I supplici è del 2002. Ad unire questi titoli, con l’eccezione di Lettere da Orune, che è vanto dei cataloghi de Il Maestrale, è l’edizione Cosarda, vale a dire di una cooperativa (“sarda autori”) sostenuta per certo da Nicola Grauso, al tempo patron de L’Unione Sarda oltre che di Videolina.
Come cercherò di meglio dettagliare più oltre, diversi di questi titoli – e tanto più quelli di più remota pubblicazione – han trovato possibilità di ristampa da parte di editori diversi: così è di Il filo della pietra, di Il ponte di Marreri e di Erthole, rilanciati (ma soltanto commercialmente) da Ilisso, ancora di Il ponte di Marreri ed Erthole voluti dalla romana Robin BdV, di Greggi d’ira entrato nei cataloghi di Il Maestrale, di il cammino spezzato che con il nuovo titolo Il brusio dei frangivento viene accolto nella “Biblioteca della Nuova Sardegna”.
A tanto, come ho già accennato, andrebbero aggiunte – quando interessi più compiutamente dettagliare l’arte e l’impegno dello scrittore – alcune decine di articoli usciti su entrambi i quotidiani sardi, che meriterebbero una ripresa ordinata in volume che entrambe le testate ben potrebbero realizzare ed offrire ai loro lettori. Condizionali, sempre condizionali… e si vorrebbe fossero indicativi!
Esperimento Cosarda
Un breve indugio vorrei permettermi sulle attività della Cosarda, la cooperativa (in quanto a forma societaria) rientrante nella holding, poi fondazione de L’Unione Sarda di Nicola Grauso (oggetto anche di contestazione da parte di alcuni parlamentari che, all’esordio politico dell’editore, nel 1997, presentarono una interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro del lavoro circa finanziamenti e compatibilità statutarie della stessa).
Inventata da Bachisio Zizi come strumento promozionale dei talenti isolani, tanto più sui versanti poetico-letterari e pittorici, la Cosarda si distinse nei primi anni ’90 per l’organizzazione di un Festival delle Arti, che ebbe, dal 1991 e almeno per un triennio, ripetute edizioni, valendosi anche di location di prim’ordine, quale fu ad esempio la Cittadella dei musei. E dunque ecco mostre collettive di pittura (presenti artisti come Liberati, Dessì, ecc.) e premi letterari poi conclusi con la pubblicazione delle opere vincitrici (vedi Pili, con l’AMD). Numerose anche le altre produzioni, cataloghi inclusi - come Argenti e Argentieri del Regno di Sardegna, 1994, e Gavino Sanna catalogo della mostra, 1994, e La Polonia e la sua cultura viste attraverso la storia dei manifesti 1946-1993 - e il "saggio poetico" di Giovanni Dettori Lunga ancora la notte, 2001, o la prosa di Milena Agus refluita in Le donne raccontano, 1994...
E’ in questo stesso contesto che, a conclusione della sua terza edizione, venne editato il libro Venti Racconti, prefato da Zizi, con una selezione dei migliori lavori depositati dai 90 partecipanti.
Molto articolata la nota introduttiva al volume da parte del presidente/scrittore, ma qui più di tutto mi pare importante ed interessante soffermarmi sulla quarta parte perché essa, in fondo, parla di se stesso. Eccola:
Gli autori dei racconti, per nascita o per altri legami ugualmente profondi, hanno tutti un forte radicamento in Sardegna. C’è da domandarsi attraverso quali mediazioni si rispecchi la Sardegna o la sardità nei singoli testi. L'esperienza di vita e l'attività professionale colloca i nostri autori su un orizzonte culturale molto ampio, aperto comunque alle grandi correnti di pensiero del nostro tempo. Nei racconti, tuttavia, un aggancio con la Sardegna c'è sempre, anche se a volte è appena percepibile. A parte il paesaggio, che in alcuni testi diventa il vero protagonista della narrazione, riconducono alla Sardegna le forme espressive e il sentimento del tempo, che non riguarda tanto i ritmi narrativi, quanto quella concezione originale od originaria che porta a sentire il tempo come stratificazione di eventi. Nello spazio storico della lunga durata tutti i percorsi sono possibili, in avanti o retrocedendo, verso il basso o verso l'alto. I nostri autori, chi più chi meno, vivono in un eterno presente, una sorta di atemporalità che induce a leggere il libro come una pluralità di interpretazioni dell'unico fatto che è la vita.
Ciò che più interessa in questa sede sono i modelli linguistici cui fanno ricorso i nostri autori per raccontare le loro storie. Elemento comune a tutti è il bilinguismo, con accentuazioni varie in cui a volte prevale il sardo, soprattutto nei dialoghi (Gli amici), a volte l'italiano, che nei testi più colti (La penna, Il naso vergine, Ceraunavolta, Dieci giorni) sembra non conservare traccia della lingua delle madri. Eppure anche quando il discorso raggiunge gradi estremi di astrazione, il sardo compare, se non come calco di scrittura, come lievito dell'invenzione.
Non c'è racconto che non sia pervaso da quel sentimento di appartenenza, alla comunità sarda, intessuto di ragioni e irragioni, con il mito e il sacro che diventano un inesauribile serbatoio di senso. Il bilinguismo non è solo un processo di decifrazione e di risalita dal segno al significato, ma anche e soprattutto fusione di orizzonti in cui il mondo si ricostituisce continuamente.
I patiti delle classificazioni e delle graduatorie potrebbero essere tentati di costruire gerarchie di valori, operazione legittima, ma che non conduce a nessun risultato significativo. Anche se le quantità sono variamente distribuite, ogni racconto porta il suo miele. A volte basta un solo passaggio felice a dare respiro all'intero testo. Gli autori riescono a coinvolgere il lettore nei modi più disparati: il richiamo può venire dall'originalità o dalla stravaganza del tema, dal ritmo narrativo, dalla compiutezza dei personaggi, dalla spontaneità della scrittura.

Dediche e timidezze
Delle prime tre opere pubblicate fra il 1968 ed il 1974, soltanto il secondo porta una dedica: «A Giovanni, mio figlio». E questa circostanza meriterà d’essere rilevata per sé. A dispetto della sua posizione di… potere, come direttore di banca ammesso ai cenacoli – può dirsi? – più esclusivi e così titolato a funzioni di protagonista della scena, Bachisio Zizi fu riservato e misurato, anzi misuratissimo in ogni possibile espansione chiamala affettiva, anche nel privato non soltanto nel pubblico: egli fu la timidezza fatta persona e fu, insieme, la volontà di dominarla quella timidezza che, altrimenti, avrebbe rischiato di estraniato dal concerto attorno a lui. Per questo non si negò mai alle interviste né per il giornalismo scritto né per quello televisivo, ma preparò ogni minimo dettaglio di quegli incontri, di quelle conversazioni, per questo fu protagonista (contro l’indole ma per dovere) sempre e ovunque fosse presente.
Franca Ferraris Cornaglia – squisita donna di lettere, amica sua e amica mia – si rivelò bravissima quella volta che volle fotografare la situazione e quel fare da prim’attore (controvoglia) con i suoi versi in vernacolo cagliaritano (titolo “Il cumbidus de Direzioni”) poi consegnati alla raccolta Su passarissu che, prefata da Mario Ciusa Romagna, sarebbe uscita nel 1985. Con ironia leggera ed educata, affettuosa anzi, quella disponibilità colloquiale, sorridente e loquace del direttore “convocato” alla cena borghese con altri colleghi direttori tutti accompagnati da mogli di complemento – lui è l’eccezione – viene riportata come in… controbracciata, a far figura sottraendosi alle banalità ma insieme, rispettoso del copione, non arrampicandosi in nessuna alta speculazione saputella…
Aneddu in didu,
prendas in zugu,
bistiri bonu postu in funzioni,
mancai sbuffendi e murrungendi
bandu ais cumbidus de Direzioni.
Bellus signoris,
tott'elegantis,
beni bistius
che figurinus,
incorbattaus e lucidaus,
è finzas bellu a dus castiai,
nudda de nai!
E s'incumenzad a chistionai:
«S'intendi' beni, cara Signora?
Teni' problemas de serbidora?
Cand'è arribàda de Cuntinenti?
S'agatta' beni in cust'ambienti?»
Deu chi m'intendu (cun arrespettu)
giai scuncordàda sa tramuntana
prim"e bessiri,
mi xittu e castiu
tottu sa genti apposentàda
ma chi no arriri.
Giai po tres bortas cust'è suzzediu:
dogna signori è meda seriu,
finzas chi is tassas in sa cumpangia
movint is barras e s'allirghia.
Ma ci nd'est unu chi m'ha colpiu,
allirgu sempri che unu pippiu,
cun d'una bella maner’e fai
ch'è unu prexeri a d'ascurtai.
Poita ad essi' chi è sempri allirgu
prim’e pappai, prim’e buffai?
Deu cun is rimas provu a du nai;
«E chi ndi benidi senz’e mulleri,
beni stìmàda, beni stuggiàda
forsis asutta «Pont’e Marreri».
Dicevo delle dediche che sono speciali, quasi impudiche, esternazioni d’amore. Quante e quali appaiono nei libri di Bachisio Zizi? Ne ho contato due soltanto, oltre quella al figlio Giovanni ne Il filo della pietra (ovviamente confermata nell’edizione Ilisso): «A Mario Ciusa Romagna, ripensando al paese-mondo, crocevia della storia» in Erthole, così confermata nella riedizione Robin (2001) e caduta però in quella Ilisso (2003) arricchitasi invece di una nota introduttiva di Sandro Maxia; «A Maria, luce della mia anima» in Santi di creta: così alla donna che fu compagna della sua vita e già in gioventù sua collega, pur con altri ruoli, nell’impero nuorese dei Guiso Gallisai (e Lostia ecc.), quell’impero di cui avrebbe trattato nelle pagine del suo romanzo tanto bello quanto incompreso e sfortunato.
Marco e il banditismo
Articolato in dodici capitoli, Marco e il banditismo è accompagnato da una brevissima nota introduttiva: La cornice dentro la quale si svolge il racconto è vera, ed è vera anche l’angoscia che da lungo tempo opprime le popolazioni dell’Isola. I personaggi, pur appartenendo al mondo della fantasia, sono stati ricostruiti tenendo presenti le virtù e le debolezze dei Sardi.

Nel risvolto di copertina è scritto: Marco è la voce della ribellione ai falsi miti, al conformismo, alla prepotenza ed al prepotere. La sua appassionata ricerca di una soluzione al problema trova valido appoggio nell’impegno di un parroco e nell’entusiasmo di una ragazza. Il “banditismo” è l’espressione di una società stravolta in cui, all’avvilimento di chi vive ai margini della civiltà, invocando a torme i banditi, fa eco la solitudine disperata dei pastori, la paura dei giovani inviati fra le sterpate del Supramonte, l’agonia degli studenti impegnati a dare morte e a morire.
Ricorderò che il 1968 – l’anno di uscita del libro cioè (e nella grande scena del mondo l’anno della contestazione giovanile, dell’escalation della guerra vietnamita con i bombardamenti americani sul nord e della protesta nelle piazze d’America e d’Europa) – coincide, nel privato familiare e professionale dello scrittore, con il suo trasferimento da Nuoro a Cagliari: la promozione bancaria (al grado di vice direttore) lo porta alla maggior sede del capoluogo regionale con le funzioni di settorista. Presto scalerà ancora, sempre per merito indiscusso.
L’anno coincide anche con un altro scritto – questa volta poetico – di Zizi, pubblicato su Frontiera, il mensile fondato e diretto da Remo Branca e particolarmente aperto alle questioni culturali e sociali del Nuorese. Sul numero di ottobre egli firma i versi che rimandano alla rivolta dei pastori (erano scesi a Cagliari in duemila nel novembre 1967 e rivendicavano la riforma delle terre, negli anni in cui era ancora in rodaggio la politica della Rinascita e s’alzava, da parte della Regione autonoma, la bandiera contestativa dello Stato centrale):

Scesero dai monti i miei pastori / con uno straccio di bandiera in pugno / e tanta amarezza nel cuore;
lasciarono le greggi / vaganti per tanche disperate, / spinte da secoli di fame
e sfilarono / per strade toccate dal benessere / avvolti nell’indifferenza / di gente sazia, immemore / della fame dei padri.
Per vincere i pudori / andarono tutti in gruppo / fischiando sull’arco delle dita:
ai soli cocenti del Campidano / le stinte vesti fumavano / di sudori antichi e nuovi.
Poi sostaron nella piazza / i miei pastori / perché i sapienti vollero spiegare / ciò ch’è chiaro / come l’acqua delle sorgenti;
e furono fiumi di parole / perché anche altri / vollero precisare / ciò ch’è espresso dalle rughe / scavate sulle fronti / bruciate dai venti.
Trafitti dai bagliori di marmi sfacciati / attesero ancora i “barbari”, / davanti a grattacieli spaventosi / dove i problemi roteano in silenzio.
Per rendere più alta la protesta, / fischiarono a lungo i miei pastori, / ma ebbero solo parole, / dette con tono d’amico / per seminare dubbi / e confondere coscienze;
fischiarono più forte / e i sibili squarciarono i cieli, / ma non scalfirono le rocce / dell’indifferenza.
A sera tornarono sui monti / con la bandiera raccolta sotto il braccio / e trovaron l’antica solitudine;
per non sentirsi soli / chiamaron le greggi / stanche d’impazzire fra gli sterpi / cercando l’erba che non crescerà.
Non avevan memoria di lacrime /i pastori / perché l’arsura aveva asciugato / anche le fonti del pianto: / sfogarono il dolore cantando, / seduti sulla pietà dei sassi, / e fu un canto lungo e triste / come un lamento.
Per quanto ne sappia, il racconto raccolse, sulla stampa sarda, cinque recensioni: su La Nuova Sardegna da Domenico B. Runedda (“Marco e il banditismo, un’opera destinata a sollevare molto scalpore”), Mario Delogu (“Marco e il banditismo: un romanzo sardo”), Diodato Pigliaru (“La mala pianta di ogni malessere: Marco e il banditismo”), su L’Unione Sarda da Gianni Filippini (“Un racconto di B. Zizi in un volume di Fossataro”), su Frontiera da… Zaccheo (“Questa volta si parla di B. Zizi e di Marco e il banditismo”). Non riporto, né per Marco e il banditismo né per i titoli successivi, il riferimento di data delle recensioni, cui ho provveduto in altra rassegna.
Il filo della pietra
Uscì nel 1971 Il filo della pietra in venticinque capitoli, e l’esergo era brechtiano: Voi che sarete emersi dai gorghi / dove fummo travolti / pensate / quando parlare delle nostre debolezze / anche ai tempi bui / cui voi siete scampati (“A coloro che verranno”, 1938).

Mi permetto qui una parentesi personale. Furono rivelatori per me i versi di “La lode del dubbio” dello stesso Brecht che Bachisio Zizi, con il quale il rapporto personale e di confidenza – e anche di confidenza letteraria – era iniziato nell’estate 1976, mi fece conoscere una volta, con tutta spontaneità e bucando la mia ignoranza e la mia presunzione giovanile. Brecht era sì nel mio orizzonte da qualche anno, per i richiami di alcuni testi teatrali in scena nell’Isola, magari di autori nostri come Romano Ruju e dei quali mi ero interessato per il palcoscenico e per certe suggestioni che mi aveva fornito Francesco Masala il professore, Cicito tanto stimato e amato e generoso. Però quello alla poetica del drammaturgo tedesco era stato un accostamento che non avevo saputo allargare e approfondire quanto sarebbe stato necessario allora, quand’ero sui vent’anni e troppo acerbo. Zizi, intellettuale postmarxista (così avrebbe accettato di farsi definire) mi aperse dunque, anni dopo, una strada, un’autostrada per le riflessioni sull’umano così nel pubblico come nel privato, e quanto nel privato! per l’emancipazione possibile da ogni stretto dogmatismo o dottrinarismo. Mi avrebbero accompagnato ed ispirato, quei versi brechtiani, in mille circostanze della vita…
Scritto già da alcuni anni, Il filo della pietra – questo riferisce l’editore nel risvolto di copertina - racconta la storia di Nineddu, un ragazzo che sogna di spaccare le montagne, come suo padre, di diventare uno scalpellino famoso e si dispera perché non riesce a trovare il filo della pietra.
La cava con i suoi silenzi, la sua poesia, i suoi uomini che picchiano come disperati sui massi, e il paese, arroccato su un’altura battuta dai venti, con la gente che minaccia in silenzio e prega cantando, sembrano mondi invalicabili a Nineddu. Poi la guerra come rimedio alla disoccupazione e alla fame. Nineddu, sospinto dalle “grandi vicende”, lascia la cava e il paese e incontra altri luoghi e altra gente: si guarda intorno e si dispera ancora perché non riesce a cogliere il nesso delle cose. Suo madre non potrà insegnargli il mestiere di scalpellino, ma Nineddu apprenderà da solo il “mestiere di vivere”.
Come i figli “di buona famiglia”, lui povero, riuscirà a varcare la soglia della scuola e apprenderà tante nozioni, ma gl’insegnamenti che si porterà dentro saranno quelli appresi nella cava, fra i tagliapietra incattiviti dalla miseria, nel pastificio, sotto il peso delle casse e nella federazione dei faci, davanti alle stravaganze dei gerarchi.
Il desiderio di sapere lo scuote come una febbre e si tuffa sui libri, ma ne rimane quasi sgomento perché le sue inquietudini aumentano e quando vuole spingere lo sguardo oltre i tetti delle casupole scopre che i monti limitano ancora gli orizzonti.
Nel 2012 il libro viene riproposto, nella collana “Scrittori di Sardegna”, da Ilisso (che, come detto, ristamperà anche Il ponte di Marreri ed Erthole) e questa è la sintesi della nuova quarta di copertina:
Cava di Cocorrovile, Orune, uomini che picchiano con rabbia sui massi, il paese arroccato e battuto dai venti, la gente che impreca in silenzio, la madre, i fratelli: sono i mondi di Nineddu, il ragazzo che sognava di diventare un apprezzato scalpellino. Poi la guerra, la fame, la partenza per la miniera di Carbonia, i nuovi compagni che alternano umanità e crudeltà nei confronti di quel ragazzo che si dispera perché non riesce a trovare il filo della pietra. Nineddu torna al paese, ma il padre, ferito nella guerra di Spagna, non potrà più guidarlo: da solo dovrà imparare il mestiere di vivere. Andrà a scuola, ma gli insegnamenti che si porterà dentro saranno quelli conosciuti fra i tagliatori di pietra o, in seguito, nel mulino-pastificio, a Nuoro, dove lavorerà come imballatore di spaghetti. Nomi e volti di una umanità disfatta dalla fatica si affollano nel racconto. E ancora un duro magistero, nella federazione dei fasci, davanti alle prepotenze lunatiche dei gerarchi.
Bella rispondenza con il contenuto del romanzo ha la copertina scelta d’intesa fra l’autore e l’editore: una foto di Costantino Nivola che, a Tempio Pausania, riprende la lavorazione dei conci in granito destinati alla pavimentazione della nuorese piazza Sebastiano Satta, a Santu Predu, non distante dalle altre case note, quella della Deledda o del Ciusa...
Intensa la nota introduttiva proposta da Bastiana Madau, già bibliotecaria di alta specializzazione ed editor della Ilisso, che la anticipa in un articolo sulla pagina culturale de La Nuova Sardegna del 10 maggio 2012. Eccola:
«Ma i figli andavano a piedi, e in quell’atmosfera rarefatta, in quella visione orrida e dolce, in quel silenzio infinito ricevevano inconsapevoli il tocco della poesia». (Salvatore Satta, Il giorno del giudizio).
Sono tanti i narratori sardi, a partire da Grazia Deledda, che definiscono come sublime il paesaggio dell'isola, sublime come solo sa esserlo il «regno della pietra» (così la Deledda in Tentazioni). Pietra, perda, preda: è un'immagine, una evocazione a cui essi sembrano tradizionalmente e intimamente legati. Di pietra è l'isola che li ha generati, da cui derivano i suoi artifici più maestosi - dai nuraghi ai menhir - e da cui provengono la miriade delle opere che hanno segnato la storia della sua letteratura. E la natura taciturna e dura della pietra sembra essersi identificata nei personaggi che le popolano, i cui volti spesso, non a caso, sembrano essere stati scolpiti. Ma se per alcuni autori la pietra è inscritta nel mito alimentato dalle magnifiche tracce dell'artificio umano nel suolo della terra sarda, e se per altri, più recentemente, assurge a metafora che da esterna si fa interna al corpo per farsi dolore, patologia, Zizi la evoca e la racconta in senso proprio, in tutta la sua pesantezza materica e la sua durezza. Alle caratteristiche fisiche della materia allude metonimicamente, già dal titolo, Il filo della pietra, pubblicato per la prima volta nel 1972 [recte: 1971] e qui riedito con una formula assolutamente nuova, voluta, dall’Autore, che lo ha riccamente annotato rivolgendosi alle giovani generazioni, indicando quei «nessi» che impediscono ai «ricordi di ragazzo» di diventare «un'ossessione» (come ebbe già a scrivere ne Il ponte di Marreri, 1984).
La pietra qui è lavoro, fatica, massa bruta e cava patita dal padre di Nineddu, il protagonista della storia, e dagli altri spaccapietre che accendono «scintille su quarzi di granito», aprendo «montagne di buio», per conquistare il senso del proprio lavoro («Compare Franzì, guardate come sono belle le pietre spaccate con rabbia»). Ma nulla è lasciato al caso in Zizi, e già nel titolo colpisce che la parola «pietra» sia preceduta da un'altra che evoca una natura totalmente diversa: «il filo». Il filo della pietra. Ha dunque la pietra un filo? Può essere filata? Tessuta? Trasformata in filigrana? Raccontata? Ricorda il filo d'argento delle janas tessitrici, i muri di filo di Maria Lai. La pietra moderna, come dire la narrativa moderna, per Bachisio Zizi, deve avere un filo, un nucleo di verità da cui dipanare il racconto, da subito, già da questo bellissimo romanzo di formazione, che dalle esperienze di vita - a partire dalla pietraia di Cocorrovile conosciuta e patita da bambino - saprà sempre ricavare una lezione che si tradurrà in spunto di poetica e narrazione anche in tutte le opere successive.
Così il libro racconta la storia di un ragazzo che sogna di spaccare le montagne, di diventare uno scalpellino bravo e apprezzato. Cocorrovile, vicino a Sant'Efisio, a 7 chilometri da Orune, tutti i giorni a piedi, andata e ritorno, cava, silenzi ancestrali, «orrida poesia», uomini che picchiano come disperati sui massi, e il paese, arroccato su una altura battuta dai venti, con la gente che impreca in silenzio e prega cantando, la madre che lo ama di un amore assoluto, i fratelli: sono i mondi di Nineddu. Poi la guerra come rimedio alla disoccupazione e alla fame. Nineddu lascia la cava di Orune, il suo paese, la famiglia, e incontra altri luoghi e miniere: Carbonia, altri uomini del fare, che alternano umanità e crudele disumanità nei confronti di quel ragazzo che scruta la realtà con occhi colmi di stupore. Nineddu si guarda intorno e si dispera perché non riesce a trovare il nesso delle cose, il filo della pietra. Torna al paese, ma suo padre, per una ferita riportata nella guerra di Spagna, dove si era arruolato per fame, non potrà più insegnargli il mestiere di scalpellino. Nineddu capisce finalmente che da solo dovrà apprendere il mestiere. Come i figli delle famiglie benestanti - che all'epoca erano gli unici a potersi concedere il lusso degli studi -, Nineddu, poverissimo, riuscirà ad andare a scuola e apprenderà tanti dati, ma gli insegnamenti che si porterà dentro saranno ancora quelli appresi fra i tagliatori di pietra disumanizzati dalla miseria, o, in seguito, nel mulino-pastificio, a Nuoro, deve andrà a lavorare come imballatore di spaghetti. Nomi, volti e colpi di una umanità dolente, disfatta dalla fatica, si affollano anche in questo punto del racconto. Ancora il duro magistero di apprendimento del mestiere di vivere nella federazione dei fasci, davanti alle prepotenze lunatiche dei gerarchi.
Il desiderio di conoscere scuote come una febbre insaziabile e il protagonista si tuffa sui libri, ma ne rimane quasi sgomento perché le sue inquietudini aumentano, si fa pressante la necessità di comprendere il senso delle esperienze. E quando, in epilogo, egli spinge lo sguardo oltre i tetti delle casupole di Nuoro, vede una realtà immobile, fatta di «colli riarsi» e «monti alti», che ancora limita gli orizzonti a cui il ragazzo aspira.

Diversamente che nella prima edizione, stavolta è lo stesso autore a dettare una premessa al suo romanzo. E’ importante: dalla prima uscita nel 1971 alla data della ristampa sono trascorsi più di quarant’anni, è passata la pienezza della sua maturità, domina ormai l’età anziana, la vecchiaia anzi di cui ha scritto egli stesso in un recente articolo su L’Unione Sarda. Gli stadi della vita hanno seminato per i successivi e ogni volta tutto è rivisto con occhi diversi, altri, capaci di esplorazione assai più che in precedenza. Ed ecco dunque Zizi ripensare se stesso protagonista di vicende lontane, ma anche ripensare se stesso narratore di quelle vicende una mezza vita prima…
Ma voglio aggiungere: anche se quello stacco temporale è minore di quello calcolato – ché Zizi (a meno che non si sia tratto d’un banale errore soltanto materiale) scrive di trentadue e non di quarantadue anni – la conclusione non cambia. Lo stacco prende comunque una metà di vita e autorizza, focalizzandoci sui due poli, a vedere l’autore rifarsi autore del suo libro ripensato, rivissuto integralmente con mente diversa, necessariamente diversa… E di più ancora, e fornendo la prova di questo: le 179 note – una quantità obiettivamente enorme, e tanto enorme quanto preziosa – che Zizi ha inteso aggiungere al libro in ristampa, marcano la rilettura che l’autore stesso deve compiere, e compie, delle sue pagine.
Le inserisce, quelle note, forse per favorire una lettura più agevole e utile ad un pubblico (magari di ragazzi e giovani, anzi soprattutto di loro studenti) fattosi intanto più estraneo alla scena dei luoghi e dei tempi raccontati, ma le inserisce forse anche per se stesso, come si trattasse di quelle pellicole andate a male e scartate ed oggi invece riscoperte nella loro funzione descrittiva. Sì, esse marcano anche la rilettura che l’autore stesso deve compiere, e compie, delle sue pagine: perché allora rivede se stesso nelle diverse età – dieci anni, dodici, e quindici, e venti – e rivede i coprotagonisti, suo padre e gli spaccapietre, i manovali fattisi sulcitani e gli operai molitori del Nuorese, i graduati, quelli sgradevoli e quelli no, dell’autoreferenzialità fascista, i compagni della scuola recuperata nell'anno del referendum. Così nella sequenza di due decenni più grigi che colorati… ed è inevitabilmente teso, lui, lo scrittore, al riascolto di tutte le anime di quel popolo che un destino indecifrabile ha costretto al lavoro, a identificare la vita con la fatica.
Bisogna anche dirlo: le 179 note ziziane sono un libro nel libro e meriterebbero un approccio tutto speciale, direi storico, d’osservatore non di partecipante (o di partecipante emotivo come invece si sarebbe della narrazione letteraria). Sono, quelle note, come le tappe di un percorso biografico che l’autore offre di sé minore, di sé bambino e ragazzo e giovanissimo… Un percorso che ovviamente include i luoghi fisici da cui la sua avventura di vita prende le mosse ed in cui si svolge fra ansie e conoscenze progressive.
Quella che si viveva a O., come negli altri paesi di Barbagia, era vita intensificata: a dieci anni si era già uomini, gravati dal peso di responsabilità troppo dure per quella acerba età. Ma la fantasia resiste a ogni coercizione e il ragazzo della cava insegue con l’immaginazione i giochi dell’infanzia perduta, innalzandosi dal corpo ridotto ad automa. Solo quando il padre gli mostra i buchi storti riesce a prendere consapevolezza di quella sospensione tra la necessità che lo inchioda alla pietra e i voli della fantasia…
In quest’intimo dialogo con la natura c’è l’apertura a un’altra conoscenza, che non è solo della mente. Quell’andare di roccia in roccia, staccando i polloni dai rovi, o ascoltando i silenzi di Cocorrovile è una forma alta di apprendimento i cui frutti sono affidati ai tempi lunghi…
La visita di leva veniva vissuta nel paese come un rito di iniziazione, che culminava con la sfida a s’istrumpa, tra i giovani di O. e i giovani di Bitti, sfida che coinvolgeva le due comunità. La sfida aveva i suoi eroi, le cui gesta si raccontavano con accenti epici…
Cantare per vincere la paura nel buio della notte, coprendosi di vergogna agli occhi di chi si fosse messo in ascolto, o sfidare in silenzio gli assalti del sangue? Questo era il dilemma. Di fronte alla tenebrosa incompiuta di Ziricheddu, il nostro protagonista tenta, e corre, quasi volesse fuggire dalla paura che lo attanaglia. Santino gli aveva detto che non sarebbe diventato uomo con “i peli nel cuore” e lui sembra rassegnato…
Nella casa dei nonni tutto si trasfigura agli occhi del ragazzo e tutto ha un sapore nuovo, compreso il pane d’orzo che non gli provoca più le ripulse della cava. Quella nonna in continuo movimento sembra dotata di poteri magici dando dignità e decoro alla casa e alle cose. Nessun lamento per le veglie davanti al forno del pane e per l’infermità del marito: anche il tacere ha la sua dignità…
In quel capovolgimento di geografie, la Spagna in luogo dell’Africa, si consuma il dramma della famiglia, con la madre che sconta in anticipo il suo lutto picchiandosi la testa con i pugni chiusi, e il figlio bambino che offre il suo sostegno con una promessa che pur nella sua ingenuità, riesce a sollevare la donna dal suo sconforto…
Il mercato nero, ossia lo smercio clandestino dei beni arraffati in modo illecito, compare sempre nei momenti di penuria, e a Nuoro, città di consumatori più che di produttori, le ristrettezze del dopoguerra sono più dure che altrove. Attraverso il mercato nero avviene solitamente quella ch’è stata definita “circolazione delle aristocrazie” per le promozioni sociali che si accompagnano all’accumulazione illecita delle nuove ricchezze…
La parsimonia con cui la madre ha amministrato le indennità dovute per il “volontariato” del marito ha permesso i risparmi che ora vengono destinati per sfamare la famiglia. Non ci sono fatti illeciti, né circolazione di aristocrazie, soltanto le rinunce del “prima” per fronteggiare i bisogni del “dopo”…
Le amare riflessioni del protagonista sono il segno della sua maturazione. Tuttavia, nonostante si maceri sui libri, leggendo le vicende degli uomini magnanimi che fanno la storia, non riesce a dare una collocazione a quanti hanno popolato le sue esperienze. E’ un altro mondo quello che lui ha attraversato, il mondo degli esclusi, dal quale sembra non si possa evadere…
Il tentativo di bruciare le tappe della carriera scolastica, troppo lenta di fronte al bisogno indefinito di conoscere, è l’unico rimedio che gli si offre nel mondo degli esclusi. Il vero scopo del suo azzardo è placare le inquietudini e i furori che non conducono a niente. Non ci sono doni, né donatori, il suo destino è tutto nelle sue mani e lui crede di sciogliere i nodi che lo stringono sprofondandosi in un impegno che non lascia respiro. L’orto è lo scenario in cui si svolge questa solitaria lotta; il padre e la madre, che teneramente scrutano da lontano il suo fare, sembrano angeli scesi da chissà quale cielo, per proteggere il figlio dalle “cavolaie”…
Sa che non è tempo di gioire, issato sulle spalle dei compagni cerca con sguardo avido le aperture promesse dai testi dei suoi studi, ma non intravede alcun varco, anzi l’orizzonte è più che mai chiuso, stretto tra le arsure dei monti che sembrano invalicabili. Le scarne nozioni dei libri non bastano più, occorrono altri saperi, saperi immaginativi capaci di dare voce e senso a tutto, anche all’inventiva paterna.
Una guida alla lettura efficace e anche un suggerimento di ricerca nuova per i lettori occasioni ma soprattutto per quelli – s’è detto – che magari nelle scuole, adolescenti, prendono in mano il libro e, forse in gruppo, lo leggono e lo… conquistano, esplorandolo pagina dopo pagina.
Ma non si limita a offrire questo nuovo supporto, questo accompagnamento alla lettura, Bachisio Zizi. In questa curatissima riedizione di Ilisso egli aggiunge una breve (e illuminante) premessa che val la pena di riprendere. (Osservo, incidentalmente e riprendendo un rilievo già sopra formulato, che l’autore parla di una distanza dalla prima edizione di trentadue anni, il che farebbe supporre – sempre che non si tratti di una banale svista o d’un errore materiale – che a tanto egli si sia dedicato nei primi anni del Duemila, e cioè un decennio prima della effettiva ristampa).
Occorre pur parlare delle ragioni che hanno condotto a riproporre Il filo della pietra, romanzo di trentadue anni fa, legato a vicende ancora più remote, che sembrano il flebile eco di mondi morti anche al ricordo. La "ristampa" certamente si inscrive in una dignitosa operazione editoriale, riconducibile al testo, che s'impone per scrittura e struttura, e al contesto di riferimento, colto nella sua dolente solitudine, dalla quale sembra non possa più uscire; e tuttavia, la motivazione di fondo della "proposta" ha qualcosa d'irrituale, se non altro per il tentativo di richiamare da quelle arcaiche lontananze voci, suoni e silenzi, evocati come soffi vivificatori di questo passaggio d'epoca che non riesce a ritrovare la "temperatura dell'anima".
C'è da chiedersi quale ascolto possa avere un romanzo come Il filo della pietra, in un mondo in cui tutti i rapporti sono stati sconvolti; è una domanda cruciale, alla quale si può rispondere solo tornando al testo del libro, che, partendo dalle cose, col suo linguaggio essenziale ed evocativo allo stesso tempo, conduce a riscoprire il ritmo della vita. Ma, nella drammatizzazione di scenari, personaggi e destini del racconto, tutto s'innalza dall'immediato e così, le vicende della cava, di Carbonia, del pastificio, della federazione dei fasci, della scuola, aprendosi al mondo creano legami di passioni e ragioni che superano le barriere dei tempo e dello spazio.
Il filo della pietra potrebbe definirsi un romanzo di formazione, incentrato sulle esperienze che portano a maturazione il protagonista principale, un "io" che diventa un "noi" convinto, fino a dare voce, se non grido, a un'intera comunità. C'è un altro elemento che concorre a meglio definire il romanzo, ed è il problema dell'identità, come riflesso delle travagliate esperienze del protagonista. Fare un bilancio di ciò che egli perde o guadagna nelle sue traversate non ha senso, ma i suoi approdi confermano che l'identità è pur sempre una conquista, un lavoro, secondo la visione di Locke.
E qui si pone un interrogativo ancora più cruciale, che riguarda la collocazione da dare al romanzo nei confronti della tradizione. Anche nei passaggi d'epoca segnati da forti cambiamenti il molto che si conserva del passato tende a saldarsi al nuovo acquistando rinnovata validità. Ma se ogni generazione, ogni momento storico pone al passato delle domande diverse, i figli dei nostri figli possono istituire con la tradizione lo stesso rapporto che aveva la generazione dei padri? Se l'assunto è fondato, si potrebbe parlare legittimamente di un libero appropriarsi della tradizione da parte del protagonista del libro, il quale, anche se penosamente, riesce a trovare punti di equilibrio fra il "dentro" e il "fuori".
In un mondo in cui tutto sembra dissolversi, dall'idea della casa come centro degli affetti, al culto dell'amicizia e alla cura delle cose, la lezione che sale dai fondali del tempo in cui le vicende del libro sono collocate, è l'esortazione all'impegno, alla perseveranza, al coraggio nell'affrontare il nuovo che la vita ci riserva ad ogni passo. Il rischio cui siamo esposti è proprio il dissolvimento di quello che di valido la tradizione ci ha tramandato, compresa la coesione che caratterizzava il mondo degli affetti cantato in questo libro esemplare, che riesce a dare un'anima a tutto.
Alla sua prima uscita, quasi due generazioni fa, Il filo della pietra non ebbe fortuna di lettori, le distrazioni dell'editore e l'inesperienza dell'autore ne limitarono la circolazione per cui si può dire che il testo rimase pressoché sconosciuto. Tuttavia, negli anni che seguirono la sua pubblicazione, il libro entrò nelle scuole di diversi centri della Sardegna, "chiamato" spontaneamente da docenti che lo adottarono come testo ausiliario di lettura. L'esperimento ebbe successo, soprattutto per l'entusiasmo che sollevò fra gli alunni.
E’ stato il ricordo di quell'iniziativa a suggerire di accompagnare il testo della ristampa con delle note che, senza nulla aggiungere alla compiutezza del libro, ne mettessero in evidenza i passaggi più interessanti. Le note, formulate con sobrietà, sono più che altro appunti a margine, che pur non avendo carattere sistematico, potrebbero costituire un utile ausilio alle libere letture degli eventuali scolari.
Neppure stavolta mancarono le recensioni sulla stampa regionale ma fu poca cosa rispetto a quanto ci si sarebbe attesi: su La Nuova Sardegna nella rubrica “La Sardegna in libreria” a cura di Aldo Cesaraccio, e – ma pure molto tardivo, addirittura del 1976!” - dall’immancabile (amico e compaesano divenuto preside di scuola) Diodato Pigliaru (“Il filo della pietra: per un romanzo di Bachisio Zizi”). Non risultano segnalazioni su L’Unione Sarda. Un richiamo a Il filo della pietra è in L’altra Letteratura. Scrittori sardi contemporanei di Cenzo Cau, che con una nota critica dello stesso curatore presenta uno stralcio del cap. II.
All’insegna di “Il filo della pietra” avvenne il 25 ottobre 2014, pochi mesi dopo la scomparsa dello scrittore, un convegno a lui dedicato, ad iniziativa dell’Amministrazione comunale e della Fondazione Enrico Berlinguer, ad Orune. Sul canale Youtube è la registrazione dell’evento.
Un appunto a margine, di natura puramente cronologica, vorrei fissarlo qui in conclusione. Nello stesso 1971 di il filo della pietra lo scrittore pubblicò una novella su Frontiera: titolo "sotto il segno della fecondità", storia d'una famiglia in boccio, quella di Paolo e Lucia... di una Lucia che si fa madrina delle creature d'altri ma non riesce lei a diventare madre e sente soffocare sopra di sé l'alito del giudizio cattivo della suocera... fino all'epilogo tragico.
Greggi d’ira
Certamente più maturo per la più sicura padronanza della scrittura è Greggi d’ira, un romanzo anche di… spessore materiale (276 pagine), articolato al suo interno in tre parti, ciascuna delle quali composta da 21, 20 e 18 paragrafi in sequenza.
Con epigrafe (o esergo che dir si voglia) stavolta di Alfonso Gatto: Il paese deserto ha stanza eterna / nel suo silenzio, vi tentenna un Dio. / Il grido è tanto alto che non s’ode, il volume presenta in copertina una scena pittorica di Tore Cau: un gruppo di pastori che si riscaldano attorno ad un fuoco.

Questa la sintesi del romanzo come presentata nel risvolto di copertina:
“Greggi d’ira” è una storia dolente, raccontata con accorata partecipazione. I protagonisti sono i pastori di Barbagia e le loro donne, colti in un momento qualsiasi della loro tormentata esistenza, anche se nel libro acquistano rilevanza persone, luoghi e fatti apparentemente lontani dal mondo barbaricino.
Le vicende di Pietro Chessa, povero pastore senza pecore, sradicato dalla sua terra con brutale violenza, in nome della giustizia, si confondono con le vicende di un’intera comunità che si disgrega a poco a poco, impotente e quasi rassegnata a quel lento morire di niente.
Nel paese, che nel libro non ha un nome, rientrano i carcerati rimessi in libertà dall’amnistia, gli emigrati cacciati dalle fabbriche, e i pastori fuggiti con le greggi dal continente: ma è tutto uno squallore e le file dei disoccupati che attendono, chiusi nel loro avvilimento, s’ingrossano. Dal domicilio coatto rientra anche Pietro Chessa, insofferente, irrequieto, cupo: sembra che si porti dentro il germe della ribellione.
La siccità dimezza le greggi e i pastori si disperano e seguono Pietro Chessa in una mesta sfilata di protesta a Cagliari. Poi lo sciopero, anche se non ci sono padroni che si possono indicare col dito, il blocco stradale, i tumulti, la collera repressa della gente, e gli esili e gli arresti. Così l’ordine viene ristabilito e nel paese scende un silenzio di morte.
L’esteso riferimento alla manifestazione di Cagliari sembra chiudere qui il ciclo narrativo apertosi cinque o sei anni prima con i versi usciti su Frontiera.
Nel 1974, quando cioè appare sui banchi della libreria Greggi d’ira, Bachisio Zizi è già condirettore della sede di Cagliari del Banco di Napoli, capogruppo d’una dozzina di filiali sparse sul territorio della intera provincia comprendente anche Oristano. Le ragioni professionali, come capo della produzione del raggruppamento fattosi ormai, proprio con il 1974, interprovinciale lo sottraggono agli impegni della scrittura, o forse soltanto a quelli della pubblicazione. Non mancano infatti segnali e confidenze che attestano come le accresciute responsabilità d’istituto esigano come una compensazione (certamente, adesso e per qualche tempo, riservata e anzi segreta) nelle arti del pensiero e dell’invenzione.

Passa dunque, è passata quasi… una vita quando, nel 1999, venticinque anni dopo dalla prima uscita, l’editrice nuorese Il Maestrale ristampa il romanzo affidando a Franco Cocco – poeta e scrittore in proprio – l’incarico, non facile, di premettere una nota critica ch’egli stesso titola “L'epico grido dei soliloqui pastorali”. Ecco il suo testo:
Rileggere dopo due decenni e mezzo questo epico grido di Bachisio Zizi, è (ri)sentire non so che dolente stupore, come di ferita che speravi finalmente richiusa sulla carne di una fiera e dolente comunità di pastori dell'antica Barbagia. Ma è, appunto, ferita che sanguina ancora: e chi pensa di non essere testimone di tanto promessa aurorale palingenesi della nostra Rinascita, è l'ancora scaltro Pilato che finge di credere tanti Sardi rapiti da un arcadico sogno di Terra Promessa. Speranza di chimere: en attendant Godot... Il fantasma di questo romanzo (edito nel 1974), dunque, irrompe sulla scena dell'ancora arcaico teatro pastorale sardo, come il convitato di pietra, proprio come l'ombra di Banquo a Macbeth.
Greggi d'ira è lirica metafora che offre al lettore, attento al lungo peregrinare della società sarda, il lamento corale di pastori colti dentro un secolare epos di miseria, per rifargli i conti di una persistente anomalia sarda che - detta con parole di Leandro Muoni - è «drammaticamente scissa tra integrazione e contestazione, tradizione e modernità».
Così, l'odissea di Pietro Chessa (pastore senza pecore, protagonista del libro) lancia ancora freddi bagliori dell'irredenta inferniade di quel dissepolto paese senza nome perché meglio risplenda come esemplare simbolo di tutte le dolenti Barbagie.
La ricerca di Zizi, in quanto sofferto lavoro di scrittore, è stata una travagliata discesa nelle viscere della realtà viva, nel ribollire di quel magma che è il rosso bulicame del sangue sparso tra la fanghiglia esistenziale: ardito sondaggio nel profondo, nel segreto della carnalità scritturale, la quale vive di una lingua italiana «petrosa» sgorgata dai granitici personaggi che hanno gole riarse dall'antica sete di silenzio solitudine malagiustizia: e quanto dolore, allora, nel cuore dello scrittore nel sapere che contro quel Cerbero della Storia, che «con tre gole caninamente latra», nessuno osa prendere il suo pugno di terra da gettare «dentro alle bramose canne». Nasce così un canto tanatologico, quasi di riscoperto pathos di tragedia greca.
Così, inevitabilmente, si ostina a esistere il paese di pastori di Zizi: paese fantasma di quasi visionaria tristezza propria delle cose tragicamente reali dove, però, vive il dono di una scrittura vigile che sa variare l'epica della miseria e dello sradicamento sociale e umano affinando la perizia del dettaglio lirico, così come appare nelle descrizioni (bellissime!) della piazza del Municipio, dove «i robusti olmi, tutti in fila, sembrano fantasmi su cavalli di tenebra»; e, ancora, in quell'evocare il cielo «pulito con tante stelle grandi come lune di maggio». E non è una trovata di letteraria fantasia, questo prodigare di gesti poetici da parte dell'autore, visto che l'ulisside Pietro del travagliato racconto è un abile compositore d'ottave orali, un dolcemente rusticano aedo che «canta i bambini».
Non può certo stupire se in Greggi d'ira lo sguardo dell'autore sardo non è puntato soltanto in profondità, dentro la petrosa carnalità degli umili pastori; ma è anche rivolto in alto; e, direi: tanto più in alto, quanto più egli è attento al calpestato fango della sua terra, dove si affatica quel disperso formicolare di uomini sorvegliati da un Dio sempre in agguato, pronto a ghermirli; e sorvegliati, essi sono, anche da una giustizia statuale quasi sempre ingiusta, dentro una terra espugnata dai "continentali", e recinta, a valle verso il mare, con filo spinato. E loro, impietriti negli ovili, «curvi, muti, soli: tronchi d'olivastro abbattuti dal fulmine». Ahi, statue di speranze incarbonite!
Questo filo spinato separa due mondi (e, anche, due civiltà): i padroni, non solo stranieri, che promettono benessere in forma di miracolo orlato di miraggio; e i pastori che, diffidando dell'interessata prodigalità padronale, non affrontano il rischio della nuova avventura della cooperativa; e, allo stesso tempo, temono l'evento che scandisca l'imminente diaspora. Temono l'ignoto. In questo oscillare di dubbi e speranze, il pendolo dell'angoscia minaccia di scandire l'ora delle decisioni, e così, l'incubo di lasciare l'ignoto l'amato l'antico rievoca la celebre metafora verghiana dell'ostrica strappata al suo habitat: e questo dolore di possibile abbandono punge come replicata condanna. E allora, anche l'antica e nobile usanza di chi «para perché è stato colpito dalla malasorte», impone al travagliato Pietro l'obbligo del rifiuto, civile forma di nuova balentia, questa. Questo libro entra nella letteratura di Sardegna come opera atipica, visto che ha avuto la capacità artistica, unita al coraggio, di far vivere la storia di un popolo, impastoiato da barbariche funi di mancata civiltà giuridica sociale politica religiosa e prossimo alla dispersione, cui soltanto «la catena delle pecore legava il corpo e l'anima». Uomini respinti, a torto, da altri "presunti" uomini; e, per giunta, consapevoli di essere «senza arte né parte, chi è nato pastore, pastore deve morire», dice Pietro, interpretando un pensiero corale. Uomini ritenuti civili che ripudiano fieri homines; e questi a ripetersi la triste litania: «Siamo come le bestie, noi, regoliamo il tempo col corso del sole e della luna o col mutare delle stagioni. Nelle fabbriche e nei cantieri, invece, si corre sui secondi. Mai al passo coi veri cristiani siamo noi, perciò non ci vogliono».
In questo pensoso libro non poteva (perché mai?) mancare una fugace sosta di "plazer": c'è una pagina linda che ha il sanguigno nitore dell'improvviso e impulsivo capriccio d'amore che sa dire tutto in quella danza della giovane Lidia quando, sopra il molle fieno odoroso, danza «col viso in fiamme»; e questo fuoco, preludio ad altra fiamma, farà esplodere, nelle vene di Pietro, lo stesso «impeto di quando domava le puledre». Davvero ci voleva il decoro di civiltà poetica di Zizi per farmi godere questa danza eterna di un Eros rusticano.
Ormai Zizi ha coscienza che il «cerchio del gregge» sta per infrangersi. L'amato Eden ha chiuso il suo dorato portale ad ogni accorato richiamo: fuori, con sembianze di orfico miraggio, o stazionano ricordi, o premono nostalgie, o folleggiano illusioni. Strappata la maschera alle chimere, ecco il tagliente volto del reale. Dice l'autore, quasi ammonendo: «Bisogna viverci in Sardegna, conoscere le cose, la gente, gli usi. La nostra lingua non si può imparare così, senza vedere, senza sentire, senza godere, senza soffrire». La nostra lingua... In un suo fresco e agile scritto ("I travagli di uno scrittore anomalo", del 1997), Zizi ci ricorda che Matte Blànco «Parla di bilogica, o logica delle grandi emozioni in cui la parte si confonde col tutto. I pastori della mia terra vivevano in uno stato di perenne tensione che li portava a quell'incontenibile traboccamento della parola. Ma la loro non è stata mai lingua di dialogo: nell'isolamento hanno potuto coltivare soltanto interminabili soliloqui».
Già in Greggi d'ira, la lingua dei pastori viveva soffertamente in un mondo «fondato sulla circolarità del gregge». Ma era pur sempre un mondo dove i «commendatori continuavano a spartirsi la terra e il cielo». E dunque: adiosu mundu antigu, adieu adieu nova civitas. Uomini - homines incapaci, seppure oscuramente ansiosi, di vivere l'ansia del mutamento.
Così, in questo antico asteroide di paese, lontano nido di soliloqui pastorali, ormai sta per spezzarsi paurosamente il cerchio della lingua materna che sapeva, un tempo, dare senso al giro ellittico dell'esistenza dei fieri pastori. Quel «cerchio del gregge», tragicamente quanto pietosamente, si ricomporrà soltanto proprio in chiusura di libro, come una sapienziale epigrafe, nella nenia delle prefiche, quando fantasmi di donne che facevano «cerchio attorno rispondevano con sommessi pianti» per dirci, forse, che l'antica lingua del cuore è capace di ricomporre il cerchio magico della parola soltanto per bisbigliare un canto tanatologico.
Diverse ma non più numerose, anche stavolta, le recensioni: su La Nuova Sardegna da Eliseo Spiga (“La rivolta dei pastori: un libro su un’amara vicenda sarda”), da Diodato Pigliaru (“Il pastore sconfitto: una esemplare vicenda sarda in un libro di Bachisio Zizi”), su Tuttoquotidiano da Cesare Protetty (“Il pastore in esilio: un romanzo sardo”). L’Unione Sarda si limota a presentare uno stralcio dell’opera con un breve distico di accompagnamento.
Devi accedere per poter commentare.