Bachisio Zizi a sei anni dalla morte, una memoria sempre presente, cara e istruttiva
di Gianfranco Murtas

L’ho perduto, il mio maestro, direi meglio: l’abbiamo perduto, il nostro maestro, nel ferragosto del 2014, giusto sei anni fa. Giunto egli alle soglie dei 90 anni, traguardo di una vita tutta conquistata, fra mille successi e diecimila sofferenze. Uomo d’orgoglio, d’autorità, e anche – come sa chi lo abbia conosciuto e praticato in campi segreti – di estrema umiltà, incredibile umiltà. Uomo complesso, di infinite stratificazioni per formazione ed esperienza di vita, per elaborazione di sé e del reale nel quale aveva, via via, insediato la sua capanna: personalità e responsabilità, relazioni, obiettivi e quotidianità, metodo e fatica. La fatica del fare, del costruire il nuovo. Uomo di pensiero, di letture e di pensiero, di studio e di pensiero, di dialogo e di pensiero. Uomo che nella banca, in quello che fu il glorioso e molte volte centenario Banco di Napoli – a Nuoro e poi a Cagliari, e dopo nell’ufficio primaziale dell’Isola, e nella direzione generale (allora a governare il credito fondiario) ed infine a Roma, a capo di oltre cento sedi operative nell’Italia centrale – mai fu soltanto “bancario”, e sia pure dirigente o alto dirigente, ma sempre fu creatura consapevole dei bisogni e delle urgenze del teatro umano. Anche sbagliando talvolta nell’intercettazione, ché gli sbagli sono anch’essi la cartina di tornasole della nostra umanità. Ma dietro i bilanci sapeva scorgere meglio di altri la vita, i sentimenti, gli azzardi, le paure, i riflussi degli uomini “del fare”, come egli li chiamava, grandi e piccoli.
Rispondendo ad un giovane universitario che, in facoltà di Lettere a Cagliari, lo interrogava sulla singolarità del suo essere, o essere stato per lunghi quarant’anni, uomo di banca – homo oeconomicus per la sua parte e per l’eccellenza della resa – ed il suo essere uomo di pensiero e scrittura, narratore, disse quella volta (era il 18 novembre 1990): «Dal mondo della banca popolato dagli uomini del fare, ho attinto i materiali narrativi che ho riversato sulla pagina scritta e dal mondo fantastico del romanzo ho derivato l'estro che mi ha consentito di pormi creativamente di fronte a ogni problema. Non sono diventato uomo a una dimensione proprio perché sono riuscito a umanizzare le procedure. Un direttore di banca ha il potere di dare o negare qualcosa a qualcuno: le sorti di domini visibili o invisibili sono legate spesso a un sì o a un no. Dietro i fatti economici però c'è sempre l'uomo».
Sviluppò particolarmente questa riflessione scrivendo, verso la metà degli anni ’80, il suo Santi di creta, che considero un romanzo bellissimo, degnissimo e bellissimo, pur se condannato in primo secondo e terzo grado dai giudici, evidentemente incompetenti a penetrare i valori d’un libro di narrativa. «In un romanzo l'autore entra da creatore, superando la materialità e la determinatezza di ciò che ha visto e sentito. Non si può scrivere niente senza amare, e Santi di creta è un libro traboccante d'amore. Ma chi può fare intendere tutto ciò ai giudici dei codici?», così rispose ad un altro giovane universitario che lo aveva interrogato su quelle sentenze venute a suggellare i processi penali azionati dalla denuncia di chi aveva ritenuto di individuare, in certi personaggi presentati nel chiaroscuro della loro esistenza, uomini e donne in carne ed ossa del vissuto paesano di Nuoro.
Erano intervenuti fior di intellettuali sardi, di letterati e poeti, a difenderlo, Bachisio Zizi: avevano firmato, numerosi, un documento in cui avevano spiegato come ogni romanzo sia un atto creativo, rielaborativo del reale secondo sensibilità personalissime e non rivelabili dell’autore, mai un libro di storia, mai una cronaca di fatti descritti nella minuzia. Rimase uno iato tremendo fra quel documento degli intellettuali sardi e quella prima seconda e terza sentenza, fra la verità degli scrittori e quella dei giudici di Cagliari e di Roma.
Partecipai anch’io, marginalmente, a quella difesa, non in faccia ai giudici ma, attraverso L’Unione Sarda, soprattutto ai nuoresi, ai miei amici nuoresi che, pur tutti in buona fede, non avevano capito, non ce la facevano a capire, come Santi di creta fosse opera alta di letteratura e non vigliacca umiliazione degli sconfitti dalla vita. E quando il mio pensiero si volge a materializzare, nel mio sentimento, nella mia coscienza, nel mio brivido, la memoria di Bachisio Zizi torno alla amarezza di quella ingiusta sconfitta, come torno anche al “fanciullino” che albergava in lui uomo potente e cui un rischio di cecità, ad un certo punto, parve dimensionarlo, rivelandone umanità netta e bisogno di conforto.
Ho pensato a come onorare in questo nuovo anniversario la memoria di Bachisio Zizi e una indicazione mi è venuta proprio dalla conversazione, cui ho fatto prima cenno, che lo scrittore ebbe con gli studenti di Giuseppe Marci, nel dipartimento di Filologie e Letterature Moderne, in quell’inizio di anno accademico 1990/1991.
Nel corso di alcuni mesi vennero a sa Duchessa, a colloquio con i giovani, diversi autori, alcuni dei nomi migliori della letteratura sarda contemporanea, da Francesco Masala ad Antonio Cossu, da Benvenuto Lobina ad Antonio Puddu, a Giulio Angioni, a Bachisio Zizi appunto. Altri poi fecero lezione su argomenti particolari, così Sandro Maxia, Nereide Rudas e Giovanni Lilliu, così Luciano Marrocu e Manlio Brigaglia, così Giorgio Melis e Michele Columbu e Giulio Angioni ancora… Una stagione accademica ricca, ricchissima che il professor Marci volle brillantemente concludere dando alle stampe, dalla CUEC, nello stesso 1991, un bellissimo preziosissimo libro: Romanzieri sardi contemporanei, introdotto da una cinquantina di pagine curate dallo stesso docente circa gli sviluppi della letteratura isolana fra Ottocento e Novecento, appunto fino all’età contemporanea, e concluso da una serie di schede su alcune delle opere di maggior rilevanza apparse nel panorama sardo di fine secolo (quelle sugli ziziani Erthole e Il ponte di Marreri, a cura rispettivamente di Lorenzo Manca ed Elisabetta Sanna e di Pierpaolo Pisanu).
Pressoché tutti gli sbobinati delle registrazioni furono curati dal gruppo di studio allora costituitosi attorno al professor Marci, non quello di Bachisio Zizi, visto e rivisto invece dallo scrittore stesso. Il che dice di Zizi altro ancora e non di poca importanza. Il rilievo cioè che egli dava alla parola, nella logica stessa del Bernstein che si riferiva alla V di Beethoven: solo quelle note, quelle battute, qui solo quelle parole, le giuste, le necessarie, fra le cento altre possibili. Una virtuosità maniacale, potremmo definirla, nell’autore de Il ponte di Marreri, Erthole e Santi di creta. Così avveniva in banca, tanto più nei cosiddetti report ai massimi vertici aziendali: il messaggio doveva essere preciso, riportare nella loro esattezza direi scientifica natura e misura di ogni evento richiamato, di ogni dinamica, di ogni previsione, di ogni giudizio.
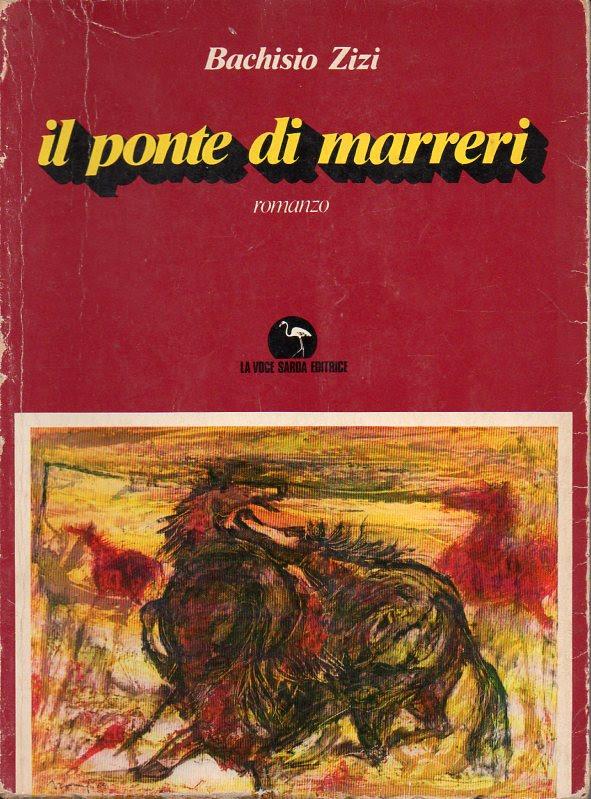
Conoscendo il rischio dello scarto (da tener sempre presente) fra la parola scritta e quella orale, e ben sapendo che la prima, soltanto la prima, costituiva pietra per la storia, mentre la seconda – sì evocativa magari di atmosfere e suggestioni ma infine radicata in una memoria fragile di per sé – soltanto se tradotta nella scrittura poteva scalare le classi e divenire “fonte” di storia, documento cioè, nulla trascurava davanti alla responsabilità, appunto, della trasmissione…
Ecco dunque, in questo nuovo anniversario della scomparsa del mio e nostro maestro, una testimonianza di lui resa da lui stesso, nei termini precisi in cui ha voluto renderla, meditandola, affinandola, affidandola alle parole scelte con lo scrupolo dello scienziato…
A seguire mi è sembrato bello ripubblicare la relazione che il professor Mario Ciusa Romagna – un intellettuale nuorese di grande rigore, per lunghi anni docente a Cagliari – svolse al convegno su La narrativa sarda nel Novecento, svoltosi a Quartu Sant’Elena nel 1988.
Gli Atti, pubblicati a cura del Comune di Quartu Sant’Elena e della Provincia di Cagliari, nel quadro della quarta edizione del Premio Letterario Michelangelo Pira, portano i contributi di numerosi critici letterari fra i maggiori presenti sulla scena isolana, da Leandro Muoni a Giovanni Pirodda, da Giuseppe Marci ad Antonio Romagnino, da Giovanni Mameli a Nicola Tanda, da Bruno Rombi a Natalino Piras, a Manlio Brigaglia – ideatore del tutto – ed a Mario Ciusa Romagna appunto (colui che, se ben ricordo, fu il promotore e il trascinatore della nobile testimonianza resa ai giudici dei processi sbagliati).
L’intervento del professor Ciusa Romagna tocca specificamente “la narrativa di Bachisio Zizi nella problematica contemporanea” e merita una attenta considerazione. Forse la comune nuoresità aveva favorito in lui una più intima investigazione delle condizioni prime e di quelle evolutive dell’arte letteraria di un autore uscito finalmente dalla “macchia”: da quella collocazione secondaria ed episodica in cui era sembrato al Michelangelo Pira de La rivolta dell’oggetto che certo conformismo aleggiante sulle lettere isolane l’avesse costretto; la frequentazione sempre proseguita negli anni, promossa e alimentata negli anni – tanto più quelli della seconda produzione, dopo lo stacco dalla stagione di Marco e il banditismo, Il filo della pietra e Greggi d’ira, fra il 1968 e il 1974 cioè – aveva consegnato alcune chiavi di lettura dell’ “universo” morale, intellettuale e letterario maturato come un unicum da Bachisio Zizi. C’era stata la ripresa infatti, nel 1981, e fu di grande respiro: Il ponte di Marreri, Erthole, Santi di Creta, e con essi un’altra decina di titoli: da Mas complicado a Il cammino spezzato, da Cantore in malas a Lettere da Orune, da I supplici a da riva a riva, e ancora da La voce dell’anima a Fughe e ritorni, da Dialoghi a distanza a Un’isola nel mondo, a Le dolenti cure…
Incontrando gli studenti della facoltà di Lettere, a Cagliari
Un sentito grazie al professor Marci per il cortese invito rivoltomi, che considero un privilegio, e un saluto caloroso a voi studenti, con l'augurio che abbia pieno successo la sfida che state lanciando da questo simpatico laboratorio culturale.
Sono lieto di trovarmi con voi, anche se devo confessare che sono qui per prendere e apprendere più che per dare. Un autore di romanzi, come un ladro gentiluomo, s'impossessa voracemente di tutto quello che vede e sente, anche se poi cerca di restituire capitalizzato ciò che ha preso. Il contributo che potete dare alla comprensione dei miei libri acquista un particolare significato, sia per il rigore del vostro impegno di studio, sia soprattutto perché voi siete portatori di futuro.
Vi è sempre uno scarto fra l'autore che traspare dal testo scritto e l'autore in carne ed ossa che parla e manifesta a voce ciò che sente e pensa. Nel libro c'è un riflesso dell'anima dell'autore il quale nella realtà della vita si porta appresso tutte le debolezze della carne. Io mi offro a voi con i miei limiti e le mie debolezze. Ponetemi liberamente le vostre domande, cercherò di rispondere come potrò, senza reticenze e senza rifugiarmi nelle teorizzazioni.
D. Come e quando è nato Bachisio Zizi narratore e soprattutto perché scrive?
R. Non credo sia facile stabilire il giorno in cui un romanziere ha incominciato a scrivere. Per un narratore la scrittura, il riversamento sulle pagine di ciò che egli pensa e sente, diventa un fatto tecnico che può anche tradire il racconto interiore cui manca un inizio e una fine.
Sono nato e ho vissuto gli anni dell'infanzia in un paese di narratori (Orune), dove perfino il saluto diventa narrazione. Raccontavano tutti nel mio paese, anziani e giovani, uomini e donne, saggi e folli... Qualche anno fa mi capitò d'incontrare su un treno che mi conduceva da Milano a Trento un giovane compaesano, soldatino di leva. "Dove sei diretto?" gli chiesi. "A Verona" fu la risposta "mi hanno detto che c'è un compaesano e vado a farmi unu mannicu 'e arrejonu". La conversazione concepita come cibo dell'anima. Nella caserma di Milano il soldatino si sentiva morire, non c'era nessuno che potesse ascoltare i suoi racconti. Tornando a me, una volta andato via dal paese, mi sono sentito in una caserma anch'io. Ciò che il soldatino cercava a Verona io l'ho trovato nella scrittura.
La pubblicazione di un libro è un atto di vanità, o così penso sia stato per me. In un altro tempo, nel mio paese, la trasgressione alle leggi ritenute inique era considerato un atto eroico; allora ci si poteva sentire uomini soltanto se si era stati almeno una volta in galera. Ora che per fortuna i tempi sono mutati, per sentirsi uomo basta aver fatto un figlio e scritto un libro. Chi può dire che inconsapevolmente non scriva anch'io per una rivalsa, per sentirmi balente in qualche modo?
D. Quali sono i suoi rapporti con gli altri scrittori e quali letture hanno influenzato le sue opere?
R. Sono stato definito scrittore alla macchia da Michelangelo Pira, il quale, in una nota a me dedicata in La rivolta dell'oggetto, parla di rimorso per la disattenzione con cui sono stati pubblicati e sono stati accolti i miei primi libri.
Scrittore alla macchia certamente lo sono stato, per pudore e per timore di invadere campi di presunte sovranità assolute. Le circostanze della vita mi hanno portato a uscire dalla clandestinità e a costituirmi, ma intimamente mi considero ancora uno scrittore alla macchia. La mia condizione di latitante e gli impegni professionali non mi hanno consentito di avere rapporti con gli altri scrittori. Questo non vuoi dire che non abbia letto e assimilato le opere degli autori che contano e che lasciano il segno. Nei miei libri però sono evidenti le tracce di una esperienza di vita non letteraria. Faccio un esempio. Recentemente ml è stato chiesto che posto occupa il danaro nei miei libri. Ritengo di poter confermare anche qui che raramente in ciò che scrivo il denaro compare come vizio o strumento di perdizione di singoli personaggi. Ho trattato la moneta come categoria economica che diventa motore della storia di piccole e grandi comunità.
Basti ricordare il personaggio di Zuacchinu in Erthole che, con l'introduzione o invenzione del comporare a dinare, segna il passaggio da un'economia naturale a un'economia monetaria, sconvolgendo la convivenza della comunità in cui agisce. Sono stato influenzato in modo particolare dagli autori di saggistica. Non avrei scritto Erthole o non lo avrei scritto così, se non avessi letto L'inconscio come insiemi infiniti di M. Blanco; e non avrei scritto Santi di creta se non avessi letto un saggio su Nuoro caso estremo di sottosviluppo.
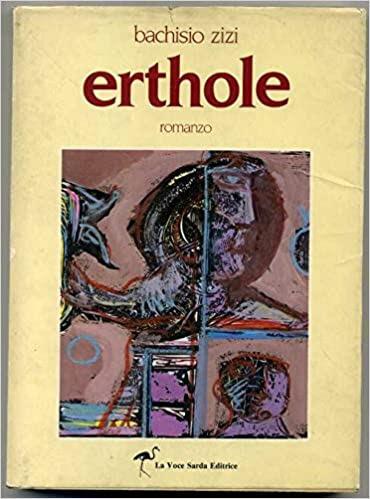
D.Può spiegare il rapporto che intercorre spesso nelle pagine di Erthole tra il mondo dei vivi e quello dei morti, fra presente e passato e perché l'evocazione di ciò che non è più o non è ancora viene affidata a elementi particolari della natura paesana come le acque e le pietre, o ancora a persone singolari, come Bambinu?
R. Ogni autore scrive un solo romanzo, i singoli libri costituiscono le parti o i capitoli in cui si articola, quell'unica opera che resta sempre un'incompiuta. Il tema ricorrente dei miei libri è il paese, il luogo degli impossibili ritorni, che finisce per diventare metafora di altro (paese mondo).
Se le necessità della vita non mi avessero costretto a lasciare il paese, forse non avrei scritto niente, avrei affidato anch'io sos contos alla parola parlata. Solo con un distanziamento di spazio e di tempo possiamo conoscere i luoghi dove abbiamo vissuto.
Ho cercato di cogliere i mutamenti del paese, andato al di là delle quantità celebrate dai sociologi. La caduta della centralità del gregge è l'inizio e l'epilogo del dramma raccontato nei miei libri. Siamo mutati insieme io e il paese e ora ci troviamo nella stessa sospensione in attesa di scoprire un altro centro dell'universo. Altre volte ho parlato di verticalità con riferimento agli scrittori sardi. Erthole è il libro dello sprofondamento nella mia sardità, il libro delle grandi emozioni. La lettura delle pietre è la ricerca dell'oltre, l'iniziazione a un'altra conoscenza che non sia solo della mente che ragiona, ma anche del cuore e delle viscere. Con Erthole mi sono avvicinato all'inconoscibile di me e del mio paese.
D.Parlando di romanzo storico e ricordando la vasta fioritura che questo genere ha conosciuto in Sardegna tra la seconda metà del XIX secolo e l'inizio del XX, tenendo, altresì presenti gli intenti con cui tali opere venivano composte dagli autori dell'epoca, vorrei domandarle, in riferimento a Il ponte di Marreri, che senso ha scrivere un romanzo storico alla fine del XX secolo.
R. I narratori sono gli anticipatori dei possibili futuri, anche quando sembrano coniugare i loro verbi al passato. Per attenermi alla mia modesta esperienza, quando ne Il ponte di Marreri parlavo del Cumone, un nuovo modo di vivere e convivere, avevo in mente la Sardegna dei duemila, non la Sardegna del 1847 dove è stata collocata la vicenda per esigenze narrative. Sorprendentemente il mio Cumone può essere considerato una forma alta della Total Quality di cui tanto si discute oggi pensando al futuro.
Partire dalla perfetta fusione, uno dei tanti nodi irrisolti della nostra storia, ha significato ripercorrere la via crucis delle riforme nate senz'anima. Il nostro vivere (di noi sardi) è un flusso nel continuo, come direbbero i matematici: nella persistenza del passato perfino la morte diventa vitale per noi. La realtà con i suoi repentini mutamenti ha sopravanzato l'immaginazione. Tutti gli antichi schemi sono stati spazzati via. La storia che pensavamo finita si è presa la sua rivincita. Dobbiamo ripensare tutto, liberarci delle metafore morte, ridescriverci con nuovi linguaggi. In quest'epoca di mondializzazione il problema che si pone agli scrittori sardi è come aprirsi al mondo senza negare se stessi e senza perdersi nell'indistinto delle quantità. Credo che la nuova narrativa troverà la propria linfa nella dilacerazione tra dentro e fuori, fra tradizione e modernità.
D. Come procede nella stesura delle sue opere e quali sono i meccanismi della scrittura che utilizza?
R. La mia professione mi porta a muovermi per programmi in ciò che faccio e in ciò che penso. Le mie programmazioni narrative però vengono puntualmente sconvolte dall'imprevedibilità dei meccanismi della scrittura. Di ogni opera riesco a costruirmi in anticipo i canovacci, equilibrata in tutte le loro componenti ma sono i personaggi a condurre i! gioco narrativo approdando a esiti impensabili. Durante la stesura di Il ponte di Marreri sono rimasto bloccato per un anno proprio per dissensi con un personaggio. Si trattava di don Satta che, durante il suo viaggio da Orvine a Nuoro, aveva voluto fermarsi davanti alla chiesa della Solitudine per dare uno sguardo alla vallata sottostante, inondata di luce e di verde. In piedi su quel ciglione sembrava celebrasse il rito di un'altra fede e io non sapevo come ridestarlo dalla sua meditazione
Si è mosso soltanto quando sono entrato in sintonia col suo mondo e ho sentito ciò che lui sentiva. Gli schemi narrativi che pretendevo imporre autonomamente erano incongrui e privi di senso proprio perché pensati secondo una logica estranea al romanzo e ai suoi personaggi. La scrittura di un romanzo, un fatto creativo e organizzato, è un lavoro paziente, un continuo fare e disfare alla ricerca delle coerenze e compatibilità. Come accade nell'impresa luogo privilegiato di ogni attività produttiva, anche nel romanzo tutto si compie all'insegna delle proporzioni definite; le parole, i gesti e le azioni dei personaggi si combinano fra di loro in modo originale e il tempo e lo spazio sono le coordinate in cui nascono e si misurano gli eventi. Bernstein, il grande direttore d'orchestra recentemente scomparso, commentando l'attacco della V sinfonia di Beethoven, metteva in evidenza più che la bellezza della composizione l'ineluttabilità di quelle quattro note. Nel romanzo l'ineluttabilità è data dalle coerenze e compatibilità di cui parlavo prima. Il rapporto dell'autore col suo testo è complesso, indecifrabile oserei dire. Se dovessi fare una classificazione, parlerei di immedesimazione nella fase della scrittura, nel senso che l'autore si sprofonda nei personaggi e vive la loro vita; di misconoscimento quando l'autore di fronte al testo compiuto si stupisce di aver scritto quelle cose, di estraniamento o espropriazione quando il testo diventa libro e acquista una sua autonomia rivoltandosi spesso contro l'autore.
Il richiamo di un aneddoto forse mi aiuta a far meglio intendere ciò che voglio dire a proposito di misconoscimento. Ho il ricordo di un mio congiunto che, assalito da febbri violente senza un male apparente parlava e straparlava di luoghi e di persone mai conosciute, facendo uso di un linguaggio colto, lontano dal suo povero orizzonte culturale. Quando usciva da quelle possessioni che lo stremavano, diceva di ricordare vagamente ciò che era accaduto e si rattristava per quella dimenticanza che lo esiliava dal mondo delle sue visioni. Se mi accade di riprendere in mano un mio libro, dal quale mi tengo lontano, non so se per la paura di trovarvi nuove dissonanze o per il disgusto del compiuto, provo stupore e mi rattristo anch'io, come quel congiunto.
D.Cosa significa oggi essere uno scrittore in Sardegna e quanto l'essere sardo ha influenzato la sua opera?
R. Se altrove la scrittura è esercizio di un mestiere o esito di una divertita evasione, in Sardegna essa resta sofferto bisogno di dare testimonianza di un sé inquieto. È da credere che nessuna opera di poesia o narrativa scritta in Sardegna sia stata mai dettata dall'impulso o ispirazione del momento, tutto viene da lontano, dalla niciana interiorità degli avi. Dietro ogni storia narrata c'è la storia della storia, un dramma difficilmente raccontabile. Eppure nessun luogo come la Sardegna ha una vocazione così spiccata al racconto; le storie si offrono spontaneamente, come fiori di campo destinati spesso ad appassire senza che l'estro di un narratore li colga. Forse siamo dei dissipatori. La nostra sardità sentita come finita infinità non consente distacco tra le cose e ci costringe a portarci dietro tutto ciò che è vivo e ciò che è morto, i fiori e la terra che li nutre.
Le molte opere di narrativa che si pubblicano sono le prova di quel racconto che non è mai nato. È come se la grande opera che la Sardegna attende dovesse scaturire da una coralità di voci che non riescono ancora a fondersi in canto comune. La perdizione nel dentro ci esclude spesso da ogni fuori, rendendoci incapaci di ogni scambio con gli altri. Detronizzati dalla realtà, non riusciamo ad ascoltare né a farci ascoltare, come gli avi pastori, più del dialogo amiamo il monologo interiore, che però resta relegato nell'inespresso. Gli scrittori sardi si rassomigliano tutti, forse perché ognuno si sente parte nel coro della grande opera che verrà. La disparità di temi narrativi è solo apparente: non vi è opera in cui non traspaia la nostalgia per il vasto grembo della madre terra e il dolore per lo scompenso tra sogno realtà.
Ora siamo entrati in una fase di meditazione o sospensione, forse abbiamo capito che la smaniosa e lacerata originalità del soliloquio in cui tendiamo a rifugiarci porta a un impoverimento di quei materiali narrativi di cui siamo custodi per natura.
D. Quale è o quale è stato il rapporto fra la sua professione di direttore di banca e l’attività di scrittore?
R. Di professionalità si può anche morire, parlo di morte interiore naturalmente. Quando una funzione o una procedura diventa metafora del mondo l'uomo perde la sua essenza. La banca molto può dare, ma molto può togliere, dipende da come si vivono i ruoli.
Con la scrittura sono riuscito a mettere in moto un circuito virtuoso dove ha trovato salvezza la mia anima. Dal mondo della banca popolato dagli uomini del fare, ho attinto i materiali narrativi che ho riversato sulla pagina scritta e dal mondo fantastico del romanzo ho derivato l'estro che mi ha consentito di pormi creativamente di fronte a ogni problema. Non sono diventato uomo a una dimensione proprio perché sono riuscito a umanizzare le procedure. Un direttore di banca ha il potere di dare o negare qualcosa a qualcuno: le sorti di domini visibili o invisibili sono legate spesso a un sì o a un no.
Dietro i fatti economici però c'è sempre l'uomo. In Santi di creta è raccontato l'incontro di due personaggi, un direttore di banca, appunto e un piccolo uomo senza beni al sole (Pipetto). Il direttore, seguendo i principi della sua arte bancaria, deve dire di no al piccolo uomo, che non ha esistenza come soggetto economico perché non ha beni. Nel libro è drammatizzata la sofferenza del decidere del direttore, il quale finisce per diventare sovvertitore dei principi quando riesce i mettersi all'ascolto di Pipetto, che lo esorta a darlo all'uomo il credito che lui chiede. Anch'io nella mia vita bancaria ho incontrato i miei Pipetto ai quali forse devo la salvezza della mia anima.
D.Una nota dolente ovvero la condanna di Santi di creta portato in tribunale poiché vi si ravvisavano gli estremi di diffamazione. Un caso più unico che raro. La domanda è questa: cosa ha lasciato tutto ciò in lei come uomo e come autore ed ancora come ha trovato la forza di continuare a scrivere dopo un episodio così assurdo?
R. Parlo con molta pena di questa mia vicenda giudiziaria, e non per l'esito che ha avuto il processo ma per l'accanimento con cui sono stati stravolti i miei sentimenti e i miei intendimenti. Ciò che più mi addolora è che un'operazione così squallida dal punto di vista culturale sia partita da Nuoro, additata un tempo come l'Atene sarda. Quando si porta la fantasia in tribunale si cade nel ridicolo pretendendo di leggere un romanzo all'insegna dell'identificazione. Col gioco delle analogie e delle connessioni misteriosamente tutto può essere analogo a tutto.
Questo processo però mi ha aiutato a penetrare i meccanismi della scrittura, a capire come la realtà e le esperienze della vita si riversano in un romanzo. Ecco una delle tante scoperte che ho fatto. In Santi di creta c'è un personaggio, la cui vicenda simbolicamente fa da contrappunto alla vicenda della famiglia di appartenenza e della città in cui vive. È Michele Senes, colto nel travaglio della sua agonia. Gli elementi che lo caratterizzano sono: la timidezza fino al limite dell'afasia; la condizione di gemello di un essere infelice; l'estrema sensibilità che lo porta a intuire le angosce di sua madre. Io sono padre di due gemelle, la cui nascita ha posto problemi molto seri in casa mia anche per le paure di mia moglie che influenzata da certe letture e dalla sua esperienza di insegnante, si alzava di notte per accertarsi che le figlie fossero normali nel corpo e nella mente. Un'eco dei terrori di mia moglie è rintracciabile nel personaggio di Anna, madre di Michele Senes. Inoltre, io ho seguito le traversie di una mia collaboratrice il cui figlio aveva avuto nella prima età difficoltà a comunicare, difficoltà amplificate dalle paure materne.
Dopo la lettura del dattiloscritto di Santi di creta, la mia collaboratrice ha dichiarato che le era sembrato di trovare in Michele Senes ciò che lei pensava e temeva per suo figlio. Pur con questi riferimenti Michele è lontano dalle mie gemelle e dai figlio della mia collaboratrice ma soprattutto è lontano dalla persona con cui lo si è voluto identificare nel processo.
Nella mia professione si parla di valore aggiunto per significare il divario esistente, talvolta rilevantissimo, tra il prodotto finito e la materia prima. In Michele Senes il valore aggiunto è prevalente rispetto a qualsiasi realtà. In un romanzo l'autore entra da creatore, superando la materialità e la determinatezza di ciò che ha visto e sentito. Non si può scrivere niente senza amare, e Santi di creta è un libro traboccante d'amore. Ma chi può fare intendere tutto ciò ai giudici dei codici?
D.Cosa l'ha indotta ad esprimersi con la scrittura di romanzi e non attraverso saggi, o, addirittura perché non ha deciso di propugnare le sue idee impegnandosi nella politica dato che molte cose da lei dette in diversi punti delle sue opere (penso ad alcune soluzioni per un nuovo tipo di vita associata come il Cumone) potrebbero benissimo fare parte del programma d'un qualche partito?
R. Il romanzo trascende sempre l'immediato, la sua incidenza sulla realtà si misura nei tempi lunghi. Il narratore compie una scelta di libertà, nel senso che riversa nel suo testo ciò che pensa e sente, senza le dipendenze e i vincoli di quella che Bacone chiama la durezza del reale.
Raramente i nostri saggisti e i nostri politici riescono ad innalzarsi dall'eterna emergenza, dove si esaurisce, naufragando, ogni loro creatività. Evidentemente sto esponendo un punto di vista personale. La nuova opera che attende la Sardegna sarà una sintesi tra saggio e racconto, una grande narrazione dove si fondono tutti i saperi.
Riflettendo sulla frantumazione che ci attraversa come singoli e come comunità, mi sono immaginato spesso opere corali, capaci, come gli integrali matematici, di dare valore anche alla polvere che si solleva dalle nostre campagne assolate.
D. Qual e la sua opinione sulla questione della lingua sarda?
R. L'elemento che più rende simili i nostri scrittori, nonostante le apparenti contrapposizioni, è il mezzo espressivo, che è sempre plurilingue, al di là del segno significante volta a volta scelto. Le lingue che ci appartengono però le sentiamo come incarnazione di tutto ciò che abbiamo vissuto o sognato. Tra la concezione del mondo di chi scrive in italiano e quella di chi scrive in sardo non ci sono scarti significativi, proprio per quella mescolanza che spesso sfugge alla nostra coscienza. La lingua, l'identità, su connottu possono tracciare curve di ascesa o discesa del nostro orizzonte culturale. Di questa sorta di paradigma ho una visione dinamica, nel senso che esso si fonda su entità storiche non metafisiche. La lingua nasce dalle cose e l'identità si rafforza ed espande solo confrontandosi col fuori, senza autoescludersi. Su connottu non è il luogo delle nostre nostalgiche rimemorazioni, ma un momento nel flusso del continuo cui e legato il nostro destino di sardi.
Quella fusione di mondi io la sento dentro di me sia quando grido le emozioni nella lingua di mia madre (impreco e prego in orunese), sia quando uso il metalinguaggio monetario per parlare di cose di banca. La sardità però resta il punto delle mie fughe e dei miei ritorni, anche quando uso l'italiano per scrivere i miei poveri romanzi.
Mario Ciusa Romagna, la narrativa di Zizi nella problematica della cultura contemporanea
La narrativa di Bachisio Zizi non è facile a capirsi nelle varie dimensioni e aspetti che, di volta in volta, assume. I problemi che vengono avanti lungo la lettura, o a libro chiuso, non sono pochi. Esistono sempre una condizione storico-ambientale ed una esistenziale, e una complessità oggettiva entro la quale soffre e vive l'esperienza dello scrittore. Il paese (Orune) o la piccola città (Nuoro) sono nel soggetto che narra così come il soggetto narrante cresce all'interno di quei contesti, sul piano culturale, umano e interpretativo. Da un romanzo all'altro, perciò, siamo di fronte a una vera e propria ri-descrizione, che come tale si presenta diversa non solo per i tempi in cui si compie, ma per il fatto che lo scrittore assume angolazioni di molto spostate rispetto all'opera precedente. Il lettore quasi non avverte che il complesso scenico-drammaturgico è sempre quello e che il processo dell'intrigo narrativo non muta di molto. Mutano sostanzialmente i tempi storici scelti come materia del racconto e ancor più la misura conoscitiva da parte dello scrittore. Direi che nei romanzi di Zizi si avverte un processo storiografico in espansione e continuo approfondimento, per cui il contesto di base e il dramma con i suoi personaggi assumono orizzonti e panni diversi, fisicità e moralità diverse. Sono altra cosa da opera a opera.
Zizi è uno scrittore in perenne «formazione». Per cui la «compiutezza» di un suo romanzo, pur con tutta l'autonomia e originalità che si vuole, presuppone un'apertura, lascia intravedere che la vicenda non è chiusa, dovrà continuare così come continuano il tempo e gli eventi degli uomini.
Nei suoi romanzi esiste sempre un'antitesi, che funziona come elemento dinamico. Le cose pare procedano secondo una normalità causale e che debbano andare così fino alla fine. Ma vi è un tempo casuale, l'imprevisto che fa deviare il corso degli eventi. Tanto che a un certo punto l'antitesi esplode in tutta la sua evidenza. «Su dominariu» in Erthole e il «Castello» in Santi di creta si vuotano, non risuonano più di vita e di passioni. Le stesse persone che abitano là dentro sono come cose morte. Vivono nel silenzio o nella disperazione. Ciò che rimane è solo desolazione, inutilità, inesistenza.
Le generazioni passano una dopo l'altra. Nel trascorrere portano via il loro tempo e le loro idee. Lasciano il vuoto perché altre generazioni lo riempiano e così via.
Nei romanzi di Zizi il fluire del tempo assume valore tragico, eccezionale e, contemporaneamente, normale. Ha una sua logica. Il morire, via via, degli eventi è destino da cui non si può sfuggire. La finitezza di ogni moto umano è, appunto, prospettiva destinale, ma non in senso negativo. Zizi non ricorre mai ad affermazioni di carattere metafisico, non ipotizza mai niente che vada oltre la possibilità dell'essere nel mondo. Tutto si consuma qui, in terra. Qui nascono e qui le cose finiscono. Ma il punto, per capire la vita, è nel capire la morte, nell'acquisire coscienza che il giorno viene per tutti e tutto. Il credersi eterni è il più grande inganno che gli uomini si auto-creano. Può divenire illusione tanto forte per cui la caduta, o la prospettiva della caduta, non può che risolversi in angosciosa delusione, in solitudine. Gli uomini sono «santi di creta» e come tali passibili di andare in frantumi, con tutti i loro progetti e immaginazione.
L'antitesi diviene elemento interpretativo, dà la possibilità di rifare, ogni volta, la via già percorsa in modi diversi. La capacità singolare dello scrittore è nella facoltà, appunto, di poter riraccontare la «stessa storia» in modi assolutamente nuovi. Le sue narrazioni sono vera e propria storiografia concepita non solo in tempi diversi, ma con cultura e umanità diverse.

Non è che Zizi sia giunto da un giorno all'altro alla concezione dei Santi di creta. È necessario ribadirlo.
Il suo è un processo culturale che si realizza narrativamente nel tempo. Sono le prospettive interpretative che vanno sempre più approfondendosi. È uno scrittore che comincia a profilarsi dopo il secondo conflitto mondiale. Assorbe le idealità e le finalità salvifiche e teleologiche dello storicismo gramsciano. Vede nel neorealismo la misura narrativa per scoprire o portare alla luce un ambiente nascosto; assiste, in seguito, non impassibile, anche alla crisi del neorealismo e al profilarsi delle neoavanguardie. Tuttavia un valore gli rimane dentro: quello della storia, nel pensare che la letteratura come tale non può prescindere dalle epoche in cui si esplica.
Uno degli autori che predilige è Braudel. La teoria dei «tempi lunghi» lo fa pensare e soprattutto lo pone in diretto contatto con le vicende del paese. Nel quale scorge non solo i tempi lunghi del processo storico, ma la validità della microstoria in rapporto alla macrostoria. Tutto, però, va verificato e vissuto sui campo. Direttamente.
Ripeto che Zizi rifugge da ogni regola o verità di ordine metafisico. La verità è nelle cose stesse, negli eventi e negli uomini. Che acquistano, poi, la loro essenza nel contesto della narrazione. È là dentro, nel tessuto stesso della scrittura, che assumono pensiero e azione. Braudel lo induce a vedere le vicende in modo più ampio, in relazione al tutto di quel determinato tempo. Ma lo attrae anche un'affermazione del famoso storico francese quando questi dice che non ha mai rifatto un suo libro. Non lo saprebbe riprendere. Lo ha sempre riscritto, il libro. Ha fatto cioè una storia diversa da quella che aveva già scritto. Ed è proprio così: le storie non si rifanno, ma si riscrivono. Ogni generazione, dice sempre Braudel, scrive le proprie. Se non lo facesse significherebbe che non ha futuro e che deve solo guardare e ripetere il passato.
In Zizi il paese o la piccola città sono ogni volta visti in modi differenti. Significa, prima di tutto, che lo stesso scrittore si trasforma e vede in modi differenti. Significa che i punti di riferimento si sono spostati. Ogni romanzo, infatti, diviene anche una riscrittura di se stesso. L'autore si riracconta all'interno della storia che tratta. Ma non è questo l'aspetto veramente positivo di uno scrittore? La dinamica narrativa si sposta continuamente all'interno dello stesso romanzo.
La ricerca di un vocabolario nuovo capace di dire la diversità della condizione sociale, di portare avanti le situazioni drammatiche inconsuete è costante in Zizi. Ma senza sforzo. Perché il problema della lingua va di pari passo con quello dei paradigmi interpretativi. È il mondo che va scrutato, visto e sentito perché contemporaneamente lo si possa anche dire. La lingua stessa è comprensione, modo di essere di un ambiente e di viverlo internamente. Ripeto: il processo storiografico è duplice perché riguarda il materiale da narrare e l'autore che narra. Che deve trovare un vocabolario, che non può essere se non quello stesso di capire e di vedere. La parola può essere rapporto ed essenza. Rapporto in quanto stabilisce una connessione, essenza in quanto diviene realtà e verità di quanto dice ed è. Zizi non ha un «grande stile» su cui modellarsi, a cui attenersi. Il problema, ripeto ancora, è quello di capire. E ciò significa anche poter dire quanto e come si è capito.
Non è un caso sottolineare che le opere più rilevanti di Zizi vengono in anni recenti, in cui già si sviluppa la crisi dello strutturalismo e si pone con sempre maggiore interesse la posizione dell'arte e della letteratura come esigenza conoscitiva. Il problema gnoseologico è in atto e, di pari passo, la funzione della letteratura come salvezza stessa dell'uomo e della natura. In altri termini si tratta storicamente e drammaticamente di esperire, di parlare o scrivere con vocabolari inusitati rispetto ai precedenti conosciuti.
Ho insistito su questo aspetto perché mi pare che sia il più positivo della narrativa di Zizi e anche quello meno inteso.
L'altro aspetto, conseguente ai precedenti, è che la «paesanità» nello scrittore è mondialità. Orune e Nuoro sono nel mondo e attraversano la stessa contingenza di tutti gli altri centri abitati, pur con le caratteristiche e specificità che si vuole. Il paese non è entità chiusa, ma dialogante. I punti di riferimento si moltiplicano e, perciò, l'ente paese è rivisto attraverso angolazioni che vanno al di là della tradizione. Le stesse ritualità etnologiche sono viste in una prospettiva antropologica al di fuori di ogni ripetitività.
Ne Il ponte di Marreri (1981), e mi fermo in particolare sugli ultimi romanzi, si può constatare una visione che rientra in certo storicismo gramsciano nella ricerca, non solo, delle disfunzioni di una società, ma nell'aspirazione che questa trovi altri equilibri. Il complesso umano, diviso in classi, e con due culture in contrasto, è colto in un momento particolare della sua storia, cioè nel punto acuto della crisi quando, alla metà del secolo scorso, le conseguenze della privatizzazione a causa delle leggi delle chiudende vengono a maturazione, per cui la massa dei contadini e pastori si trova esclusa dai privilegi che prima godevano sulla terra.
Il romanzo è corale in quanto tutta la popolazione partecipa alla vicenda. Da una parte i nuovi proprietari che si fanno sostenitori delle leggi dello Stato e dall'altra la folla dei diseredati, che si appellano alla tradizione che concedeva loro l'uso libero della terra. Le parti sono capeggiate da due personalità potenti. La conservazione degli istituti decretati dallo Stato è guidata dal Rettore don Arcangelo Satta e l'altra da uno studente malato, debole fisicamente ma di forte ingegno. Le due figure così nitide, viste a tutto tondo, si contrappongono degnamente. Il Rettore domina dall'alto della sua chiesa e parla e ingiunge ordini dal pulpito come se abbia in mano le tavole mosaiche, il diritto che gli spetta per volontà divina. O è egli stesso parte di quella divinità? Se le campane sono annuncio ai fedeli della presenza di Dio, non le fa anch'egli suonare perché tutti accorrano a sentire la sua parola? Alessio è il classico intellettuale organico. Possiede la lucidità della ragione e il calore del diritto umano, della solidarietà con i deboli. Pastori e contadini si persuadono alla serrata, secondo le direttive di Alessio. Si ritirano nei boschi alti della montagna. La legge non li può raggiungere ed operare contro di loro. Il dramma si scioglie con la decisione sorprendente del Rettore di mettere a disposizione della «comune» le sue vaste terre. Contadini e pastori ritornano in paese. È festa. Comincia l'aratura e poi la semina. Le greggi si spandono tranquille nei prati. Pare che il cielo di Orvine si illumini come non mai e il verde dei campi assuma una tenerezza inconsueta. Ma il colpo di fucile che abbatte il Rettore mentre transita sul ponte sopra il fiume Marreri pone fine alla breve stagione in cui tutto il paese pareva avesse iniziato Im nuova epoca.
Il romanzo è vasto. Dalla coralità emergono moltissime figure con personalità ben distinte. Ognuna, pur in mezzo alla complessità della materia, è ritagliata con decisione, con contorni ben chiaramente individuati. Ma l'anima è l'insieme, la folla tutta che agisce, pensa e parla all'interno del cielo e della terra che sono suoi. La voce del vento che spazza il paese e fa fremere i boschi pare sia la stessa della disperazione di quella gente. Il dolore è la vera entità che, alla fine, accomuna gli uomini, che amano di un amore disperato la terra e le altre creature a loro simili. Amare è sofferenza ed attesa. Forse, mai speranza.
Siamo di fronte ad una scrittura fortemente espressionista. Lo storicismo gramsciano determina l'impostazione dell'intrigo narrativo, e così pure certa tendenza verso aspirazioni di origine neorealista. Ma è da evidenziare che Zizi ha di fronte il proposito di una grande saga paesana, colta in un momento rilevante della sua contingenza. Per cui il romanzo, pur con i riferimenti culturali e letterari che si vuole, s'impone per la sua unità drammatica e per la dinamicità dialettica costante dall'inizio alla fine. L'imponente figura del Rettore o la esile e forte personalità di Alessio o la delicata Pepparosa con il suo amore segreto e le lunghe attese sono sempre visti all'interno del dramma di tutto il paese. Fanno parte intrinseca di quella totalità. Sono inconcepibili al di fuori. Non si spiegherebbero i loro umori e desideri, la disperazione e la solitudine, le nostalgie e il loro dolore.
- Romanzo storico? Potrebbe essere. Mi rifaccio a quanto già detto per confermare che la narrativa di Zizi è «storica» in quanto trova le sue matrici nei momenti nodali della società di cui tratta. Le epoche di passaggio lo attirano perché sono le più mosse e le più ricche per i contrasti tra passato e presente. L'azione del tempo diviene fondamentale. La contingenza si pone come punto conclusivo di un'epoca e inizio di un'altra. La suggestione verso ciò che muore e ciò che nasce è molto forte nello scrittore.
Sono i momenti cruciali che richiedono maggiore impegno perché esigono vocabolari diversi dai soliti, punti di riferimento assolutamente al di fuori della consueta tradizione. Ogni linguaggio subisce l'usura del tempo assieme agli istituti sociali che costituiscono il cosidetto senso comune.
Zizi è molto attento a tutto ciò. Sa distinguere. Perciò la scelta stessa di un argomento diventa impegno in quanto lo costringe a un riesame del passato in confronto alle prospettive che il presente gli mette di fronte. Il capire diventa dire. E il modo in cui un fatto od altro si dice è spia della comprensione. Ho già accennato alla suggestione che nello scrittore hanno esercitato gli storici delle «Annales». Da cui, in concreto, sono venute le posizioni culturali a vasto raggio rispetto non solo alla storia, ma a tutto il sapere contemporaneo. La storia è complesso di più discipline, di una perenne osmosi tra le diverse specificità riguardanti non solo le scienze dello spirito, ma le scienze in generale. Zizi non è un «puro» narratore. Tanto meno un letterato di carattere estetizzante. Le esperienze, ripeto ancora una volta, le fa sul campo in cui si possono incontrare e scontrare le aspirazioni e le esperienze esistenziali e sociali, politiche ed economiche, scientifiche e tecniche, ecc. Non a caso ha attraversato le problema culturali che vanno dalla crisi dello storicismo gramsciano al post-strutturalismo, alle recenti posizioni ermeneutiche, ecc. La tensione e sempre nello sforzo di capire più profondamente ogni evento.
Il ponte è narrato ma terza persona anche se l'autore partecipa alla vicenda con tutta la sua solidarietà. Nel secondo importante romanzo passa alla prima persona. È fatto non trascurabile perché Erthole, uscito nel 1984, proprio per questo ha suscitato non poco interesse. Anzi, direi che in quell'anno è stato il «caso» letterario più importante nell'isola. Naturalmente se mi fermassi all'asserzione del passaggio dalla terza persona alla prima direi molto poco. Però la questione è che questo spostamento di persona, o se si vuole di pronome, ha creato anche un fondamentale spostamento narrativo. Perché l'autore è passato da uno stile referenziale, pur con tutti i possibili chiaroscuri, ad uno fondato prevalentemente sul dialogo. Tanto è vero che la referenzialità assume, il più delle volte, il valore di vere e proprie didascalie. Ma tutto ciò crea un impasto così fuso e mobile, per cui ti pare di far parte di quanto avviene all'interno del dramma.
È un fatto nuovo e non comune nella narrativa sarda. I due elementi, quello soggettivo e l'altro oggettivo, sono in funzione complementare, si integrano a vicenda. Anche la forma dialogica possiede un proprio andamento, in quanto l'io si pone come colui che non solo vuole sapere ma spinge gli altri a rivelarsi. Il metodo del dialogo, perciò, è maieutico. Suscita tensione continua, attesa di conoscere, aspirazione a scendere sempre nel più profondo delle anime e dell'ambiente. Insomma Zizi spezza la tradizione narrativa di origine ottocentesca di cui si era valso in buona parte ne Il ponte per porsi dentro la materia. Stavolta la discesa in campo è completa. L'esperienza si compie nello stesso momento in cui avviene. Si fa nel fare, come già accennato.
Perché questo capovolgimento di impostazione narrativa? Date le caratteristiche dello scrittore la si potrebbe definire naturale. La sua tendenza appassionata e appassionante è quella di entrare, di far parte attiva e umana dei fatti che segue. Perciò la prima persona, l'io gli dà questa possibilità di toccare, di vedere, di seguire passo passo quanto avviene o è avvenuto. Lo stile, e anche questo è rilevante, acquista un andamento tra lirico e drammatico. Voglio dire che l'aspetto memoriale, la ripresa di un tempo perduto nel momento presente si interiorizza maggiormente. Si fa visione, sogno e si fonde con la realtà contingente. La brevità dei periodi diventa battente. L'insistenza continua nel domandare si ripercuote nell'anima di chi legge.
Il dialogo, stavolta, pone più imperiosamente il problema del dire, che Zizi affronta con decisione e sicurezza. Ma che cos'è questo romanzo? Che cosa racconta, se di racconto si vuoi parlare?
L'io narrante si è allontanato dal paese da molti anni. È quasi fuggito seguendo a piedi l'antica traccia impressa dagli avi nei terreno. Quel sentiero lo ha portato nel grande mondo, dove è cresciuto e dove ha esplicato la sua attività. Ma un vuoto nell'anima gli è rimasto. Come una malattia che nessuna medicina può guarire e nessun medico riesce a diagnosticare. Il rimedio può essere il ritorno al paese. La malattia, in realtà, è un singolare rimorso che affonda proprio in quella fuga lungo l'antico sentiero. Se n'è andato. Ha lasciato i campi, l'aria e il vento del paese in cui è nato e vissuto fino ad una certa età. Bisogna ritrovare quel tempo. Perciò ritorna, stavolta lungo la strada provinciale asfaltata e con la sua macchina. Dall'alto della «preda iscritta» rivede, in basso, il paese. Gli appare come un cimitero, così immerso nel silenzio e costellato dalle antenne televisive che si presentano come tante croci. Un'idea di morte e di un mondo trapassato quasi lo immobilizza. Ma deve andare, scendere, dove lo attende un amico a cui si è rivolto per avere una casa in affitto nel mezzo del bosco di Erthole. L'ingresso nell'abitato genera meraviglia e interesse. Le strutture urbanistiche sono mutate, ma anche il tempo e l'aria paiono mutati. Sulle antiche strutture se ne sono sovrapposte altre. Sul vecchio che rimane si è stabilito il silenzio e il mistero Le generazioni e i personaggi che hanno qualificato la vita e le istituzioni del paese non sono quasi più ricordati. Ma il protagonista narrante, o meglio, il malato che cerca di guarirsi nella rievocazione del passato, li risuscita e li riporta alla dialettica del dramma.
Il Due sorelle gli danno la casa in affitto nel mezzo del bosco. Che ha le sue voci e suscita memorie infinite e inquietanti domande. «Su mudu», un vecchio pastore, è la persona che gli sta più vicino. Ma anche le due sorelle vengono a trovarlo. E Maddalena, la maggiore, inibita e senza memoria, ritroverà i suoi trascorsi e anche l'amore. «Su mudu» e Maddalena riportano il protagonista alla guarigione, al superamento del rimorso che gli pesava. Se ne va, alla fine. Lascia «Su mudu» che ha ritrovato la parola e Maddalena che ha ripreso ad amare. Se ne va mentre anche il paese si illumina e le grida della gente salgono fino a lui che si ferma un istante in cima a «sa preda iscritta» per rivedere il luogo da cui si porta via, definitivamente, il proprio passato.
Breve e scialbo riassunto. Perché la sostanza, la vera, del libro è in ben altro. Tocca le figure più importanti del racconto. La maggiore è quella di Zuacchinu che ha mutato la storia del paese. Giunge da un luogo lontano con due cassette di sapone che offre per moneta. Non accetta lo scambio in natura. Il denaro solo è il mezzo per avere. Le donne fanno di tutto per acquistare il sapone secondo le condizioni imposte dal venditore. Che torna con altre merci, con stoffe e oggetti, che affascinano le giovani, le quali scoprono le nuove dimensioni del dare e dell'avere e contemporaneamente la vanità e l'essenzialità dell'essere belle e dell'amore.
Zuacchinu dirà, nella visione in cui appare al protagonista, che ha spostato il paese portandolo da una condizione primitiva ad una umana e civile, in cui non più la vita delle greggi è determinante della vita degli uomini. Zuacchinu è il perno storico del passaggio da un'epoca all'altra. Muta radicalmente le strutture e i sentimenti del villaggio.
L'arrivo, dopo l'ultima guerra, della divisione Cremona introduce il superamento dei vecchi costumi. L'amore è passione e godimento. La donna sa di essere bella e fonte di desiderio. Zuacchinu mette su un grande emporio. Vende tutto. Porta la luce elettrica e costruisce il primo mulino a vapore.
Il paese è visto nel momento più cruciale della sua crisi. Pochi anni mangiano secoli di storia. Stabiliscono una dinamica inarrestabile, per cui anche l'epoca di Zuacchinu è superata. Gli eredi si disperdono. Non sono all'altezza di seguire il corso dei tempi. Lasciano isolato e vuoto il grande «dominariu», che costituiva l'anima dei nuovi rapporti economici e sociali. La polvere e l'abbandono sono metafora del mutare dei tempi.
I nodi storici, come già detto, sono le «imprese» narrative di Zizi. Le ragioni le ho spiegate. Ma insisto sul fatto che proprio quei «nodi» pongono la necessità di cultura e linguaggi sempre più adeguati. Il dire, il vedere e continuamente interpretare è un pensare e il pensare è un vivere le contingenze nella dimensione in cui, di volta in volta, vengono a trovarsi. Non si può narrare o parlare sempre nello stesso modo, sulla base delle regole e dei medesimi lessici. La lingua, ogni lingua, cambia così come cambia la storia del mondo. E il paese di Zizi è appunto un mondo che segue il processo del tutto. Parlare è pensare ed essere. Però nella dialettica del mondo.
Ma c'è di più. L'arte in genere nasce dalla cultura, dalla tensione ermeneutica di conoscere e di interpretare, di porre l'uomo, il destinatario, di fronte a «realtà» e «verità» non precedentemente conosciute. Zizi non è uno scrittore ingenuo che se ne sta a bocca aperta in attesa che l'ispirazione scenda. Sa che è frutto di lavoro, di stringersi l'anima fino alla spasimo. Tanto è vero che l'ultimo romanzo, Santi di creta (1987), è stato il più sofferto da parte dell'autore. L'orizzonte di osservazione si è molto allargato. Il nodo storico scelto ancora più complesso. I rapporti tra i personaggi in campo più complicati. Eppure i tempi rispetto ad Erthole possono essere gli stessi. Mutano le strutture sociali ed economiche. Così pure la scena, che si sposta dal paese alla piccola città con più ricca tradizione e con maggiore apertura. Perciò le leggi del dare e dell'avere si svolgono con determinazione più tecnica e razionale. Quindi più incombenti sul destino degli uomini.
La vicenda dei Santi nella sua linea evolutiva può ricordare, senz'altro, quella di Erthole. Anche qui un imprenditore, non d'origine mercantile, non girovago, ma nobile e ricco. Don Michele Are, infatti, è preso dalla febbre del fare, del costruire. Impianta un grande mulino a vapore, porta a Nuoro la luce elettrica, allarga gli spazi delle macine fino ad impiantare un grosso pastificio. Ma non si accontenta. La febbre lo spinge al più arduo e pericoloso dei suoi progetti. Tenta di costruire una grande diga in modo da imbrigliare le acque del Cedrino. Che, regolate, possono dare maggiore energia e ricchezza. Però don Michele viene travolto da quelle stesse acque durante una vorticosa piena del fiume. Di lui non viene trovato che qualche indumento. Fa la fine di un dio e come un dio scompare nel mistero dei gorghi.
Diego, il figlio maggiore, sostituisce il padre. Ha lo stesso temperamento, la stessa tendenza a fare e comandare. I fratelli sono come dominati dalla sua volontà. Però, in fondo, non lo amano e tendono a svincolarsi dalla sua soggezione. Nel mulino, nel vasto ufficio, ognuno ha il suo tavolo. A Diego nessuno contende la sedia e il tavolo del padre. Pare che tutto proceda come una volta. Ma una sorda disgregazione è in atto tra i discendenti. Che passano i giorni senza dialogo, nel silenzio più cupo, ciascuno chiuso in se stesso. Gli affari, tuttavia, tirano. Gli anni della seconda guerra mondiale rendono l'azienda indispensabile alla vita del regime di guerra. Ne fanno un ente che si sviluppa in sistema di monopolio. Perciò Diego pensa e progetta. Accresce le attività produttive fino ad edificare un vasto laboratorio destinato a fabbricare ceramiche.
La fine della guerra capovolge la situazione. I mercati lentamente si riaprono. La dimensione monopolistica cessa. E ciò porta anche ai forti scoperti in banca fino ad un temuto e possibile fallimento. I vuoti finanziari e la diminuita richiesta dei prodotti accentua la disgregazione dei fratelli. Si arriva alla chiusura dei vari stabilimenti. Chiude anche il mulino che era il cuore pulsante della città. Gli interni dell'enorme edificio si trasformano in inutili spazi, l'attività frenetica delle macchine in silenzi esasperanti.
Dentro il mulino Diego si trova come un essere sperduti in un mondo che non gli risponde più.
Quel desolato mistero attrae e nello stesso tempo distrugge l'uomo. Anche il palazzo che abita è desolazione. Quando ritorna l'ultima notte lo accoglie la vecchia e unica domestica rimastagli. Lo mette a letto. Diego già vaneggia assalito dalla febbre. Rivede il padre che gli siede vicino, come se sia giunto per accompagnarlo nell'al di là.
Ecco la chiusura del romanzo:
«-Andiamo - disse il padre, con infinita tenerezza. Diego voleva sapere se era quello il momento del trapasso, ma conosceva già la risposta e chiese soltanto: Dove?
- A vegliare le agonie del mondo...
Disparvero lentamente nella notte più buia, e la terra non ebbe un sussulto».
Forse bisognava giungere a questa epigrafica conclusione per capire meglio lo spirito che caratterizza tutto il romanzo. L'autore usa spesso questi termini «trapassi» e «agonie», a cui fa seguire l'immobilità della terra o il vuoto degli spazi silenziosi. In fondo vi è sempre l'azione del tempo che agisce e muta le opere e gli affanni degli uomini. Le generazioni corrono, si accavallano una dopo l'altra con mille dolori e amori. Ma il tempo non ha pietà o tenerezza alcuna. Corre implacabile e se ne porta via «ogni umano accidente», per parafrasare Leopardi, che Zizi conosce e spesso rilegge. Ma qui, in questo romanzo, non si tratta di un ritorno al materialismo settecentesco. Qui il tempo che travolge le azioni, i sogni e i desideri è la stessa organizzazione che gli uomini hanno messo su. Sono gli istituti regolatori della vita che assorbono e cancellano ogni orma. L'uomo è pressato dalla necessità di correre verso la propria agonia. In don Michele e don Diego non resta, alla fine, che un inutile pianto su se stessi che fanno parte, o meglio, hanno fatto parte del mondo che esaspera la vita per lasciar posto solo alla morte.
Diego è il vero eroe del romanzo. Può ricordare certi personaggi di Ibsen. Può essere vicino al costruttore Solness. Ma anche là, nel drammaturgo nordico, siamo di fronte alla crisi di una fase storica della borghesia, la quale cade sotto gli stessi templi industriali che aveva costruito.
Nel romanzo di Zizi la corsa vorace del tempo è la molla che trasforma, avvolge e travolge. Tutto passa. La vita chiede solo affanni. In questo senso balzano tutti gli altri personaggi del libro. Anna, la madre dolorosa è certo una delle figure femminili più alte della narrativa sarda. E la disperazione e la rassegnazione. Il figlio malato in modo irreversibile l'annienta e la esalta. Dentro la stanza ovale dove si chiude per sfogarsi si addormenta. E come se torni all'interno di un grande utero che può essere materno oppure costituire il mondo stesso.
Paola, la bellissima dei fratelli Are, è personaggio irrequieto. In fondo senza amore e senza pace. È quella che vive più intensamente il dramma della famiglia. Intuisce la caduta e prova per il fratello Diego grande tenerezza e comprensione. Il castello diviene deserto come il mulino, come la notte, come le strade di Nuoro su cui si alzano ormai i palazzi di Ghenesse e degli altri faccendieri. Si alzan tanto da opporsi alla bellezza e all'austerità del castello che deperisce.
Quest'ultimo romanzo di Zizi è narrato in terza persona. Ed è giusto, la prosa vuole essere obiettiva, procedere quasi fatalisticamente. Tanto è vero che lo scrittore non si allunga nelle descrizioni. Tutto converge paradigmaticamente nel gorgo del dramma. Che è storia di un momento particolare del processo sociale nuorese. Anche qui la città è sempre presente con i suoi rapporti e relazioni. La notte e il giorno si inseguono continuamente. Ma più che altro è la notte che prevale e rende la vicenda più tragica e umana.
L'agonia del mondo: dice lo scrittore. Ma come? Come fatto dialettico rispetto alla vita, come azione rispetto al pianto. L'alternativa tra morte e vita domina anche questo romanzo. Ma ciò non porta anche ad una considerazione che preme in noi, persone di oggi? Non è forse la perdita del senso della morte che non ci fa più capire e amare la vita?
Santi di creta nel suo vasto tessuto può avere anche punti non del tutto risolti sul piano letterario e poetico. Può darsi. Ma è certo uno dei libri più singolari nel panorama narrativo odierno proprio per la complessità delle problematiche che propone. È un romanzo aperto. Il seguito possiamo essere anche noi con i nostri dolori e illusioni; noi, dico, così sperduti e incerti in questo vasto mondo che non riusciamo a capire come si dovrebbe. Certo: siamo anche noi «santi di creta», fragili e passibili di andare in frantumi alla minima scossa che i nostri interessi o le nostre ambizioni possono subire.
Il romanzo accentua ancora di più la dialettica umana e la pone di fronte alla realtà stessa che si vive giorno per giorno.
La narrativa di Zizi è sofferta e fa soffrire; è atto d'amore verso il prossimo e invito ad amare. Senza amore e dolore non può sussistere neanche vita. Il resto è illusione che prima o poi cade come tutti i «santi di creta».
Siamo di fronte a uno scrittore post-moderno? Ad un ermeneuta che ci porta verso il neo-pragmatismo di un Rorty? E di fatto non è, forse, lo scrittore delle contingenze epocali, delle ironie e della solidarietà umana?
Devi accedere per poter commentare.


