Come il giovane Cocco Ortu (futuro guardasigilli del governo Zanardelli) anche il giovane Bacaredda ebbe Mazzini nel cuore (parte prima)
di Gianfranco Murtas

Il genitore aprì la strada al figlio e, buon educatore, gli trasferì anche alcune idealità civili che al giovane consentirono sempre di combinare umanesimo libertario e spirito di patria. Quelle idealità dovettero essere d’impronta repubblicana e mazziniana. Senza espressioni pubbliche, senza enfatici proclami, s’intende, ma certo è da immaginare rivelate nel ragionar familiare lungo l’accompagnamento formativo del futuro sindaco nato nel cuore di Stampace appena poche settimane prima che in Roma vedesse la luce l’eroica Repubblica costituzionale di Mazzini e del Triumvirato, la Repubblica vanamente difesa da Garibaldi e per la quale offerse la sua vita, soltanto ventiduenne, Goffredo Mameli.
Vado per suggestioni, lo dichiaro subito, in questo primo inoltro nel tanto di politico – valori, aspettative, partecipazione – possa aver segnato l’esperienza adolescenziale e giovanile di Ottone Bacaredda. Suggestioni che non sono documento storico ma che pure dal documento storico e dalle documentate situazioni di vita prendono il via e traggono legittimazione. E già mi immagino quale impatto anche emotivo possa aver esercitato su Ottone Bacaredda appena rientrato a Cagliari dalla lunga permanenza genovese – lui ormai 26enne, giovane avvocato all’esordio professionale, dopo la rinuncia all’ufficio delle dogane conquistato per concorso, ma già sposato e padre di un primo bimbo – quel grande parallelepipedo scolpito dal romagnolo (di sangue repubblicano) Sisto Galavotti e collocato, appunto nel 1876, al centro del camposanto antico di Bonaria, il parallelepipedo recante in rilievo la rappresentazione della drammatica scena della caduta della Repubblica: Enrico Serpieri e gli altri costituenti assediati dai soldati di Carlo Luigi Napoleone (prossimo Napoleone III), tutti effigiati con le stesse sembianze del loro presidente… La Repubblica Romana gemella ideale, per la temporalità del suo boccio poi soffocato, del prossimo sindaco della maggior città della Sardegna. Chissà, una repubblica conosciuta per gli avanzatissimi principi ispiratori – dal suffragio universale alla proscrizione della pena di morte e di confisca – che ben avrebbero potuto illuminare alcuni dei primi scritti di Bacaredda sia come pubblicista che come candidato all’accademia giuridica e, poi dopo, da docente in cattedra… Si pensi alla polemica, nata clericale e reazionaria su Il Risveglio per tema di infiltrazioni repubblicane o socialiste, che lo colpì nel 1894 – lui sindaco già da un lustro –, alla discussione della tesi di laurea di Ignazio Cogotti (suo prossimo collega in quel di Villacidro “paese d’ombre” e collega anche come rimatore, autore di vivaci sonetti in sardo campidanese) su “Lo stato d’assedio”.
Il magistero dell’esempio: quello di Efisio Baccaredda
Forse non avrebbe riportato direttamente all’apostolato mazziniano, fermandosi invece al De Officiis ciceroniano, quel riferimento repubblicano presente nel necrologio pubblicato da L’Unione Sarda alla morte del commendator Efisio, l’amatissimo padre di Ottone, nel giugno 1894: «Con Efisio Baccaredda si è spento un padre di famiglia esemplare, un ottimo e onesto funzionario, un cittadino virtuoso e colto. Come d’amore fu tutta quanta l’opera sua dal giorno che la mente s’aperse al raggio del cielo del natio paese, all’amore s’ispirò in quest’atto della vita, che, pure essendo l’applicazione di una legge fisica, è destinato in ugual grado a sopperire al bisogno di creare attorno a noi come un’atmosfera di affetti altruistici, continuatrice di quelli che per fatalità di cose vengono a mancare: all’amore s’ispirò in tutti i rapporti, che s’aggrupparono attorno a quella società, che, con frase antica e sempre nuova, fu appellata seminario della repubblica».
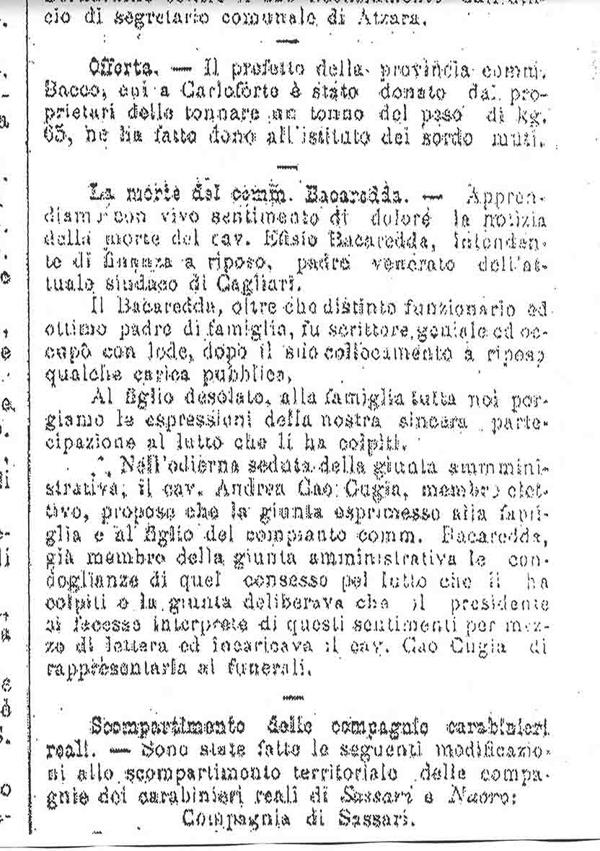
Certo è però che la fama di repubblicano aveva accompagnato a lungo quell’Efisio Baccaredda – lui con due c, come gli ascendenti e i collaterali e, saltata una generazione, i discendenti – che, per essere impiegato governativo del Regno di Sardegna prima, del Regno d’Italia poi, ovviamente corretto e leale verso le istituzioni monarchiche si sarebbe sempre mostrato. Un’eco leggera e discreta della giusta strada percorsa, fra i doveri dell’ufficio e le ansie ideali si ha in una nota domestica, datata forse 1884 e si direbbe testamentaria, dell’anziano funzionario delle Finanze erariali (a me favorita dalla famiglia che amerebbe recuperare, del proprio avo, il profilo più completo possibile): «Io mi mantenni col lavoro come importava la mia posizione. Tentai i possibili risparmi e i miei impegni osservai con rigore per conservare quel pochissimo che col correre del tempo formasse un gruzzolo per deporlo in mani del figlio. Ho soggezione a dire questo dopo essere stato assiduo faticatore! Abbiamo conservato una casa modesta in buona posizione dove io sono cresciuto e vivo ancora. Avrei voluto migliore la proprietà se mi fosse stato possibile di guadagnar di più restando fermo nel proprio paese senza viaggiare di continuo come occorreva nel passato in località disagiate e con spese gravi per adempiere ai doveri impostimi. A forza di stenti si pervenne a non avere bisogno di nessuno, sempre orgoglioso di vivere come era possibile senza prestiti, neppure di un soldo: questo pure è un mio vanto. E’ a mia moglie che devo il più che ho potuto conservare: è opera sua. La buona volontà, il lavoro e l’amor proprio sono stati il mio gran capitale. Io ho lavorato assai ma mia moglie più di me: non sarei diventato vecchio senza di lei e nelle pene sofferte fisicamente e moralmente questa giustizia è dovuta a una donna savia e affettuosa.
«Se si pon mente a tutto non occorre di lagnarsi gran fatto. Si è vissuto senza disdoro, non confusi con gli abietti e avendo una reputazione che il mio povero padre se ne orgoglierebbe. Il figlio ha mantenuto le sue orme ed è ciò che più mi è caro. Io avrei potuto fare una carriera più pronta ed anche forse più gradita ma non ci fu maluccio se lascio il posto, dopo 43 anni di onorevoli servizi, d’intendente di finanza, con missioni laboriose e difficili, adempiendo un dovere lungo e scabroso, nominato dal governo, io che fui riputato repubblicano, rispettato ed anche stimato, nonostante la carica piuttosto odiosa, nella provincia in cui ebbi a governare finanziariamente, cosicché mi vidi fregiato di onorificenze e di lettere onorevoli, che possa chiamare guadagnate col lavoro».
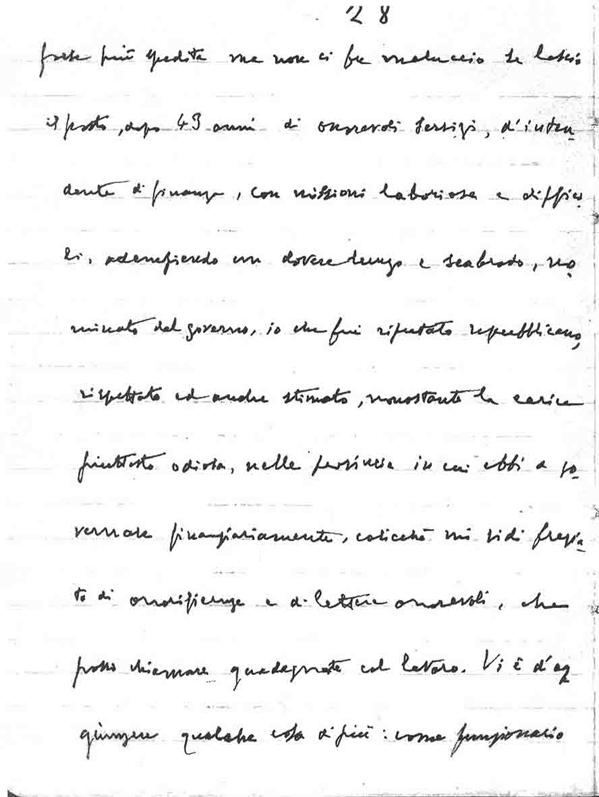

Sassari 1848 e anni seguenti
C’era stata, nei primissimi anni di vita di Ottone, una residenza sassarese di due-tre anni, in scavalco di decennio e qualche frequentazione repubblicana, più o meno ideologizzata, è possibile che il papà, il trentenne Efisio Baccaredda, l’abbia coltivata proprio in Sassari. Fra il 1849 ed il ’50 certamente la memoria degli avvenimenti segnati dalla costituzione – insomma dallo Statuto albertino – e da quanto s’era ad essa collegato era freschissima. Sì, lo Statuto aveva acceso, in città, soprattutto gli spiriti monarchici più sensibili al liberalismo civile: si riformò allora la toponomastica (piazza Carlo Alberto, piazza la Costituzione, strada della Costituzione, contrada Azuni…), si sottoscrisse per un monumento al re “magnanimo”, s’invocò la formazione di una Guardia Civica, si condivise festeggiando «pane, carne e minestra per tre giorni in tre diversi punti della città», come ricorda Enrico Costa nel suo Sassari, tumultuosamente si cacciarono i gesuiti detti “cappelloni”… I mesi e le settimane della sfortunatissima (a parte Goito e Peschiera e qualche altra battaglia) prima guerra d’indipendenza accesasi dopo la cacciata austriaca dai milanesi di Carlo Cattaneo e con la partecipazione di numerosi volontari anche isolani, furono la stagione di successo (e di contrasto) del tribuno Antonico Satta, un sassarese tornato in patria dopo aver molto viaggiato per l’Europa, il quale diffuse allora «Idee di socialismo, di comunismo, e forse ancor di repubblica», creando così, attorno al nuovo circolo Nazionale, una certa opinione: ci furono allora dimostrazioni piuttosto tumultuose a suo favore e contro quanti, dell’establishment politico-amministrativo e militare, tendevano a zittirlo e riuscirono infine a fermarlo decretandone, almeno per qualche giorno, la cattura e la detenzione… Una vicenda che saltò il mare, giungendo a Torino, a Palazzo Carignano, ed impegnò, in più sedute, deputati come il Sulis, il Siotto Pintor, il De Castro e lo stesso ministro dell’Interno chiamato a spiegare…
Le subentranti vicende della Repubblica Romana, lungo il primo semestre del 1849, ridettero voce ad Antonico Satta e ad altri con lui, combinando elementi d’acceso anticlericalismo od … antipiismo a suggestioni repubblicane che i nomi associati di Mazzini e Garibaldi da soli potevano suscitare anche in chiave antipiemontese, giusto a mezzo secolo di distanza dalla cavalcata tutta sarda dell’Alternos Gio.Maria Angioy… E’ certo – lo ricorda il Costa citando la Gazzetta Popolare – che all’inizio dell’anno, forse per raffreddare l’ambiente, erano stati trasferiti a Sassari diversi impiegati pubblici cagliaritani. E’ possibile, probabile anzi, che nel novero fosse anche Efisio Baccaredda, che a Sassari comunque arrivò allora. Se così, chissà quali stati d’animo, magari anche contraddittori, avrebbero preso il giovane funzionario di sentimenti repubblicani, allora recante la qualifica di “scrivano” assegnato alla Sezione del Magistrato d’appello…
A proposito. Capita giusto a questo punto, nel mezzo del racconto delle predicazioni del Satta, della contestazione dell’arcivescovo Varesini (il piemontese che fu uno dei più tenaci avversari di Giorgio Asproni proprio allora all’esordio della sua carriera politica postcanonicale!), ecc., una nota di Enrico Costa sul Consiglio d’appello. Scrive l’autore delle duemila e passa pagine di Sassari: «Col 31 dicembre del 48 erano cessate le attribuzioni e giurisdizione del Magistrato della R. Governazione. Il Municipio, in data 23 febbraio, partecipa che: “fin dall’erezione e nomina della Sezione d’appello in Sassari, questo pubblico diè segno di esultanza e contentezza per la sanzione di S.M.; e così fu per l’installamento del medesimo col solenne giuramento che ebbe luogo in forma pubblica la mattina d’ieri […]. Il Municipio di Sassari, per l’eccelso dono di questo tribunale, munito di vasti poteri, prezioso frutto delle generose e libere istituzioni che ci governano, ha determinato di segnarlo, rendendone grazie all’Eterno con un solenne Tedeum nella Cattedrale, con intervento delle autorità ed ordini accademici, in una mattina della prossima settimana".
La città contava al tempo su un rinnovato Consiglio comunale con sindaco Giacomo Deliperi (di nomina regia) ed apprese della disfatta di Novara e dell’abdicazione di Carlo Alberto a favore del figlio primogenito Vittorio Emanuele con qualche ritardo, ma presto si adattò allo stato di fatto... Qualche ritardo si registrò anche, per averne comunque il risultato, nella formazione di una compagnia di bersaglieri nazionali, la qual cosa accompagnò l’applicazione dell’indulto regio che liberò allora dal carcere l’Antonico Satta il quale, escluso dalle liste elettorali, salpò per Genova per dirigere un giornale repubblicano dal titolo Italia e Popolo. Rientrato due anni dopo a Sassari finì male per lui e peggio ancora per un suo occasionale oppositore che, in un incontrollato faccia a faccia, giunse a perdere la vita…
La Sassari vissuta da Efisio Baccaredda con sua moglie Efisia Poma e il piccolo Ottone era una città vivace, di contrasti fra clericali e liberali di varia sensibilità, di progressisti e conservatori come i decenni a seguire avrebbero meglio definito le forze in campo. Quando, nella primavera del 1850, Pio IX fece ritorno a Roma da Portici (e Gaeta) e l’arcivescovo Varesini intonò un nuovo Tedeum, il Consiglio comunale e il resto delle pubbliche autorità marcarono la propria indifferenza astenendosi da ogni presenza ufficiale… Reagì il presule, con una circolare indirizzata al suo clero, negando efficacia alla circolare Siccardi sulla abolizione del foro ecclesiastico, tanto da far scattare contro di lui, dopo una perquisizione domiciliare, un mandato d’arreso. E agli arresti l’arcivescovo restò per un mese, condannato infine dal Magistrato di appello.
Né i contenziosi furono allora soltanto ideologici, ché l’agenda della pubblica sicurezza andò registrando ogni giorno nuovi delitti. La carenza di occasioni di lavoro esasperava la tensione sociale favorendo gli sfoghi contro le persone come contro le proprietà… Per contro, in positivo, esordì allora la banda musicale cittadina, furono rinnovati (con speciale autorizzazione arcivescovile) i grossi ceri per la discesa dei candelieri (prima eran torri di legno), soprattutto ci si preparò come fu possibile a un’ondata colerica dei cui primi focolai si ebbe notizia da Marsiglia e dal nord italiano… Suffragato da mille messe in duomo e altrove fu allora il re Carlo Alberto deceduto in Portogallo e nel cui nome si compattarono i legittimisti locali, si sventò lo smantellamento dell’ateneo che era stato considerato cosa fatta… e si cominciò finalmente a pensare di spurgare il porto di Torres e a costruire il nuovo carcere (quello di San Sebastiano, data l’indecenza strutturale di quello vetusto di San Leonardo).
Tanto altro, ovviamente, avrebbe registrato quel passaggio di decennio e di cinquantennio, e Costa non avrebbe mancato di farne la lista: dai maggiori controlli sui giochi d’azzardo all’avvio delle corse giornaliere della diligenza fra i due capoluoghi dell’Isola (esercizio Senno-Manunta), dai nuovi cedimenti della parrocchiale di Santa Caterina, cinquecentesca e gesuitica, per cui si insistette si andasse a demolire (fortunatamente senza averne allora risposta) al rilancio della Guardia Nazionale con una nuova dirigenza, ecc. Il colera permaneva come minaccia sullo sfondo, poi sarebbe esploso rabbioso… Nel 1854 Garibaldi avrebbe visitato la città, alloggiando alla Locanda d’Italia, ma intanto i Baccaredda avevano lasciato l’Isola… e preso casa a Ventimiglia.
Ventimiglia, il Piemonte e nuovamente Sassari
C’era dunque, a proposito del Generale e di Ventimiglia, la Liguria, la Liguria repubblicana, la Liguria che aveva avuto una storia repubblicana, e ancora la Liguria di Mazzini genovese e di Garibaldi nizzardo. Ed in Liguria, a Ventimiglia – a meno d’un’ora di treno da Nizza –, i Baccaredda vissero appunto nei mediani anni ’50, diciamo nel 1854-55, quando per Ottone cominciarono le iscrizioni alle scuole primarie e, sulla scena pubblica, poté considerarsi ormai consolidatasi la fusione perfetta: dai collegi elettorali isolani – pur nel ristrettissimo suffragio solo maschile e censitario – alcuni importanti uomini, riuscendovi oppure no e con frequenti candidature plurime, cercarono allora di portare a Palazzo Carignano le brucianti istanze delle lontane province. Fra essi, per dire soltanto dei progressisti e dei repubblicani, Giovanni Battista Tuveri e Giorgio Asproni (quest’ultimo, non a caso, eletto anche a Genova, non soltanto a Nuoro).
Sì, è da dirlo perché sono le stesse confidenze fissate su carta da Efisio Baccaredda ad autorizzarcene. Non fu mai contraddetto quello spirito repubblicano – non ideologico certamente, ma sentimentale, volto forse al fascino della tremenda rivoluzione dell’89 magari mischiato all’eco, già richiamata, dell’impresa dell’amato Alternos – ed è qui da immaginarsi cosa e quanto della democrazia di matrice mazziniana abbia viaggiato nella mente del papà di Ottone il futuro sindaco di Cagliari.
A Ventimiglia come verificatore presso la Direzione (fiscale) di Nizza, ad Alessandria poi e, forse con qualche salto, a Vercelli – la Vercelli del santo vescovo cagliaritano Eusebio –, al tempo della formalizzazione costituzionale dell’unità d’Italia, con ruoli di maggiore responsabilità nelle gerarchie burocratiche, in quanto segretario dell’Amministrazione delle contribuzioni dirette… ecco le residenze degli anni ’50 dei Baccaredda.
Avrà contato, nella permanenza alessandrina, il rimando di memoria ai famosi e sfortunati moti del 1821, quelli promossi dal Santarosa e momento di una più larga agitazione europea contro l’assolutismo, coinvolgente la Spagna, il Portogallo, il Regno di Napoli? Avrà contato, allora e dopo, fino alla residenza vercellese, il clamore prodotto dal passaggio (nel 1860) di Nizza alla Francia, avrà contato la dolorosa protesta di Giuseppe Garibaldi privato della sua patria natia, avrà contato l’argomentata posizione di Giuseppe Mazzini in difesa della italianità della Sardegna, anch’essa posta in pericolo dalle segrete transazioni diplomatiche del conte di Cavour con l’imperatore Napoleone III a Plombières? Come saranno entrate – ma è da pensare per certo che siano entrate – preoccupazioni e migliori aspettative nell’animo della famiglia, del padre come del figlio ormai inoltrato alla sua adolescenza?
Tornarono in Sardegna, nel 1863, i Baccaredda: Efisio, Efisia, Ottone. Efisio ancora innalzato nella gerarchia dell’Amministrazione finanziaria, adesso con il grado di primo segretario di 2.a classe, Efisia perfetta conduttrice e custode delle armonie domestiche, Ottone ormai quattordicenne e, dopo il ginnasio, pronto per il liceo.
Non era cresciuta granché la città, in quel decennio di lontananza per le migrazioni in continente: due-tremila abitanti in più, adesso intorno ai 26-27mila raggruppati nei quartieri tutti intitolati ai santi del cielo: San Donato e San Sisto, San Nicola (dov’è la cattedrale), Sant’Apollinare e Santa Caterina (Catterina)… Ma intanto l’unità d’Italia, compiutasi con azioni di guerra e di democrazia plebiscitaria, certamente aveva inciso.
Il colera aveva più che decimato la popolazione, in città e nei centri più vicini erano state ben oltre quattromila le vittime, secondo alcuni perfino sette od ottomila… impossibile non considerare la violenza dell’evento. Innumerevoli i benemeriti, sanitari (anche cagliaritani, saliti apposta a Sassari a dare una mano) e religiosi, monache e militari che si adoperarono per alleviare le sofferenze (in contemporanea, nell’ondata genovese, soccombette in continente anche don Antonio Baccaredda, zio di Efisio e prozio di Ottone).
Era entrato in funzione, intanto, il telegrafo, con gran soddisfazione soprattutto del ceto commerciale, s’era data altra regolamentazione efficientista il Battaglione mobile della Guardia Nazionale, s’era deliberato il nuovo mercato (inaugurato nel 1863), s’era messo mano ad alcuni lavori pubblici come l’allargamento dei giardini pubblici e delle passeggiate verso l’università e s’erano attivate le pratiche per l’impianto di uno stabilimento dei bagni, s’era inaugurata la Camera di commercio e progettata l’illuminazione a gas delle strade nonché la rete del nuovo acquedotto… Naturalmente non erano mancati gli abbellimenti patriottici: deliberati dal Consiglio comunale i busti di Cavour e Garibaldi – del Garibaldi ancora vivo e vegeto! – e, con speciale sentimento cittadino, di Domenico Alberto Azuni. Onorati con una lapide nello scalone municipale i morti di colera, si fondò proprio allora, ad iniziativa di Giuseppe Giordano – un pubblicista di fede tutta repubblicana – il Circolo degli impiegati… Non erano neppure mancate, però… a bilanciare, le visite principesche, quelle di Umberto ed Amedeo…
Erano ancora a Sassari i Baccaredda quando si votò, nell’estate 1864, per il rinnovo del Consiglio comunale e fu quello un rinnovo piuttosto rumoroso, accompagnato da contestazioni tali da provocare l’arrivo della forza pubblica e il rullo dei tamburi. Così la mattina, mentre la sera altri attraversarono la città con le bandiere tricolori e il grido di “viva lo Statuto, viva il Re, viva la Guardia Nazionale”.
Nuove agitazioni si registrarono anche l’indomani, al mercato, per contestare il pagamento della tassa del suolo, e nuovi arresti furono disposti, fino a quaranta… Arrestati anche, al loro ritorno da Torino dove erano andati a perorare la causa della riforma del dazio consumo, lo zappatore Antonio Luigi Mura Favarrustu ed il frate-poeta-pittore di sentimenti liberali Angelo Maria Garzia. Dopo mesi di detenzione tutti quanti sarebbero stati scarcerati o mandati assolti dal giudice. Interessante, a tal proposito, il giudizio di sintesi che il solito Enrico Costa avrebbe successivamente espresso nelle pagine del suo Sassari: «Fu, ed è sempre destino di Sassari, di ascrivere ogni movimento popolare a delirio mazziniano o a febbre conservatrice. Il dazio sul vino era stato un pretesto per sfogare antiche bizze di partito, o malumori per mene elettorali. Diversi opuscoli furono pubblicati in proposito e sempre disparati fra loro. Il partito radicale, in uno scritto col titolo: i moderati turbolenti, tentò dimostrare come le piazzate del 22 e 23 agosto fossero frutto, forse in parte non previsto, di mene moderate. Il cav. Passino, nelle sue Pagine Storiche, volle invece che le piazzate si dovessero ai mazziniani, i quali volevano cogliere il destro per piantar la repubblica. Egli scrisse: fu quello un arcano che diede agli ignoranti cospiratori fama incontrastata di abilità rivoluzionaria».
E più oltre: «Le cause […] bisognava ricercarle nel sindacato, nel consiglierato, nel cozzo tra vecchie e nuove idee, nei rancori antichi, nella nervosità della Società di Mutuo soccorso che subiva continue trasformazioni, nei puntigli degli operai in disaccordo fra loro, nella tenacità dei conservatori, nell’impazienza dei radicali, e in quel bisogno continuo di agitarsi che è nella natura dei sassaresi».
Non significherebbe improprie o incongrue (e abusive) espansioni interpretative affermare che il clima sociale e quello politico della Sassari postunitaria possa aver tenuto desto, in casa Baccaredda, il sentimento repubblicano paterno ed abbia cullato una certa prossimità ideale del giovanissimo Ottone (liceale dell’Azuni proprio allora derivato in parte dal Canopoleno) ad un mazzinianesimo dichiarato, sentimentale e di principio, che, in tempi di monarchia, poteva connotare, come le macchie d’un leopardo, l’Italia di Vittorio Emanuele. Se ne sarebbe avuta la riprova negli anni tornati cagliaritani – quelli dal 1867 al 1871 –, quando cioè in alcune prove giornalistiche del giovane ormai universitario l’argomento sassarese, e mazziniano-sassarese, sarebbe tornato nel pubblico dibattito.
Che altro? La partecipazione di Ottone Bacaredda, quale collaboratore assiduo e, nello sviluppo dei suoi temi, certamente incisivo, alle produzioni di quotidiani come Il Corriere di Sardegna e L’Avvenire di Sardegna: testate che, pur non repubblicane, o nel solco dottrinario del repubblicanesimo, alle correnti della democrazia italiana, incluso il mazzinianesimo, incluso il radicalismo presocialista ed incluso dunque il garibaldinismo, aprivano le loro pagine, accompagnate inevitabilmente dai profili biografici dei loro direttori, da Giovanni De Francesco a – nientemeno – Giovanni Battista Tuveri. Né soltanto a quei giornali si sarebbe indirizzata la collaborazione redazionale di Ottone, ma anche al periodico lanciato all’inizio del 1869 dagli studenti universitari di Cagliari: A Vent’anni!, il settimanale di chiara impronta liberale – o liberale in direzione della democrazia – che, nell’anno in cui a Napoli si tenne l’Anticoncilio del Ricciardi (in manifesta ed oppositiva risposta al piino Concilio Vaticano I) e in quello seguente che s’esaltò con la breccia di Porta Pia, confermò per cinquanta e più numeri un inequivoco indirizzo laico, non tacendo di Mazzini e del mazzinianesimo.
Luci vennero, a tal riguardo, dalla ripresa da L’Apostolato di Catania di uno scritto del Genovese sul “Socialismo” (così il titolo del pezzo uscito il 19 giugno 1870), evocativo di «uno dei temi che più sarebbe utile trattare oggi con profonda e pacata discussione per fare argine specialmente ai funesti delirii, che intorno alla vitale questione ci vengono d’oltr’alpi». Chiaro il riferimento alle agitazioni che avrebbero portato, un giorno neppure troppo lontano, alla Comune parigina.
Da vero rivoluzionario, la sua collaborazione a “A Vent’anni!”
Ma altro ancora, da A Vent’anni!, si potrebbe richiamare: l’editoriale scelto per l’apertura del numero del 17 luglio 1870 (giusto vigilia del voto conciliare sul doppio dogma del primato e della infallibilità pontificia) è a firma proprio di… Giuseppe Mazzini! Titolo originale “L’agonia d’una istituzione”, quello redazionale “Agli uomini dell’istituzione”, con breve accompagnamento: «Questo scritto, come tutti gli scritti del grande esule italiano, splendido per profondità di concetti come per venustà di forma, nobile come la sua anima, robusto come la sua fede, non ha niente di personale, niente che non riveli la calma profonda che nasce dalla profonda convinzione. L’autore svolge un principio filosofico che può applicarsi così ad una monarchia come ad una repubblica.
«Or bene questo scritto che, non ne dubbitiamo, il governo russo farebbe liberamente circolare ne’ suoi stati, e l’Osservatore Romano potrebbe, se volesse, pubblicare impunemente nelle sue colonne, questo scritto in Italia, nella patria dell’autore, nel paese che per ironia si dice retto a libertà, è stato sequestrato dal r. Fisco di Genova.
«Ed ecco come nobilmente Mazzini risponde ai ridicoli sequestri del fisco. Riproduciamo i brani più salienti dell’aureo scritto che a quest’ora ha fatto il giro di tutta quanto l’Italia: “Io scrivo, voi sequestrate. E’ risposta degna di voi. Ma non vi chiarisce essa deboli e incapaci di provarmi in errore?...”».

Un lungo testo, quello mazziniano offerto dalla redazione di A Vent’anni! ai propri lettori, giovani e non giovani, che reca la seguente conclusione (e valga qui rammentare l’ormai prossima nuova carcerazione dell’Apostolo repubblicano: sarebbe iniziata il 14 agosto di quel 1870 per protrarsi due mesi pieni): «Potete voi, infelici, sequestrare la Storia? E s’anche poteste, come l’Islamita, ardere le biblioteche d’Italia, potete sequestrare i marmi e le pietre, pagine eloquentemente mute che insegnano alle nostre città come furono grandi quando furono repubblicane? Le sacre rovine di Roma! I templi e gli edifizi Toscani? I ricordi di Pontida e Legnano? San Marco? Il sasso di Balilla? Le tombe dei primi nostri tra i nostri Grandi? Che! Non v’è fanciullo in Italia il quale guardando attonito ai nostri monumenti e chiedendo del quando s’alzarono, non oda rispondersi dalla madre: ai tempi della repubblica. Non v’è navigante che movendo dalle nostre coste a quelle dell’Oriente Europeo e incontrandosi per ogni dove con memorie e vestigi di colonie nostre, non oda dirsi, se ricerca le loro origini: risalgono alla Repubbliche di Genova, di Venezia, di Pisa…».
Può dir qualcosa, e più di qualcosa, anche qualche passaggio dell’articolo “Libertà!...” che il giovane Bacaredda pubblica sul numero 23 dello stesso 1870 (quello del 26 giugno, quart’ultimo della serie), tutto puntato sul dovere di sgrossare l’idea di patria sollevandola da ogni retorica illiberale, per ciò facendo riferimento a un evento della quotidianità sassarese, da lui lasciata di recente e proprio in tempo per iscriversi, nel 1867, all’università della sua città: «Un bravo giovane, un giovane d’ingegno, una perla di giovane, giornalista, poeta, pittore e soldato dell’indipendenza italiana scrive un bel giorno su pel giornale otto linee di cappello ad una lettera di Giuseppe Mazzini, otto linee tutta poesia, otto linee per di più che, a parte la forma, eccellente quanto a concetto non dicevano nulla di nuovo: perciocché che Giuseppe Mazzini sia un grand’uomo e che molto debba l’Italia a lui non è il primo né il centesimo che l’abbia detto l’ottimo nostro amico sassarese Francesco Rugiu.

«Ma Francesco Rugiu è un giovane come non se ne trovano a dozzine nella giornata; ei si sente ad avere della cosa qua dentro nel petto, come dimostra d’averne nella zucca; Francesco Rugiu scrive nel Progresso di Sassari e mena giù botte santissime, ma non da orbo; ché ei sa dove picchia e sa come picchiare. Le sue sono bastonate vescicatorie; e siccome governo e governanti non sono que’ prototipi di onestà, di accortezza e di liberalismo che vorrebbero farci credere que’ dello sbruffo, è naturale che anche a costoro capitino di tratto in tratto tra capo e collo i complimenti del nostro amico.
«E però Francesco Rugiu non è il beniamino del Prefetto di Sassari: che la fede di battesimo chiama Mezzopreti, ma che la voce pubblica si ostina ad appellare Tutto-prete!
«L’esser prefetto vuol ben dire che s’ha un bravo impiego, ma non importa assolutamente che si debba essere giusti, leali e galantuomini. Tutt’altro! Quindi il signor Tutto-prete, che da un bel pezzo guardava a stracciasacco l’amico nostro, non sa altro che pregare i suoi santi protettori perché gli mandino l’occasione di accoccargliela bella.
«Ecco l’occasione. Francesco Rugiu scrive e sottoscrive le suddette otto linee che non facevano male né pure ad una pulce: il prefetto arriccia il naso; un imbecille qualunque, di quelli che campano la vita facendo la spia, gli sussurra all’orecchio che l’ammiratore di Giuseppe Mazzini è un ufficiale in aspettativa… Gesumaria! Il prefetto è per venir meno dalla gioia: scrivere una lettera di fuoco al ministero, una al comandante militare, una al delegato è cosa di mezzo secondo. Un mese di prigione, un consiglio di disciplina, una destituzione è vendetta abbastanza soddisfacente per un Tutto-prete.
«E detto, fatto. Provvidenza di Dio, come alle volte tu sei governativa!!!
«Dunque da oggi in poi Mazzini è un corbello; l’Italia chi l’ha fatta non è lui un cavolo: l’Italia l’hanno fatta Lanza, Tutto-prete e i mardochei di Sassari… Così è, e così va detto: e chi non ci crede, dagli addosso come a un nemico della patria, e chi scrive il contrario, caccialo a pigliare il fresco in gattabuja…
«La libertà noi ce l’abbiamo… ma non è libertà di dozzina. Oibò! libero il governo di succhiarci il sangue, libere le autorità costituite di maneggiare per diritto e per traverso la bocchetta del comando, liberi i pagnottisti d’inneggiare alla pagnotta e di vituperare gli avversari… ma ricordare i nostri babbi che hanno avuto del senno, e che ne hanno ancora? insegnare i loro nomi alla moltitudine, e propagarne i profondi pensieri? mostrarsi vivi e vitali a questi lumi di luna?... Gonzo chi ci casca!
«Ma poiché tutto il male non viene per nuocere, noi la mercé di questa libertà da burla che godiamo, e del signor Tutto-prete chiamato a tutelarla presso i nostri fratelli di Sassari, abbiamo avuto il piacere di stringere la mano di un novello amico, e di acclamare insieme alla vera libertà… di là da venire!».
Dunque Ottone Bacaredda repubblicano mazziniano? Concluderne in questo senso sarebbe eccessivo. Potrebbe invece convenirsi che, così come molti altri dell’ecumene liberale della prossima stagione zanardelliana e/o giolittiana – come lo stesso Francesco Cocco-Ortu, socio di Antonio Ponsiglioni e giovane in formazione soltanto pochi anni prima di Bacaredda (sei anni appena li dividono) – hanno pascolato fra quei larghi campi delle idealità democratiche, o liberaldemocratiche e radicali che dai tempi di Porta Pia hanno coperto l’intero postRisorgimento, sempre più invero “adattandosi” al sistema liberalmonarchico ma introducendo in esso, a compensare l’indebolimento di un’istanza istituzionale tanto generosa quanto creduta intempestiva, larghi elementi di riforma civile e sociale. Così nell’allargamento del suffragio come nella laicità dell’ordinamento scolastico, ecc. Non senza contraddizioni, fin dalla svolta del 1876, dal passaggio delle leve governative e di maggioranza parlamentare dalla destra storica postcavouriana alla sinistra depretisiana e poi crispina…
Aiuta a comprendere meglio questo “stato dell’anima” che, limpido nella sua esternazione, non si fa ideologico (e tantomeno dottrinario) un articolo editoriale che il ventunenne Ottone firma in A Vent’anni! già il 12 dicembre 1869, alla ripresa delle pubblicazioni della rivista dopo una sospensione di cinque mesi (e quando anche potrebbe datarsi l’avvio dell’attiva collaborazione con la testata). Titolo: “Ai nostri amici”. Si tratta di… confessarsi, di dichiararsi – come redattore, o nuovo redattore o collaboratore – al pubblico dei lettori, in specie forse ai suoi coetanei: il giornale proporrà soprattutto riflessioni sull’istruzione pubblica, di generale interesse, così come sull’attualità sociale vista magari con la lente della satira come l’intendeva il Giusti, e in quanto alla politica…

«La politica non sarà cibo prediletto della nostra mensa, ma solo un manicaretto. Per la politica ci riconosciamo troppo giovani; troppo buoni per poter contemplare senza fremere le infamie, le immoralità, lo sperpero del danaro pubblico… e quando nella politica saremo tratti dalla forza naturale delle cose, non ci daremo alla destra né alla sinistra, ma ci schiereremo sotto il vessillo del Vero; secondo la ragion sociale giudicheremo dei fatti politici; e dove per avventura ci si chiedesse del bisticcio guerrazziano: “si stava meglio quando si stava peggio!” non indugieremo a rispondere: - ieri si stava peggio, domani si starà meglio; l’oggi è un periodo di transizione del quale ci dobbiamo giovare per fare che questo domani non ci trovi a balia o nel curricolo a chiappar le mosche…».
Si tratta di una dichiarazione che non può ridursi ad un indistinto qualunquismo, al contrario. Se vista in relazione ad altre esplicite prese di posizione dell’articolista, la sua affermazione rivela un indubbio pragmatismo, quasi un agnosticismo politico-ideologico che non è però valoriale; introducendo la categoria della «transizione», evidenzia peraltro il distacco da un passato del quale ancora avverte l’imprigionante affanno e delinea un futuro che non può non essere sulla linea della democrazia come maturazione di un liberalismo quiritario e classista.
Fa tutt’uno con quest’ansia chiamala progressista il desiderio di una unità regionale, coinvolgente entrambe le province isolane e tanto più le giovani generazioni presente-e-futuro dei territori. E ne trae motivo di riflessione da sgradevoli cadute rilevate nelle miopi note di certa stampa. In “Amor di Patria!...”, uscito il 12 febbraio 1870 Bacaredda rimbrotta con sarcasmo Il Popolano, «giornaluccio sassarese che vanta una tiratura di cinquanta esemplari per settimana, che si vende a 25 cent. il numero, e che deve il debolissimo suo filo di vita tisicuccia alle inserzioni amministrative e giudiziarie della provincia». La colpa del «giornaluccio» sarebbe, a suo dire, uno sbrigativo ed apodittico giudizio anticagliaritano espresso, per di più, con «bastardume» di forma: il tutto per reazione alle considerazioni che dal capo di sotto eran venute circa il carnevale celebrato dall’altro capoluogo. Mentre ben altro occorrerebbe – egli sostiene – al presente e al futuro dell’Isola, sognando «il giorno che i fratelli dei due Capi si stendono a vicenda la mano, e dimenticando rancori pettegoli, ciance da campanile, uniscono in una le loro forze perché una volta trionfi il diritto conculcato»…
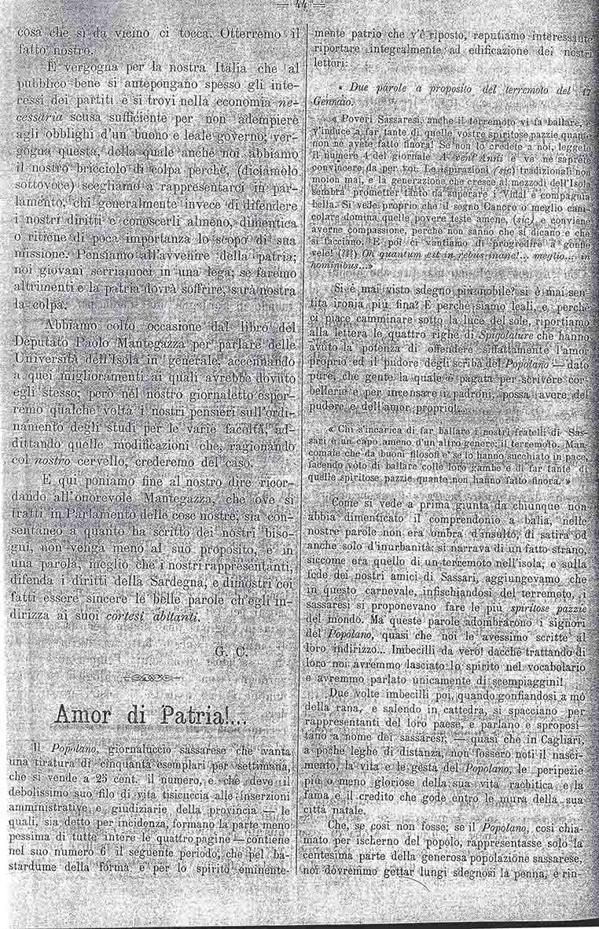
S’è detto: il giovane Bacaredda è gemellato, per calendario di nascita, alla Sardegna “italianizzata” dall’ordinamento postFusione e dallo Statuto albertino, che molto ha promesso e permesso seppure sia di fatto ancora notevole lo scarto con quanto legislazione ed amministrazione (in primis quella finanziaria) – anche la legislazione ed amministrazione successive alle guerre d’indipendenza e alla formalizzazione dello stato unitario, del Regno d’Italia cioè – hanno concesso e concedono. E lo stesso Bacaredda ventunenne non si fa velo alcuno a denunciarlo, a rilevarlo e commentarlo, dimostrando uno spirito sardo che non s’umilia davanti a quello italiano.
Siamo ormai nell’estate del 1870, alla vigilia della storica breccia. A Firenze, a palazzo Medici Riccardi, siede Giovanni Lanza presidente del Consiglio, al casino Mediceo di San Marco Firenze nientemeno che Quintino Sella ministro delle Finanze, nel complesso di San Firenze Cesare Correnti ministro dell’Istruzione… Da un anno e ancora per altri due, quell’esecutivo governa e governerà l’Italia in un passaggio epocale della sua storia. Tutto è difficile, complesso e complicato, ma pare indubbio che nella natura stessa del sistema monarchico siano quei freni che impediscono più rapidi e stabili avanzamenti verso traguardi di giustizia distributiva e democrazia. Ed è quanto rilevano anche molti giovani pur di… buona famiglia, che a Cagliari (come a Sassari) frequentano i corsi universitari. All’opposizione del governo per… statuto d’anagrafe, si direbbe, ma certo anche e soprattutto per la palpabile sofferenza che investe pure i ceti medi, non soltanto il bracciantato delle campagne ed il proletariato delle isole industriali…
Una nuova generazione s’avanza: «Maledizioni al governo d’Italia»
Bacaredda – né è il solo, ma certo è fra i più brillanti – si fa voce della nuova generazione impegnata negli studi liceali ed universitari e consegna alla composizione del tipografo un articolo di fuoco che A Vent’anni! pubblica nel suo numero 24 del 4 luglio. Titolo: “Maledizioni al governo d’Italia”. La prima traccia ch’egli vuol seguire nella sua denuncia è, dunque, nazionale: «in dieci anni dacché col sangue e col denaro si è messo su questo cencioso regno d’Italia, in tante dozzine di ministri unti dal Signore che si sono arrampicati gonfi di superbia e divorati dall’ambizione e dall’appetito […], in così sterminato numero di leggi, di decreti, di regolamenti, che parrebbero fatti a posta per dar da mangiare alle stamperie regie, si arriva al punto che un deputato illustre e venerato esclama in pieno Parlamento: “le popolazioni postergate e calpestate maledicono al governo d’Italia!”…
«I soldati che si fanno martiri d’una tedesca disciplina per essere condotti al macello di Custoza, i marinai che si portano a prendere i bagni a Lissa e fra gli scogli del Mar Rosso, gli impiegati che si vogliono demoralizzare, i preti che si spogliano sino della camicia, i ricchi che impoveriscono le imposte enormi, i poveri cui vien tolto di bocca il tozzo di pane, i maestri che mandano ad accattare – tutti bestemmiano e maledicono il governo, tutti imprecano a quella Camorra che penetrata fraudolentemente nel nostro paese colla rivoluzione, vi si stabilì, e oggi ne è la sola dispotica regina.
«Che importa ad essa che il popolo soffra, si dolga e pianga? basta che Minghetti comperi de’ bravi poderi laggiù in Svizzera, basta che Manabrea mangi lautamente alla greppia dello stato, basta che il famigerato Pironti sia creato conte, che Lamarmora continui ad essere proclamato illustre, che Cialdini abbia un alloggio conveniente, che Brenna e Fambri procurino di far quattrini, […], che una schiera di giornalisti salariati sbattacchi il turibolo sul muso ai suoi padroni, o che s’ha da badare ad altro?
«La giustizia vada a rotoli, il galantomismo sia crocifisso, il senso morale si sciupi, smarrisca la strada il senso comune, l’istruzione si butti in un pozzo – che perciò? la questione è questa: serbar la pancia per i fichi, corbellare il prossimo, scialacquare a rotta di collo i suoi denari […].

«Al giorno che corre una immensa aureola di tasse circonda il capo della nostra madre patria: il suolo che calpestiamo, il cantuccio che ci serve per riposare, il pane che ci sfama, l’acqua che ci smorza la sete, tutto noi paghiamo, e lo paghiamo a caro prezzo – ancora un po’ di questa nostra benedetta pazienza, e ci faranno pagare sino la luce e l’aria che ci danno la vita!
«E poi, gli vedete? salgono la bigoncia alteri e ben pasciuti i baccalari del governo e della stampa, a predicarci le beatitudini del nostro regno, le liberalità che magnanimamente ci largiscono, il progresso che c’incalza, ci soffoca, ci divora!!! Ma certo: e che progresso!
«Ne volete un esempio luminosissimo e palpitante d’attualità? Sentite questa: l’istruzione non è chi non la chiami una cosa santa, una cosa indispensabile perché un popolo s’avvii sicuro ad una meta gloriosa: il governo che non vuol lasciarsi scappar di mano il mezzo più acconcio, più sicuro, più legale per ben guidarlo, il governo che sente altamente di sé e che vuol da senno provvedere all’incremento dei materiali vantaggi dei governati, deve badare sopra tutto alla tutela e allo sviluppo dei loro interessi morali, deve prima d’ogni altra cosa, intendere all’istruzione, renderla, il più che sia possibile, ampia, libera, completa, e comune a tutte le classi di cittadini. E’ tirannide là dove regna l’ignoranza…». E qui ecco esposte le tabelle delle inframmettenze, delle tasse (universitarie) che di fatto colpiscono il diritto allo studio e, alla fin fine, attentano al ricambio generazionale nelle classi dirigenti: «La Camera dei deputati, more solito, si fece una premura di approvare il progetto bonghiano, accogliendo, colle solite ilarità le parole degli onorevoli Salaris, Del Zio, Oliva, Melchiorre e S. Morelli i quali ebbero la soddisfazione di predicare ai porri…».
Cosa c’è da godere di un governo liberalconservatore, reazionario per molti aspetti? «Del resto, a parte il dolore, niuna meraviglia ne destò la votazione del 21 giugno. Tra la guigliottina che nel nuovo Codice Penale il comm. Borsari vuol sostituire alla forca, e tra la legge che fa dell’istruzione una privativa dei ricchi, noi crediamo di scorgere una tal quale correlazione, che può darci un’idea più o meno approssimativa del carattere del governo che ci regge. Anzi diciamo di più: non sarebbe egli probabile che i nostri ministri, se per disgrazia avessero mai letto le poesie del Giusti, si fossero fatti in capo di voler ottenere colla guigliottina ciò che gl’imbecilli del nostro conio vorrebbero veder fatto dall’istruzione…».
E su questa falsariga, introducendo la “specialità” sarda, prosegue la sfrenata polemica bacareddiana sul numero 26 del 17 luglio successivo: “Quod non fecerunt barbari, facient Barberini!...” (non a caso, forse, impaginato di seguito alla nota mazziniana consegnata al catanese L’Apostolato).

Con lo scoppio è l’incipit: «I giorni che corsero dalla prima invasione aragonese al trattato di Londra, con cui si dava alla Sardegna per la millesima volta un novello padrone, sono dalla storia ricordati a caratteri di sangue: guerre, tradimenti, massacri, inquisizione, balzelli, angherie, sopprusi… insomma, tutte le piaghe d’Egitto e quant’altre sono sulla terra flagellarono questa sempre povera isola. Anco la lingua s’imbastardì, sin anco i costumi, e si spense quella fiammella di civiltà che si doveva ai Pisani e Genovesi […]. Pure è sotto la grave servitù spagnuola che la Sardegna vide sorgere per la prima volta dal suo seno le due sue Università pareggiate a quelle di Salamanca e di Lerida; è l’abborrito governo spagnuolo che offrì ai sardi, depressi e dimenticati, il mezzo a raggiunger quella coltura che dianzi dovevano medicare oltremonte ed oltremare». Merito di molti forse – delle Corti Generali, dei filantropi come Antonio Brondo, dei papi come Paolo V – ma «è fuor di dubbio che Filippo III per l’Università cagliaritana, Filippo IV per la turritana, avrebbero potuto, solo che così gli fosse talentato, apporre il loro veto, ed impedire che l’isola si avvantaggiasse di due istituti che cotanto lustro le dovevano poi arrecare», puntualizza Bacaredda. Che valorizza quelle benemerenze per opporle alla neghittosità italiana, o meglio: del governo prima di Torino poi di Firenze. «Toccava al governo italiano, al governo liberale, al governo ristoratore toglierci quel cencio prezioso che gli stranieri ci avevano saputo rispettare!».
Ancora: «La promessa dell’onorevole Correnti non ci pare né più né meno che una di quelle frasi d’obbligo che non mancano mai nelle commedie e sulle labbra di un ministro; e il progetto Bonghi ci dà l’aria di uno di quei tranelli, che se fanno onore all’ingegno dell’inventore, disegnano in faccia al mondo del carattere di esso un profilo per nulla soddisfacente».
Parole chiare: «L’Università cagliaritana, che non può essere fra le privilegiate, dovrà adattarsi a vedersi tolta una facoltà oltre alle altre due in breve tratto di tempo ingoiate dall’orca. Ora, siccome queste soppressioni si fanno per ragioni di alta economia, è a credersi che non quella di matematica, che per verità importa una piccola spesa, ma bensì la facoltà di medicina, che forse è la più numerosa fra noi, sia sacrificata: e bastano a raffermarci nella nostra convinzione le parole pronunciate tempo addietro dallo stesso Bonghi nella sala dei Cinquecento: il corso medico fra noi, si sarebbe potuto dar borse a quegli studiosi che volessero andare altrove ad addottorarsi; parole che dettarono ad un nostro confratello maggiore due sensatissimi articoli. E qui domandiamo noi: a che sarà ridotta l’Università cagliaritana quando due sole facoltà conterà di avere, e poche dozzine di studenti? sarà dessa veramente un’università, oppure una parodia d’Università».
Bacaredda si scatena qui rielaborando da par suo – par di letterato e polemista – il progetto Bonghi «trappola»:
«Articolo 1° - Il governo non vuole inasprire le popolazioni, ma sì le vuol corbellare.
«Articolo 2° - Le Università d’Italia, escluse quelle che garbano a noi ed ai consorti nostri, non si regaleranno del colpo di grazia, ma si faranno morire di male sottile.
«Articolo supplementare – I gonzi (che sono molti!) le beveranno grossa, e noi ci succhieremo in santa pace anche le rendite d’ogni singola università».
La conclusione meriterebbe, per lo studio delle parole adoperate, una riflessione straordinariamente attenta circa quanto essa possa dare di vero della personalità ancora in formazione di Ottone Bacaredda: «lo stare sempre snocciolare elegie sulle sempiterne miserie nostre ci fa male all’anima: abbiamo raspato un articolo, perché certe cose non ci vanno più in giù del gorguzzule: e abbiamo parlato con quanta libertà sapevamo per mettere sull’avvisato e studenti, e corpo accademico, e municipio e deputati. Fra tante disgrazie che ci possono capitare sul groppone, sarebbe forse la più dolorosa il lasciarsi coglionare.
«Noi vorremmo aver preso lucciole per lampioni, e spezzata una lancia contro un mulino a vento… Ma, e se avessimo colto nel segno? se un giorno disavventuratamente apparissimo, che Dio non voglia, profeti? Sarebbe forse una ben magra consolazione il poter dire a noi stessi: ciò che non ci fecero gli spagnuoli ci hanno fatto gli italiani! Basta che, fatici pecore, i lupi ce lo lasciassero dire!...».
Nel tempo di Porta Pia: ancora Mazzini!
Ancora sessanta giorni, appena sessanta giorni… ed i bersaglieri del gen. Cadorna sfondarono Porta Pia. Quello stesso giovane Bacaredda alla vigilia quasi della sua laurea conquistata in un ateneo dalla sorte sempre più incerta, indirizzò a Giuseppe Mazzini recluso a Gaeta ed a Giuseppe Garibaldi in domicilio coatto a Caprera un telegramma con cui, a nome dei suoi compagni, celebrava Roma italiana. Non avrebbero avuto però buona sorte quei messaggi, e se ne lamentò dunque il mittente anche se poi superò la delusione rilanciando in chiave… democraticamente patriottica. Lo fece dandone notizia a Giovanni De Francesco direttore de Il Corriere di Sardegna (cf. n. 226 del 27 settembre 1870). Ne ho già riferito nell’articolo “A.D. 1872, centocinquant’anni fa. Il lutto di Cagliari per la morte di Mazzini. Da allora anche le logge massoniche della Sardegna celebrano, il 10 marzo, l’Apostolo repubblicano” postato su Giornalia lo scorso 9 marzo, ma non sarà vano riproporre il testo di quella lettera:
«Preg. Sig. Direttore,
«siccome Ella scrisse nel suo pregiato giornale, due telegrammi venivano or è una settimana, e propriamente in occasione delle feste popolari, provocate nella fausta liberazione di Roma, inviati dalla gioventù di Cagliari que’ due grandi patriotti, i cui nomi sono un culto ed una religione per quanti sentono di amar la patria, oltre la cerchia di qual si voglia consorteria.
«L’uno di quei telegrammi, indirizzato a Garibaldi, partiva per Caprera, e che vi sia giunto, e quando, e come la è cosa da potersi anche mettere tra le improbabilità; l’altro, quello indirizzato a Mazzini, veniva, per superiore comando, intercettato dall’autorità politica, messo per otto giorni in contumacia, e quindi rimandato donde era venuto, come roba affetta da cholera o da febbre gialla.
«Non è che i commenti possano qui giovare a qualche cosa: oltre che vi hanno dei fatti, i quali, ben reggendo per se stessi alla logica, non possono sopportare commento di sorta.
«La quota pertanto del dispaccio, che mi venne oggi stesso rimessa da quest’ufficio telegrafico, io credo interpretar il desiderio di tutti i miei amici e colleghi, devolvendo a beneficio dei caduti all’assalto di Porta Pia.
«Così potremo dopo tutto non dolerci che un’azionaccia ne abbia dato la ventura di fare una buona azione».
Il messaggio all’Apostolo era stato essenziale: «Gioventù sarda, festeggiando Roma capitale, dolente vostra cattività, manda primo apostolo libertà italiana una parola di speranza».
La stampa, anche quella sarda, avrebbe dato presto notizia che nel decreto d’amnistia firmato da Vittorio Emanuele II fosse stato incluso anche il nome del Genovese. Il quale, per parte sua, rifiutando il beneficio, avrebbe scelto per sé di nuovo l’esilio (e quando, meno di due anni dopo, approssimandosi la morte, sarebbe stato in Italia lo sarebbe stato da clandestino, a Pisa, a casa Rosselli-Nathan).
Il periodico cagliaritano La Verità, di chiara tendenza democratica ed anticlericale, nel suo numero del 23 ottobre 1870, avrebbe presentato – raccogliendola da L’Unità Italiana – una lettera dello stesso Mazzini inviata al il giornale diretto dal cagliaritano Vincenzo Brusco Onnis: «… Sono libero. Hanno riaperto la porta della mia prigione, e sono escito. Respingo naturalmente da me l’amnistia. Mi sento puro di colpe verso il paese, unico padrone, che io riconosca, e la clausura regia non è merce per me… Non accettando l’amnistia, non intendo giovarmi dei suoi benefici. Ripiglierò dunque tra pochissimi giorni, volontario la vecchia via dell’esilio. Dolente ma sereno e fermo nella mia fede e certo che i grandi fatti d’Italia devono un dì o l’altro compiersi tenderò da lontano l’orecchia a udire presto finch’io viva, ed accorrere, se dalla sacra, comunque or profanata Roma o da un angolo qualunque d’Italia, sorga una voce che accenni a generosi fatti e rinnovelli la rotta tradizione di libertà repubblicana».
A fronte di tanto spirito etico, ed etico-civile, da cui solo potrebbero derivare applicazioni democratiche, la deputazione sarda a Firenze dopo che a Torino, e così, fra breve, anche a Roma non sembrò capace di muoversi con il necessario rigore in difesa ad un tempo degli istituti partecipativi e degli interessi materiali dell’Isola. Il ristretto suffragio chiaramente condizionava ogni slancio e la galassia parlamentare, con la sua frantumazione, impediva alla rappresentanza di strappare udienza all’esecutivo manovrante i bilanci. Fu questo anche il giudizio del giovane Bacaredda analista o polemista di A Vent’anni!: «Siamo schietti – scrisse il 13 marzo 1870 nel fondo “I Deputati Sardi” –: quali sono i deputati sardi? che hanno fatto essi mai per noi? quante volte la loro voce, e opportunamente, ha tuonato nell’aula dei 500? quale influenza hanno essi sull’animo dei ministri? quali aderenze fra i loro stessi colleghi? e, cosa che supera ogni scandalo, quante volte per ogni legislazione furono visti occupare i loro seggi di velluto?».

Sarebbe stato parlamentare lui stesso, Ottone Bacaredda, giusto trent’anni dopo dacché fissò e diffuse questo suo giudizio e forse, per esperienza personale, avrebbe potuto confermare e però anche coinvolgere se stesso nella riflessione critica. Scrisse nel 1870: «Da vero che noi, giovani come siamo, allora che tronfii o spensierati vediamo passeggiare per le vie, scorrazzare a caccia le campagne, viaggiare per diporto coloro nei quali gli elettori riposero tutta la loro fiducia ed il paese le redini de’ suoi destini; e sappiamo la Sardegna subissata d’ingiustizie, bersagliata di vituperi, ci sentiamo salire le fiamme al volto, e domandiamo: se i nostri padri, i nostri fratelli, i nostri amici che hanno il diritto del voto (diritto che in un paese libero una legge liberale a noi non accorda ancora!), corsero all’urna per mettere sul candelabro di cotali uomini, se questi vollero togliersi da senno a rappresentanti, e se da essi sperarono mai bricciolo di bene.
«E la risposta si è: che i nostri padri, i nostri fratelli, i nostri amici sconsigliatamente disertarono le urne, lasciandole in balia di que’ pochi, che o ignoranti, o ingannati, o compri le fanno servire a totale profitto degli ambiziosi o degli interessati, i quali sotto l’involucro inviolabile di deputato vogliono empir l’epa o volar alto».
La conclusione si faceva allora sconsolata ed evidentemente eccessiva, incapace di distinguere e di entrare, come pur sarebbe stato necessario, nel dettaglio, nelle pieghe della legislazione e dell’amministrazione proprio per non appiattire diversità e responsabilità. Ciò non di meno essa rivelava un largo sentire: «L’inerzia nella vita politica è la morte dei popoli […]. Se un governo si è quale il popolo si merita – ed è verità! – i deputati son quali noi gli vogliamo. Vogliamo uomini inerti? ebbene sia: ma allora non ci doliamo che altri ci calpesti e che niuno ne protegga. Vogliamo deputati che abbiano la coscienza del loro ministerio santissimo che siano attivi, instancabili, fieri di loro stessi? accorriamo alle urne, concordi perché saremo forti; risoluti, perché riusciremmo a certa vittoria. Non facciamo caso del censo avito, dei gradi accademici, delle entrature a Corte, o delle decorazioni bugiarde: uomini anche poveri, ma onesti; anche oscuri, ma immensamente generosi, possono fare alla Sardegna tanto di quel bene, quanto non ne fecero in tanti anni di sgoverno e governo e deputati».
Mazzate e ancora mazzate contro l’inerzia
Colpisce la nettezza di queste osservazioni e conclusioni non perché nuove – e nuove anche nella produzione giornalistica di Ottone Bacaredda poco più che ventenne e sempre più interessato alla scena pubblica – ma perché quasi in contrasto o, potrebbe dirsi, in dialettica con giudizi più benevoli circa la presunta atavica indolenza o inerzia degli isolani.
Una ragione, in questa apparente contraddizione, è da rinvenirsi nella diversa platea verso cui egli punta il suo indice accusatore: l’Italia parlamentare e ministeriale del postRisorgimento lenta e compromissoria in ordine ai pur doverosi riconoscimenti di merito e bisogno della Sardegna («povero scoglio flagellato dalle onde marine e dalla sferza dei potenti, e lanciato dal Caos nel mezzo del Tirreno perché paludamento di re mostrasse e corona e scettro; ma fosse di fatto schiavo di tutti, e sempre») – evidenza ne era anche la questione universitaria –, la stessa rappresentanza politica isolana nella sua dubbia capacità di combinarsi con quanti potrebbero azionare le leve dello sviluppo territoriale della regione. Di tali riflessioni è prova un articolo apparso in A Vent’anni! nello stesso 1870 (cf. n. 3 del 23 gennaio). Titolo: “L’inerzia della Sardegna”.
Occorre partire dal dubbio, osserva in breve Bacaredda: davvero nella sua storia l’Isola è stata, come sostiene Mantegazza («deputato di parte destra al Parlamento Nazionale»), inerte, passiva, soccombente per causa sua propria? Torna all’indietro, l’articolista, ai fenici e ai cartaginesi e ai romani per contestare quanti autori intinsero «nel fiele» le loro «penne brillanti»: Cicerone e Marziale, Orazio e Viriglio, Dante e Tassoni… «Questo popolo inerte nelle sue leggi più antiche condannava l’infingardaggine e l’ignavia», «vinto dai Cartaginesi, gli si ribellava di tratto in tratto compiendo la famosissima giornata in cui le schiere spesse ed agguerrite di Macheo venivano fatte a pezze e volte in fuga disperata»… Costò ai romani «fiumi di sangue» la conquista dell’Isola ed il popolo sardo «acconsentì a farsi romano quando un M.P. Catone colla sua equità, colla sua altezza di mente, colla sua rigidezza stoica cancellò le infamie dei primi Pretori»…

Passa per T.S. Gracco e Tito Livio il giovane Bacaredda nelle sue ricostruzioni sentimentali, fra guerre e leggi, e raggiunge i Giudicati: «I sardi inerti nel 695 scuotevano il giogo dei greci e si rivendicavano a libertà, stabilendo governo nazionale; e dessi caddero sotto i Pisani e i Genovesi quando, più dei patiti travagli, che non gl’infiacchirono, poterono le divisioni de’ suoi quattro Giudicati e le discordie che Cagliari separavano da Torres, Gallura da Arborea. Codesti sardi vilissimi non vollero dar pace ai loro governanti spagnuoli finché questi non si mostrarono savi ed equi nelle leggi… sono pur essi questi benedetti sardi, che sprovvisti d’armi e d’armati, dai bastioni di Cagliari, sulle pianure di Quarto, dalle torri della Maddalena rintuzzavano una seconda volta la baldanza francese; e che pochi anni appresso mostravano agl’ipocriti ed egoisti governanti quanto fosse la gagliardia del loro braccio e la nobiltà d’animo e la magnanimità loro».
Mai inerti, dunque, i sardi, secondo… l’esploratore Bacaredda. Forse nell’oggi sì, però. E quindi sfida, lui antigovernativo (e antidinastico!), Mantegazza: «se il sardo è inerte oggi, non lo son forse del pari tutti gl’italiani?». Aggiunge e motiva: «Il popolo nostro ha oramai dimenticato i Suffietti, i Pretori, i Consoli, i re vandali, i Presidi, i preti di Roma, i Giudici ed i Viceré; ha dimenticato altresì come i regoli del Piemonte rimunerassero nel 1793 i sardi della loro virtù, e pochi anni appresso della generosità loro, quando nel 99 salvavano e corona e persona ai principi sabaudi. Il popolo ha voluto scordare le imposizioni, i massacri, le ingiustizie trascorse; ma non può chiudere gli occhi sulle sventure presenti…».
E finalmente: «La Sardegna nel 1848, tempi d’illusioni comuni, prima, in Italia, rinunziava spontanea ai privilegi proprj, alla propria autonomia per far atto di sottomissione allo Statuto del così detto re magnanimo! sobbarcandosi alle gravose imposte di denaro e a quella più gravosa del sangue. Dessa si strappò dal seno gli scarsi figlioli per immolargli sull’altare della patria indipendenza… ed in compenso veniva considerata dal piccolo Piemonte ciò che è la Cajenna alla Francia; i sardi per barbari si ritenevano, e noi, più tardi, molto bambini ancora e lungi dalla madre patria, mille volte arrossivamo in un giorno alle parole che i nostri compagni sulla piazza, i maestrucoli nella scuola spendevano sulla terra che ci aveva veduti nascere… troppo bambini allora per poter conoscere come ciò ci faceva arrossar le guancie avrebbeci dovuto inorgoglire il cuore!».
Proietta, Bacaredda, la sua esperienza personale, quella di bimbo iscritto alle scuole liguri di Ventimiglia o d’altra città del continente prima di tornare nella sua isola, per gli studi d’adolescente a Sassari… ripensa alla sua alterità più come gli era stata rinfacciata, in Liguria o Piemonte, prima ancora che l’unità si compisse, prima che il Regno d’Italia si formalizzasse in ordinamento giuridico-costituzionale sviluppandosi dal seno del Regno di Sardegna… Né questo, invero, sarebbe cambiato neppure negli anni successivi.
«Il Piemonte prosperava, e la Sardegna languiva: Cavour, lo strenuo politico, si voleva assorto in pensieri di future grandezze, tanto da non poter rivolgere uno sguardo pietoso ed una mano benefica verso la derelitta che soffriva, si doleva – ma sperava! Era inerzia questa?».
Nuove stagioni, ma pur ancora quelle stesse di prima, nel biennio 1859-60: «i sardi siccome i loro fratelli fecero prodigi sui campi di battaglia; il Galantuomo gli chiamò i suoi piccoli diavolotti… la Sardegna piangeva i figliuoli morti gloriosamente, le campagne deserte; ma sperava !... e mentre sperava, il sempre strenuo politico, di sottocchi, dopo aver barattate con un disinteressato alleato due terre italiane, meditava vendere a Napoleone quest’isola italiana. […]. Noi si protestò, volemmo rimaner coi nostri, cui ci legava ragione di posto, di stirpe, di lingua, di storia; sacrificando alla nazionalità un sicuro e pronto benessere materiale; assoggettandoci a nuove sofferenze, confortate dalla speranza di tempi migliori. Fu inerzia questa?».
Non richiama esplicitamente nel suo scritto, Bacaredda, la ferma presa di posizione della democrazia sarda – di Giorgio Asproni in primo luogo – contro la ventilata operazione cavouriana, e lo stesso intervento, più volte replicato, di Giuseppe Mazzini per la difesa della intangibile italianità della Sardegna. Importa qui sostenere la tesi dell’orgoglio nazionale/regionale dell’Isola nella sua lunga storia, contro l’accusa di inerzia rivoltole da Mantegazza e/o dai suoi, e l’articolista resta sul punto, evitando deviazioni politiche a rischio d’esser giudicate strumentali e fuorvianti. Fa invece l’elenco dei ritardi di sviluppo che le due province isolane soffrono ancora a distanza di dieci anni quasi dal capitale 17 marzo 1861: il sistema stradale, quello portuale e quello ferroviario, la sicurezza pubblica… «i sardi abbandonati dai governanti a loro stessi, si videro anche abbandonati dai fratelli del continente, coi quali pure combatterono e pei quali disprezzarono straniere protezioni: nelle feste nazionali della penisola quante volte la bandiera sarda si vide sventolare fra le tante della cento provincie sorelle? quando mai si udì un brindisi alla prosperità di questo lembo di terra? […]. Scorrete i giornali italiani: quante volte e in quanti trovate menzionate l’isola nostra? di solito sempre che vi abbia un delitto da registrare, un’infamia da raccomandare alla esecrazione dei buoni…».
Dunque ora sì – in un’Italia che è ancora cantiere, che ancora non ha Roma capitale e tanto meno ha Trento e Trieste con sé, che fatica a calare l’unità od uniformità degli ordinamenti nel cuore sociale dei territori fra loro così diversi –, la stagione «dello sconforto» è venuta per la Sardegna. E ben a ragione. E l’inerzia attuale che pur si deve rilevare è conseguenza di una colpa collettiva nazionale. «Una volta era proverbiale la devozione del sardo al re ed al potere costituito: anco il bandito una volta fra le immagini di S. Gavino e di S. Efisio metteva ed adorava il ritratto e l’arma del sovrano. Si domandi ora al cittadino, all’artefice, al villano, al montanaro, alla donnicciuola che mai si occupò di governo, che siano per loro e re e regi consiglieri e funzionari regi… ciò ch’essi infallantemente diranno noi lo serbiamo nella penna per non procacciarci le animosità e le vendette del regio Fisco. E questa opera di demolizione non la fecero fra noi i giornali anticostituzionali, i partiti estremi, le sette, gli apostoli dell’Idea; no, la è tutta opera lenta del governo che a forza d’inganni finì per lasciare intravedere ai poveri illusi l’inganno». Il ricordo della rivolta del 1794 si riaffaccia. Non sia mai che debba materializzarsi in azione. Parola di Ottone Bacaredda ventuno-ventiduenne.
***
Scrivo queste note mentre continuano a giungere, drammatiche, le notizie da Kiev e dalla Ucraina tutta. Sia maledetto chi ha scatenato l’inferno ed ha provocato la morte e la sofferenza di tanti innocenti. (Ed ancora una volta abbiamo la plateale dimostrazione della nullità liberale degli esponenti della destra italiana, pagana e imbrogliona, da cui insistenti sono venuti, negli anni, gli accarezzamenti ad un pericoloso dittatore nato).
Fonte: Gianfranco Murtas
Autore:
Gianfranco Murtas
ARTICOLO GRATUITO
RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Devi accedere per poter commentare.


