Fabio Maria Crivelli, memoria viva di chi... sa vivere la memoria di Cagliari. Affabulando con lui circa gli speciali de L'Unione Sarda
di Gianfranco Murtas

Con il suo intervento che avevamo titolato Fabio Maria Crivelli, il mestiere del giornalista-cronista rivelato in un suo articolo di sessant’anni fa su “L’Unione Sarda”, nei giorni scorsi Gianfranco Murtas ha ricordato, in questo stesso sito, il profilo ideale e materiale che di se stesso professionista e dei suoi colleghi di redazione aveva tracciato il direttore del quotidiano allora di Terrapieno, prendendone lo spunto dal 2° premio assegnato a Giuseppe (Peppino) Fiori, nell’edizione 1960 del letterario Deledda, per il suo Sonetàula.
Oggi, come promesso, egli torna in argomento: l’undicesimo anniversario della scomparsa del grande direttore e l’approssimarsi del centenario della sua nascita ne offrono nuovamente l’occasione. Non si tratta, come è stato in altre circostanze – ché gli articoli dedicati a Crivelli da Gianfranco Murtas sono stati fin qui numerosi e tutti piuttosto corposi –, di una analisi mirata ad una qualche sua specifica iniziativa né di una lettura, per così dire, sinottica della sua attività al giornale, ma piuttosto di una libera affabulazione intorno ad alcune coordinate della sua direzione negli anni ’50 ed alla sua scelta di vita, interiorizzata proprio allora, di farsi… integralmente cagliaritano. (Red.)
Una redazione nella nuova vita cagliaritana
Accostandomi ancora quest’anno – come cerco di fare, puntualmente, nella triste sequenza degli anniversari – alla memoria cara di Fabio Maria Crivelli, direttore e amico, mi era parso bello, di primo acchito – ma soltanto di primo acchito –, riaccostarne il genio professionale ad un evento della storia de L’Unione Sarda collocabile ancora quasi agli inizi, o a fine di svezzamento, della sua direzione del quotidiano. Del 1958 per la precisione. Si trattò di un bellissimo inserto di quattro pagine che Crivelli, certamente allora “assistito”, o “consigliato” che dir si voglia, dai più stretti collaboratori interni ed esterni al giornale, volle a complemento della edizione del 1° febbraio: “Cagliari morte e resurrezione”.
Mente e gusto, tensione amicale e debito morale verso lo storico direttore del quotidiano della mia città, mi costringono però a percorsi diversi e diversamente orientati in vista di definire complessivamente, se mi riuscirà, obiettivi e modalità della sua missione professionale e civile tanto più in quei mediani e conclusivi anni ’50 che furono insieme il tempo del “miracolo italiano” e dell’affannata rincorsa della nostra autonomia regionale verso la stagione della Rinascita.
Due le circostanze che indussero al menabò di quello speciale “memorialistico” tutto cittadino: l’approssimarsi del 15° dei terribili bombardamenti del 17, 26 e 28 febbraio 1943 – che anticiparono di poco la sospensione delle pubblicazioni del giornale (dapprima per quasi tre settimane, fino al 19 marzo, poi, dopo la nuova “pioggia di fuoco” del 13 maggio, fino al 16 novembre) – e la visita a Cagliari, e quindi negli altri capoluoghi provinciali dell’Isola, del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che volle appuntare «solennemente sul gonfalone del Comune la medaglia d’oro al valor militare concessa alla città “martire” di Cagliari il 19 maggio 1950. L’occasione è propizia – questo aggiungeva un box di presentazione dell’inserto – al ricordo delle giornate tragiche dei bombardamenti ed al bilancio di una magnifica opera di ricostruzione».
Chiamò allora, Crivelli, alla confezione dello speciale alcuni degli intellettuali che con L’Unione Sarda collaboravano da tempo – così Francesco Alziator, Marcello Serra, Alberto Lorrai, Pietro Leo (che era stato, dal 1949 al 1956, anche sindaco della città) – e alcuni dei cronisti di casa: Antonio Ballero, il decano (era stato lui, capocronista, a reggere il giornale nelle poche settimane di dicembre che separarono l’addio dell’umbro Giulio Spetia dall’arrivo a Cagliari del successore, allora appena 33enne), Peppino Fiori, Angelo De Murtas. Offerse un bel supporto fotografico (con una quindicina di pezzi) l’ing. Luigi Valentino. L’apertura venne affidata ad un uomo politico, quello di maggior riferimento del giornale nella prima fase della direzione Crivelli, e cagliaritano doc: Francesco Cocco Ortu cioè, che a cavallo fra il tragico 1943 ed il 1944 fu parte attiva e meritoria nella rinascita cittadina sia come collaboratore diretto, con Guido Zoccheddu, del commissario prefettizio postfascista Gavino Dessì Deliperi, sia come assessore all’annona (e ad altro) nell’esecutivo interpartito che lo stesso Dessì, su indicazione del Comitato provinciale di concentrazione antifascista, varò e presiedette nell’estate 1944, fino alla sindacatura di Cesare Pintus (da ottobre 1944 a marzo 1946). Quel Pintus azionista e mazziniano, varrebbe ricordare, ancora impegnato nella redazione de L’Unione in temporanea e straordinaria gestione ciellenista.
Ma per introdurre qualche osservazione su quell’inserto de L’Unione Sarda, mi sembrerebbe utile richiamare, di Fabio Maria Crivelli, alcuni episodi – certificati dai suoi scritti – che riportano lui, romano (quartiere Trieste) di nascita istriana, di Capodistria diventata Koper nella repubblica slovena, al lutto di massa che afflisse Cagliari nel 1943 così come a quanto lo precedette e a quanto lo seguì. D’altra parte e del prima e soprattutto del dopo, di quel prima e di quel dopo egli scrisse diverse altre volte, e di tutto mi piace sempre ricordare quell’articolo di spalla dell’inserto che il giornale – allora diretto da Gianni Filippini – pubblicò, non a caso sotto il titolo generale “Cagliari. Gli anni della resurrezione”, nel quarantesimo dei bombardamenti, il 19 maggio 1983. Suo il pezzo “Dai cumuli di macerie nasce una città nuova”. Una magnifica ricostruzione memorialistica dai tratti perfino poetici, forse sorprendenti forse no nella scrittura di Crivelli.
Il doppio Virgilio cagliaritano di f.m.c.

In due suoi contributi alla rivista Esse come Sardegna, diretta da Piercarlo Carta nel passaggio di decennio, fra ’80 e ’90, Crivelli si sarebbe riavvicinato al tema ed oggi essi meriterebbero una nuova e fresca lettura: il secondo (uscito nel n. 6 del 1990) aiuta a capire meglio il primo (uscito nel n. 3 dell’anno precedente). I titoli: “I due ‘cronisti’ un po’ speciali” e “I mesi prima della tragedia”. Li riproduco in appendice.
Ricostruisco così: Alziator e Ballero – in veste di doppio “Virgilio” nel guidare il nuovo e giovane direttore per i quartieri, antichi e moderni, della città nei febbrili (soprattutto sul piano edilizio) 1954 e 1955 e 1956 ecc. – ebbero modo, e volontà, e gusto, di raccontargli Cagliari sì nelle sue pietre, nei suoi monumenti, nei suoi snodi viari e rionali, ma tanto più, insieme con le pietre e i monumenti e le chiese e i palazzi, nell’umanità vera del popolo, fra le svettanti eccellenze professionali o accademiche e la larga “piazza” – trama e ordito – dei ceti di mezzo di una città di mare e mercantile, di commercianti soprattutto e anche di artigiani, così come di un certo proletariato più di pescatori e salinieri che di operai d’industria, ma anche di salariati e salariate del gazogeno e della birreria, della manifattura e della cementeria e di certe officine meccaniche ancora resistenti negli opposti viali Trieste e San Bartolomeo…
Nell’insieme cittadino, piuttosto coeso anche perché la nostra non fu mai una borghesia di distanze né il nostro proletariato fu mai ostile per odio ideologico di classe, e perché la nostra intellettualità convisse benissimo sempre – lo testimonia personalmente lo stesso Alziator nel pezzo di Novecento della sua docenza all’Istituto agrario – con l’ordinaria quotidianità delle masse di studenti d’ogni estrazione sociale… Cagliari si presentò agli occhi del nuovo e giovane direttore de L’Unione Sarda come una realtà urbana ricca tanto di storia, umile e grande storia di provincia e insieme ombelico del Mediterraneo, quanto di potenzialità creative alla prova nell’oggi e tese all’aggancio della modernità e di una sana, progressiva secolarizzazione mai disconoscente tradizioni e valori.
Fu nel corso di quelle passeggiate d’istruzione cagliaritana che i professori (di mestiere e di vocazione) Alziator e Ballero, cui potrei aggiungere, per altri aspetti, Marcello Serra (e nell’ordinario segreto confidenziale della redazione Franco Porru, il vicedirettore del giornale ancora giovane ma, per iscrizione all’albo – 1941 –, il più vecchio dei giornalisti sardi), presentarono a Crivelli i segreti del caffè Genovese, i suoi tesori immateriali oltre quelli evidenti materiali (di certa ebanisteria d’un tempo!): il cenacolo che aveva ospitato, verso la metà degli ’30 – gli stessi, press’a poco, delle imprese coloniali africane e dell’impero etiopico conquistato nel titolo più ancora che nel territorio – gli intellettuali amici di Salvatore Quasimodo… e poi però raccolto gli insulti delle camicie nere pronte alla guerra da vincere con l’alleato tedesco contro ebrei e massoni, le plutocrazie occidentali e magari i bolscevichi… E quant’altro e quant’altri…
Fra essi quei tanti che, fino agli squilli della guerra, avevano associato le buone lettere alla militanza nelle organizzazioni del regime e immaginato un futuro che mai la storia avrebbe loro regalato… E di più: era entrato, Crivelli, come passando dalla… teoria alla pratica, cioè dalla teoria della lettura dei giornali in collezione di quel decennio chiamato del “consenso” alla pratica pedibus calcantibus – e sia pure immaginaria in quanto ai tempi – delle battute, quasi perlustrazioni, dei luoghi teatro delle scene di comizi e di adunate di gerarchi e popolo, popolino anzi (perché privo di autonomia intellettuale), di corpi marcianti con inni alla bandiera, ma anche dei riposi e divertimenti estivi al Poetto, al Lido magari, o degli ingenui appagamenti di curiosità per gli attracchi di navi da guerra al porto della via Roma …
Era il “prima”. Il dopo sarebbe stato un inferno, Cagliari ridotta a settemila abitanti nelle settimane nere dello sfollamento, ridotta a un cimitero di case e chiese e palazzi… fino al ritorno in un’emergenza senza fine, senza servizi d’acqua, senza annona dapprincipio, e le grotte di Tuvixeddu e Bonaria occupate dai senza tetto. E fino alla ricostruzione che avrebbe ancora per dieci e vent’anni visto in singolare, quasi surreale alternanza – fu la scena fotografata nel 1954 – i cumuli delle macerie e le vetrine illuminate dei negozi di chi voleva vivere un nuovo oggi.
A Terrapieno, fra processi e novità politiche
Agli occhi della città e della regione lo stesso giornale doveva presentarsi, esso con tutta la storia nobile e meno nobile che si portava dietro, come un protagonista della nuova stagione storica che guardava allo sviluppo, appunto al nuovo oggi e quasi lo interpretava, anzi lo impersonava, questo nuovo oggi. Se ancora nel 1954 erano ovunque, anche nel viale Regina Elena, evidenti i segni materiali dello sconquasso bellico di dieci o undici anni prima, se redazione e tipografia erano separati, ancora in quel 1954, soltanto dalle cataste di bobine della “sacra carta” – ché tutto era raccolto al pian terreno e nelle poche decine di metri quadri di due androni, di giorno cantiere di muratori e idraulici riedificatori –, i nuovi macchinari fra linotypes e rotativa, i nuovi più razionali spazi assegnati alla redazione, la stessa possibilità di distribuire il giornale con mezzi propri nei più dispersi centri dell’Isola – Sassarese compreso –, tutto questo mostrava, nel 1958 volontà e capacità realizzativa.
Da questo punto di vista, dunque, si potrebbe anche dire che quell’inserto del 1958 sviluppava, in termini di risultato, la fatica della modernizzazione del giornale, di una sua maggiore completezza ed una migliore articolazione dei notiziari della città, delle province e dello sport, della graduale introduzione (naturalmente collegata all’aumentata foliazione) delle pagine sia della cultura (la 3.a) che degli spettacoli (sarà la 5.a)…
Non solo. Iniziavano le inchieste volute dal nuovo direttore e annunciate da titoli che potevano colpire perché, datosi un giornale sì indipendente ma di area certamente moderata e quindi governativa, parevano quelli strillati dalla stampa d’opposizione. Fra le prime, nell’ottobre 1956, quella in tre puntate sulla “scuola privata in Sardegna” e titoli, appunto, niente affatto anodini: “Insegnanti mal pagati nella fabbrica delle promozioni”, “Il marcio è nel sistema”, “Non serve a niente stupirsi degli scandali”. Autore Magister, «un professore assai qualificato e di molta esperienza» (invero noto e notissimo nell’ambiente e in città ma il cui nome il direttore, per il patto fiduciario con l’interessato, tenne segreto anche con gli intimi, e così sarebbe stato per il futuro, per ogni collaborazione “riservata”).
Particolare menzione – prova provata dello sforzo compiuto da Crivelli e dall’intera redazione anche con la mobilitazione dei collaboratori – meritano senz’altro le inchieste del 1957, ma forse, prima di questo ed a fissare sfondi e colori modernisti, e direi prima di tutto civili, mi concedo – trattandosi qui di pura affabulazione, fuori dai rigori diacronici propri di altri contesti –almeno di richiamare (in attesa di tornarci con approfondimenti appena possibile) la quantità di processi che il “responsabile” della gerenza era chiamato ad affrontare, “protetto” dall’avv. Cocco Ortu, fin dal 1954 per continuare l’anno seguente ed i seguenti ancora, e con la difesa ancora di Cocco Ortu o con quella dei colleghi Endrich e Delogu, Caredda e Sanna Randaccio… Per la denuncia, nelle cronache cittadine, una volta dello sforamento in altezza del palazzone di viale Regina Margherita, un’altra dell'anomala subconcessione comunale della spiaggia del Lido, un’altra ancora della strana vendita cagliaritana di terreni addirittura nel Mato Grosso brasiliano, o per l’annunciato rinvio a giudizio di un industriale oleario («Non si tratta di pagare o meno ventiduemila lire, si tratta di ottenere un’affermazione di principio sulla libertà di stampa e di cronaca. Le leggi sono quelle che sono, è vero, ma bisogna anche cercare l’interpretazione esatta, non applicarle alla lettera…», aveva sostenuto l’avv. Delogu e il Tribunale gli dette allora ragione), o per il preteso mancato controllo sulla posta dei lettori con causa andata a rimorchio di un’accusa di diffamazione a carico di Angelo Amicarelli, commissario straordinario dell’Emsas… (interessante al riguardo anche una chiosa nell'editoriale del 12 marzo 1960: "Maestrine affamate"). Giornalisticamente e politicamente ancor più clamorosa quell’altra causa sorta anch'essa a un qualche rimorchio: quello di una crisi politica regionale e coinvolgente l’on. Francesco Caput (in antico direttore de L’Unione Sarda organo del fascismo della prima ora) ed i redattori Peppino e Vittorino Fiori accusati di scrivere… sotto dettatura! – una vicenda che meriterebbe di essere raccontata tutta intera e nei particolari…
Quanti avvenimenti negli intrecci di vita del giornale e della città, dei doveri informativi del giornale e anche delle vicende umane della sua compagine azionista nel quadro complesso delle passioni diffuse nel pubblico dei lettori e degli interessi cittadini i più diversi… Per dire, nel 1955 Guido Sorcinelli – il presidente del Consiglio d’Amministrazione – aveva seguito nella tomba suo fratello Nando, deceduto quattro anni prima (da lui stesso allora rimpiazzato nell’amministrazione e sostituito alla direzione de L’Informatore del Lunedì, dopo un breve interregno di Spetia, da Sergio Valacca, genero di Vitale Cao, il fil rouge del giornale, o della redazione politica romana, dalla stagione del regime a quella del potere democristiano; nel 1956 poi era stato Franco Porru, vice a L’Unione, a caricarsi la gerenza del settimanale)… Estremamente toccanti le note del cordoglio redazionale, così com’era stato, alla fine del 1951, per Fernando: dimostrazione evidente della intimità stretta del corpo giornalistico con la famiglia proprietaria che, dopo la morte dell’avv. Ferruccio, nel 1925, si era assunta collettivamente la responsabilità amministrativa della SEI, per il più condividendo gli indirizzi imposti dal regime al sistema informativo nazionale. Sforzandosi nel dopoguerra, di dar corso ad una linea editoriale più coerente ai nuovi tempi, centrata su un liberalismo prudente e, insieme, attraverso i contributi vivi delle corrispondenze territoriali, centrata su un regionalismo si direbbe più di “contenuti” che di “ordinamento”. Ma anche di ordinamento, come si sarebbe visto proprio con la direzione Crivelli e le vicende della presidenza di Alfredo Corrias (tanto più con l’ospitalità frequentemente e intensivamente offerta all’avvocato “ribelle” di Oristano dopo la fine della sua leadership d’“orgoglio autonomistico” e di protesta contro il governo Scelba avarissimo nelle assegnazioni CasMez a favore della Sardegna: suoi gli editoriali, felicissimi, del 12, 20 e 27 luglio, del 3 e 10 agosto e ancora del 1° novembre 1955).
Con Peppino e Vittorino Fiori e Filippo Canu – quel Canu portotorresino tutto Mazzini-e-Garibaldi (era nell’intimità di donna Clelia) destinato a magnifica carriera quirinalizia e poi RAI ma anche a successi letterari e teatrali – come punte di diamante della cronaca politica e di società, Francesco Alziator e Nicola Valle, Marcello Serra e via via Francesco Masala e Mario Ciusa Romagna (tanto più come critici letterari e d’arte) e con Salvatore Cambosu soprattutto (titolare di tavolo e sedia in redazione!) ecc. come firme a crescente presenza nella terza pagina e direi che proprio nella terza culturale, nel quadro del riordino graduale della impaginazione del giornale e della maggiorata foliazione (a dieci e poi dodici pagine): ecco l’asse qualitativo già in quei primi anni della direzione Crivelli, fra la colonna Ballero e la colonna Porru, con Mario Pintor alla segreteria di redazione e sempre pronto a dar conto della storia civile o religiosa segnalata dal calendario.
Il giornale all’edicola ancora soprattutto in città e nel Campidano – con la modesta (e declinante) concorrenza de Il Quotidiano Sardo, la testata dei nuovi guelfi cagliaritani organizzati dall’arcivescovo Paolo Botto e, per lui e per qualche anno ancora (fino ad arrivare al solido parrocato di San Lucifero), da monsignor Giuseppe Lepori. Quando ancora si usava, da quel fronte, autocertificarsi come “buona stampa” mettendo nel maggior recinto degli avversari morali, non soltanto civili e politici, anche L’Unione, che invero al notiziario diocesano e religioso in genere non mancava mai di offrire spazi anche piuttosto generosi.
In quanto alle dinamiche politiche impostesi nel quadro sempre più precario del centrismo dopo il fallimento della legge elettorale maggioritaria (la cosiddetta “legge truffa” del 1953) e la morte di Alcide De Gasperi (Trento, 1954), e nelle more degli sviluppi, forse sperati più che programmati, delle convergenze fra Saragat e Nenni in distacco dal PCI (Pralognan, 1956) una mirata lettura critica meriterebbe la posizione politica liberale di Crivelli e de L’Unione Sarda: riprenderò l’argomento, difficile ma importante ed obbligato, seppure soltanto per azzardare soggettive interpretazioni di una “problematica confusione” fra valori intimamente avvertiti come dirimenti e un pragmatismo di… multiple convenzioni. Mi riferisco da una parte alla scissione radicale del 1955 e al tanto di novità che quella quota di dirigenza liberale progressista introdusse sulla scena nazionale, e mi riferisco anche, sul piano regionale, alle riserve sulle propensioni conservatrici e politicamente reazionarie della giunta Brotzu lungo un triennio “sdraiato a destra” fra il prima di Alfredo Corrias e il dopo di Efisio Corrias. Sull’altro fronte mi riferisco, da una parte, alla conferma di una sostanziale intesa, circa la politica governativa, con Cocco Ortu – il quale, idealmente occhieggiando ai radicali, mai si sentì però di abbandonare il suo partito che pur lo costringeva a posizioni di minoranza –, e dall’altra al “rispetto” degli interessi anche economici degli azionisti estesi, nelle seconde e terze linee, a settori non editoriali.
Affidate la analisi della politica interna e di quella estera rispettivamente ad Armando Zanetti (liberaldemocratico di storia laica ed antifascista ed europeista della prim’ora) ed a Marco Trudu (un professore di scuola superiore cultore di relazioni internazionali, di marcato orientamento occidentalista ed anticomunista), Crivelli seguì con estrema attenzione e partecipazione, ma da regista più che da attore o prim’attore, quanto si muoveva nel piccolo mondo isolano e in quello vasto dell’Italia e dei continenti: era anche il tempo del poststalinismo, del XX congresso del PCUS, della invasione armata della Ungheria, della guerra di Suez e di quella d’Algeria… ma anche dei trattati di Roma istitutivi del MEC. Di tanto fanno fede il numero e la frequenza, ora accelerata ora rarefatta, degli editoriali e/o corsivi direttoriali, immancabilmente firmati o siglati.
Editorialisti a parte, nel suo primo manifesto tentativo di guadagnare all’informazione isolana una qualche firma di competenza o risalto nazionale – quello era, peraltro, anche il tempo di Silvio Piola allenatore (sfortunato) del Cagliari –, nel 1955 Crivelli aveva voluto nientemeno che Gino Bartali come inviato speciale del giornale al Giro d’Italia: venticinque articoli firmati dal campione-cronista e un successo di vendite per il giornale.
Nello stesso anno al Quirinale Giovanni Gronchi aveva raccolto l’ufficio di Luigi Einaudi ed al Viminale, alla presidenza del Consiglio dei ministri, s’era insediato il sardo Antonio Segni. Pressoché in contemporanea, a Cagliari, le cennate giunte regionali di Alfredo Corrias, democristiane aperte o a diretta compartecipazione sardista – s’intende sempre del PSd’A dei Melis e dei Casu, dei Soggiu e dei Puligheddu o dei Contu, diciamo pure dei Mastino e degli Oggiano (niente a che vedere con il Partito Sardo paraleghista e destrorso di oggi che semmai è l’opposto di quello di buona storia) –, avevano concluso una certa fase storica dell’autonomia speciale per cedere il campo – e così sarebbe stato per più di mille giorni – agli esecutivi Brotzu monocolori “sdraiati” a destra, coperti dal voto palese o segreto della destra monarco-missina ed avversati, senza cedimenti, da L’Unione Sarda. (Debbo, sul punto, una rettifica o una precisazione su quanto troppo sbrigativamente avevo scritto su Chorus del 1° giugno 2003 e riportato quindi nella dispensa omaggio a Fabio Maria Crivelli, nel 2011: quasi come traino dell’appoggio alla formula centrista nazionale avevo posto il giudizio sulla maggioranza monocolore a puntello monarco-missino, che invece fu di avversione).
Dicevo delle inchieste, per arrivare poi agli inserti, e a quell’inserto del 1958, con quanto ad esso direttamente o meno si potrebbe ricollegare, per successive testimonianze del direttore.
Cagliari, una città da fare
Muovendo, certo non a caso, dal capoluogo, ed a firma di altro collaboratore, stavolta Vitruvio (pseudonimo scelto dall’autore – con probabile ricalco della propria esperienza professionale ed in omaggio al celebre Marco Vitruvio Pollione, architetto romano del I secolo a.C.), a partire da gennaio – l’anno è il 1957 – vanno 14 puntate (con impaginazione mobile): “Cagliari: una grande città da fare”.
Eccoli i titoli: “Partiamo da via Roma dove la verità si specchia” (con premessa: «Questa è una inchiesta e insieme un dibattito aperto a tutti; non un processo al passato ma un’appassionata indagine con l’occhio aperto al futuro»); “Alla base dell’anarchia edilizia la mancanza d’un piano regolatore” (con sommario: “Non esiste un piano delle fogne cittadine; e della rete idrica esiste solo il piano dei nuovi impianti. I limiti del Piano di Ricostruzione. La Regione, con un provvedimento recente, ha affermato il principio della verticalità. Chi approva i progetti”); “Le due facce della medaglia: una tragica realtà e un’occasione perduta” (e “La città avrebbe potuto trar vantaggio dalle devastazioni belliche e risorgere con un volto mutato. Ma le esigenze pratiche dei cittadini prima e l’irresolutezza delle autorità politico-amministrative poi hanno dato alla ricostruzione una impronta di orgasmo e di caos”); “Un pericolo permanente le secolari fognature cittadine” (e “Molti canali sono permeabili ed il liquame che ne trasuda, nutrito di una impressionante flora batterica, rischia di essere assorbito dalle logore condutture dell’acqua. Soltanto metà dell’abitato è servita da fogne dinamiche. I rifiuti sboccano all’interno del porto”); “Metà delle vie cittadine debbono essere ancora pavimentate” (e “La rete stradale si sviluppa per ben 97 chilometri. Buoncammino, una passeggiata meravigliosa ma omessa da tutti i piani di restauro. Come Vittorini ha descritto la via Roma. Lo strano episodio citato da Balzac. Per sistemare il fondo delle strade al centro e nelle frazioni occorre la spesa di un miliardo”); “Per troppi chilometri regna ancora il buio” (e “L’estensione dei pubblici servizi, e la luce tra questi, non ha seguito il veloce ritmo di sviluppo della città. Una rivoluzionaria innovazione: l’avvento delle lampade fluorescenti. Tra breve saranno illuminate le Piazze Repubblica e Costituzione ed il lungo tratto che da Piazza Jenne porta a Piazza San Michele. Inappagata sinora l’esigenza di illuminare i monumenti cittadini”); “Le romanzesche vicende del Palazzo della Regione” (e “I bizzarri capitoli di un film quasi comico. Il voto del Consiglio reginale e il concorso di primo grado. Bocciata via Roma all’unanimità! La protesta del prof. Caronia. Leo e il concerto a percussione”); “Continua lo strano romanzo del palazzo della Regione” (e “Bocciata all’unanimità l’area di via Roma. Ardente polemica fra Leo, sostenitore di Piazza Yenne, e Asquer, fautore di Su Siccu. ‘Isolare i monumenti è sempre pericoloso’. Il prof. Caronia nell’imbarazzo. La votazione finale”); “Si chiude con il trionfo dell’assurdo il romanzo del Palazzo della Regione” (e “Furono soprattutto i comunisti a battersi contro Su Siccu: temevano che il popolo non andasse a vederli in zona periferica. Leo non avrà l’Oscar della coerenza. La città aumenta il numero delle occasioni perdute”); “In aprile cominceranno i lavori di demolizione del vecchio mercato” (e “E’ questo il primo passo per l’assetto del centro cittadino. Ma gli edifici della Banca d’Italia e della Banca Nazionale del Lavoro, pur decorosi, non avranno un carattere monumentale, come in un primo tempo era previsto e non sorgerà nella Traversa Mercato una galleria”); “Quattro enormi spine nel cuore della città” (e “Sono il Palazzo della Dogana, il Mattatoio, l’officina del gas e la Stazione delle Ferrovie Complementari. Cinque passaggi a livello in pieno centro. Per il nuovo macello ci sono già pronti l’area e il progetto, manca la cosa più importante: il denaro”); “Nel giro di quindici anni la zona industriale sarà realtà” (e “Fin dal 1918 si progettò la sistemazione di un comprensorio che portasse la capitale dell’Isola sul piano dei grandi centri moderni. Ora il progetto è stato impostato e verrà gradualmente concretato. La spesa complessiva sarà di 16 miliardi”); “Per tremila universitari sedi insufficienti e squallide” (e “Is Mirrionis: una zona da bonificare. La scandalosa sistemazione di alcuni istituti universitari. Un piano di completamento edilizio del Rettore Peretti. Due miliardi e seicentoquaranta milioni che bisognerà assolutamente trovare”); “Dopo le dieci di sera diventiamo podisti” (e “Il problema giornaliero dei trasporti pubblici e quello degli orari e della frequenza. Vetture dignitose ma nere. Imminente la riforma tramviaria. Il mistero dei tassametri”).
Dopo scuola ed urbanistica, al giornale per i trasporti
In parallelo, da febbraio e firmata da Alberto Granese, giovanissimo pedagogista in preparazione ad una attività accademica che sarà la sua vita, e già distintosi con uno speciale dal titolo “Oristano a più voci” (occhiello “Dove nasce la quarta provincia”, 17 dicembre 1955), un’altra inchiesta si sviluppa allora per otto puntate. Titolo generale e già della prima puntata su nove colonne: “Per i sardi partire è sempre come un po’ morire”. Entrano in questa sintesi le difficoltà materiali dei viaggi o dei trasferimenti dall’Isola via mare e via aria: la Tirrenia da una parte, la LAI (dopo l’avventura dell’Airone) dall’altra, sono i vettori maggiori o di monopolio… ma ecco poi la viabilità interna, le ferrovie statali e quelle secondarie, storie di scartamenti e di isolamenti persistenti e intollerabili… Alla vigilia, anzi all’antivigilia, della motorizzazione popolare, che si compirà nell’Isola con molta gradualità dai primi anni del decennio successivo, ma già qui nel pieno delle correnti migratorie che segneranno – anticipando l’industrializzazione petrolchimica o quella turistica sulle coste (Alghero e Santa Margherita di Pula, e Villasimius e la Gallura) – l’economia e la società sarda.
Il primo sommario: “Quelle 125miglia che ci separano dal Continente costituiscono il più pesante handicap della nostra terra. Non è con i secchi che si prosciuga il Tirreno. La situazione delle strade è sempre quella d’un pase coloniale. Un processo da farsi”. Ed eccone i titoli in sequenza: “A Roma fanno e disfanno senza neanche invitare la Regione” (e “Storia della convenzione con la Tirrenia. Qual è la penale quando sulla nave viaggiano più delle 466 persone prescritte? A giugno il rinnovo, ma è il CIR ad avere l’ultima parola e c’è da temere che la voce della Sardegna non sia neanche udita”); “E’ assurdo il sistema di finanziamento alla Tirrenia” (e “La inutile polemica fra sud e nord e idee poco chiare sul problema. La questione delle riduzioni e la guerra fra i Ministeri. E intanto noi paghiamo e stiamo a guardare”); “Con i vecchi muletti percorriamo le vie del cielo” (e “Come la LAI riuscì a soppiantare l’Airone grazie alle preferenze del Ministero. Ora si parla di nuovi aerei: ma per la Sardegna c’è qualche altra manovretta in vista”); “Quando si deciderà lo Stato a proteggerci da ogni sorta di abusi?” (e “Se son così lontani non è colpa nostra! A nessun italiano costa tanto viaggiare come a noi. Tutta una serie di piccole rapine che sono divenute legge. Il nolo delle macchine e altre diavolerie. Quello che possiamo e dobbiamo pretendere”); “Ciò che deve sapere l’angariato signor X” (e “Quando l’aereo scricchiola nessuno gli spiega perché il ‘muletto’ non può andare né più sopra né più sotto. Che probabilità ha un D.C. 3 di volare con un motore in panne? Perché paghiamo 1.950 lire per un pasto che mai consumiamo. ‘Hic sunt leones’”); “Neanche i miliardi viaggiano su strade sbagliate” (e “Le distanze sulla carta e le distanze reali. Per fare 150 Km talvolta non basta una giornata. Scartamento normale e scartamento ridotto. Alle origini di un grosso errore”); “Spendiamo troppi miliardi per non seppellire un morto” (e “I tecnici vogliono lo smantellamento di parte delle ferrovie concesse: i politici vi si oppongono. A far le spese di questo dissidio sono soltanto i passeggeri e tutti i contribuenti”).
Pare interessante rilevare come, nel novero degli speciali che L’Unione Sarda dedicherà negli anni avvenire alla questione “trasporti” (o al “problema dei viaggi nell’Isola”), uno del 1962 raccoglierà due importanti reportage dalle riviste Quattrosoldi e L’Automobile. Titoli rispettivamente “Per venire in Sardegna fanno la fila” e “Itinerario emozionante per chi usa l’automobile” (questo secondo con un box di… chiaroscuro: “Le delizie della traversata fino a Golfo Aranci e il disastro dello sbarco”). Il che testimonia delle permanenti difficoltà negli arrivi, ma anche preannuncia il prossimo futuro turistico della regione.
Nasce il MEC ed è il futuro. Gli adottivi di Sardegna
Di novembre e dicembre dello stesso 1957 – l’anno dei trattati di Roma e quindi anche dei primi affacci, sulla stampa nazionale e sarda, delle opportunità offerte dal Mercato Comune Europeo, cioè del superamento delle barriere doganali (di cui si occupa ripetutamente Angelo De Murtas) – è un’altra inchiesta, cucinata in redazione, che sembra particolarmente gradita (perché idealmente lo ricomprende) al romano-istriano Crivelli: “Continentali in Sardegna”, in quattro puntate: “Lentamente le prevenzioni e gli assurdi concetti con i quali si guardava alla nostra Isola stanno scomparendo. Ma anche in passato forti correnti di immigrazione varcarono il Tirreno. Un romano e i Quattro Mori”.
“Trentamila siciliani vivono nella nostra Isola” recita il secondo articolo dell’inchiesta (sommario: “Sono in molta parte contadini insediatisi nelle campagne di Iglesias e di Capoterra. Diciottomila risiedono a Carbonia. Cagliari deve la chiesa di S. Rosalia ai palermitani che il colera aveva costretto a fuggire dalla loro terra”), e così recitano i successivi: “Quarantamila napoletani vivono nella nostra Isola” (e “I primi immigrati partirono da Secondigliano, una frazione del capoluogo campano dove fioriva l’artigianato tessile. Quasi tutti sono dediti al commercio in tutti i suoi livelli: dal grande emporio alla bancarella”) e “Sono ormai diventati i figli adottivi dell’Isola” (e “I luoghi dove l’insediamento permanente di forestieri è avvenuto su ampia scala sono Carloforte, Arborea e Fertilia”).
Efficaci e gustose le conclusioni: «Indagine sommaria ed attenta solo alla latitudine del fenomeno, fuori dalla minuta casistica personale, che oltre tutto sarebbe estremamente difficile, per la difficoltà di un eventuale censimento, di setacciare il sardo dal continentale. E non sembri questo un paradosso. Dopo appena dieci, vent’anni di residenza nell’Isola, il forestiero si sente del luogo, vota per le amministrazioni locali, tifa se è sportivo, per la squadra della sua città d’elezione, entra nei consigli municipali, legge i giornali del posto, persino assorbe a volte i dialettismi e in certi casi le inflessioni della gente che ormai tutti i giorni frequenta e pian piano la memoria delle sue vecchie amicizie si affievolisce, le nuove abitudini sostituiscono le vecchie ed il fenomeno d’acclimatamento è compiuto. Per cui uno stupido battito di ciglia è la reazione comune ad una domanda che riguardi la sua origine continentale. In bello accento romagnolo ci siamo sentiti rispondere, nel corso dell’inchiesta: “Che vuole che le dica dei continentali in Sardegna? Per me, io sono sardo”. E non è una posa, non è un atteggiamento cortigianesco. Veramente per molti continentali quest’Isola tumulata nei pregiudizi di quelli che non la conoscono è diventata una seconda patria, una terra che semmai, per i guai che l’affliggono, suscita slanci e tenerezza a somiglianza di una creatura inferma che necessiti dell’aiuto comune. Ecco perché avremmo voluto intitolare l’inchiesta, anziché “Continentali in Sardegna”, “I figli adottivi”».
Nella stessa logica di un’inchiesta lasciata anch’essa alle cure della redazione si presenta quella che, sempre nell’autunno 1957, rimanda alla domanda: “La laurea serve a qualcosa?”. Qui due sono le puntate e lunghissimi gli articoli che escono la domenica impaginati di lato alla rubrica “Colloqui domenicali”, che Crivelli ha lanciato da qualche mese (per protrarla ancora nel 1958 e replicarla nel 1964: ne ho dato conto in un trascorso articolo uscito in Fondazione Sardinia l’8 novembre 2017): “Sempre più avvocati sempre meno chimici” (e “Le facoltà scientifiche vengono progressivamente disertate a beneficio di quelle giuridiche e letterarie. Ogni anno 500 studenti si iscrivono all’Università di Cagliari. Ma soltanto metà seguiranno fino alla fine il corso prescelto”) e “Quarantamila lire al mese dopo diciassette anni di studi” (e “E’ la sorte di molti giovani farmacisti. In pericolo la facoltà di veterinaria di Sassari disertata dagli studenti sardi e frequentata quasi esclusivamente da giovani greci”).
In piena coerenza pare collocarsi anche il focus tematico che, nel medesimo 1957 (17 marzo), è affidato a Marcello Serra su Oristano “Quarta Provincia” con uno speciale di due pagine ed un pot-pourri di articoli che, fra passato e presente, vogliono rappresentare una realtà territoriale e culturale assolutamente originale e meritevole di promozione anche politica (“Ritratto di Oristano”, “Destino sul mare”, “Leggenda”, “Teatro della storia sarda”, “Eleonora interprete dell’animo dei sardi”, “Una basilica armoniosa fiorisce tra case di fango”, “Le lacrime di Santa Giustina”).
Pur non esplicitata nello speciale di Marcello Serra, è la questione dell’Oristanese come quarta provincia isolana a chiamare l’interesse del giornale che l’ha infatti affrontata, con innumerevoli servizi e “tribune libere”, già da anni: proposte di legge e voti, ordini del giorno e istanze da parte delle più diverse fonti, tutto s’è finora risolto, a livello parlamentare, in un nulla di fatto (e sarà così fino al 1974) principalmente per le obiezioni, più o meno sotterranee, mosse dalla DC nuorese, poco disponibile ad amputazioni dei suoi bacini elettorali tanto più nel Marghine e nella Planargia.
Sempre nella logica degli approfondimenti, con passione
Continueranno nel tempo questi approfondimenti tematici rivelatori delle nuove coordinate dell’informazione che L’Unione Sarda affidata a Fabio Maria Crivelli intende affermare in un periodo che si rivelerà cruciale per il futuro isolano, in uno con quello nazionale s’intende, e con le aperture che la scena politica – invero seguite inizialmente con cautela dalla direzione (mi riferisco ancora alla svolta di centro-sinistra del 1962-63) – assicurerà ad una società progressivamente coinvolta nei processi modernizzatori dell’Europa e dell’Occidente.
Presto altre importanti inchieste avrebbero visto la luce. Sarebbe stato nel tempo del consuntivo, forse complessivamente deludente, del primo decennio di autonomia speciale, nel tempo dell’avvio delle necessarie (ma purtroppo non tutte indovinate) trasformazioni industriali, nel tempo anche della progressiva evoluzione del costume sociale grazie soprattutto alla scolarizzazione di massa…, e sarebbe stato, per il giornale, nel tempo appunto del consolidamento della nuova direzione e del deciso rinnovamento del quotidiano fattosi qualcosa di più che il “breviario laico” di romantica retorica. Si ricordi in particolare quel “Facciamo il processo alla città: Cagliari e brutta” del gennaio-febbraio 1960: quattro articoli a firma di Michelangelo Pira, gli opposti giudizi di Luigi Cocco e Nicola Valle, quello dell’arch. Bruno Virdis, dell’ex sindaco Pietro Leo, di alcune decine di lettori, fino alle conclusioni di Pira.
Firmata da Vittorino Fiori, cronista di valore e sempre più punta di diamante del giornale, sarebbe venuta poi, all’inizio del 1961, una lunga e preziosa inchiesta sul Piano di Rinascita ancora in elaborazione e di prossima approvazione da parte del governo Fanfani (con La Malfa ministro del Bilancio e della Programmazione decisivo ad imporre la compartecipazione regionale alle decisioni della Comitato interministeriale e della CasMez)…
Questi di esordio o di rodaggio della direzione Crivelli (che avrà davanti a sé un futuro di cinque lustri circa) sono anni anche di… lucida passione per la storia de L’Unione Sarda. Sarebbe da dire che al 1958 arriverà la schedatura di qualcosa come venticinquemila articoli che, dieci anni dopo – nel 1968 cioè, all’80° compleanno del giornale – Giuseppe Della Maria presenterà in due volumi di grande formato: uno con il repertorio tendenzialmente completo del settantennio, l’altro con la storia delle direzioni, vale a dire con la storia – fase per fase – della testata nata cocchiana ed evolutasi (nel bene e nel male, a pensare al ventennio di dittatura) secondo gli indirizzi ad essa forniti dalle intese fra editore e direttore. Così, dal 1958 al 1968: altra storia nella storia. E peraltro, per inquadrare la tempistica, potremmo anche aggiungere che il 1968 avrebbe significato la vigilia del passaggio del controllo azionario della SEI, dell’editrice cioè, dalla famiglia Sorcinelli (in persona ancora del presidente del CdA Roberto Sorcinelli, poi di sua figlia Silvana) ad una finanziaria estera riconducibile al petroliere Nino Rovelli, patron della SIR e dal 1967 editore, in forma aperta e spregiudicata, cattiva perfino, de La Nuova Sardegna.
Nella relativa limitatezza dei mezzi sia tecnici che finanziari a disposizione, la direzione Crivelli cavalca bene la duplice missione di modernizzare il giornale e di regionalizzarlo, in una sorta di convivenza – invero non facile – con La Nuova Sardegna di antico radicamento non soltanto nel Sassarese e nella Gallura, ma anche nel Nuorese (territorio che fino al 1927 era ricompreso, come circondario sottoprefettizio, nella provincia di Sassari) e in parte anche nell’Oristanese.
E’ una direzione che favorisce lo sviluppo del giornale in termini di dimensioni del notiziario locale, subprovinciale, prima ancora che di diffusione delle copie: ciò grazie all’allargamento della schiera dei corrispondenti, valorizzati nel loro ufficio, direi perfino meglio “formati” al mestiere. Ed è una direzione, quella Crivelli, che si avvale in crescendo anche di collaborazioni importanti, tanto più preziose per la terza pagina, di cui sarà a lungo il responsabile Gianni Filippini in un mix di firme sarde e di firme continentali.
Si erano sperimentate domenica 16 dicembre 1956 le dodici pagine (nei giorni del gran lavoro dei tribunali speciali in Ungheria!), Alziator aveva aperto la terza culturale (“I musei del folklore”), la cronaca cittadina si era espansa per una volta su due pagine (la seconda anche conglobando la programmazione radiofonica e le manchette dei cinematografi), informando anche dell’apertura della Bella Cagliari! e circa le novità della Fiera prevista per la primavera successiva; la sesta e l’ottava si erano riservate alle province (capo di sotto e capo di sopra rispettivamente), la settima ad uno speciale natalizio con le firme degli autori forniti dai circuiti nazionali, la nona allo sport (in programma Cagliari-Brescia, allenatore rossoblù Rigotti ), la decima e l’undicesima agli interni e agli esteri, alle ultime della notte, ai necrologi, l’ultima alla piccola pubblicità. Un esperimento, un tentativo, una… presa della misura per le nuove macchine al massimo sforzo…
1956, 1957: Sant’Efisio e molto altro
Nell’aumentata foliazione era facilitato il complessivo riordino del notiziario provinciale e la terza pagina con una ambizione di “pienezza” poté allora accogliere anche qualche… selfie, diremmo oggi, qualche zoomata sulle vicende della stessa testata. Promettente anticipazione, da questo punto di vista, già alla data del 12 dicembre 1954 – quasi a conclusione dunque del primo anno di direzione del giovane professionista formato dalle esperienze romane de L’Epoca, de Il Momento e de Il Giornale d’Italia – fu un lunghissimo articolo (“Un attentato al Quirinale aprì le cronache del milleottocentonovanta”) con un occhiello rivelatore più del titolo: “Alla ricerca del tempo perduto, sfogliando i primi numeri de L’Unione Sarda”. Una foto a corredo presentava la collezione del giornale nei locali della Biblioteca Universitaria, non ancora nei locali che avrebbe occupato di lì a breve, per l’intervenuto acquisto del palazzo Belgrano bis, cioè del seminario diocesano da parte dello Stato (ministro della pubblica istruzione e, presto, presidente del Consiglio, Antonio Segni).
Era quella soltanto una anticipazione. Nell’autunno 1958 – proprio in contemporanea con il conclave che avrebbe portato la Chiesa cattolica dal pontificato di Eugenio Pacelli a quello di Angelo Giuseppe Roncalli – più frequenti spazi seppe trovare, il giornale, per la propria autobiografia nel 70° della sua prima uscita (o, sarebbe meglio dire, nell’inizio d’anno della sua festa): Ubaldo Nieddu (“Eroici lettori”), Pietro Leo (“I primi direttori de L’Unione Sarda”)… Occorrerà tornare in argomento, peraltro già avvertendo che di Pietro Leo meritano una particolare menzione, e meriterebbero una particolare rilettura, le cinque puntate di una ricostruzione piena e “contestualizzata” delle vicende del quotidiano uscite nel gennaio 1959 (“Lo spensierato viaggio della Commissione d’inchiesta”, “Un terremoto finanziario travolse la bravissima età dell’abbondanza”, “Netta opposizione alle avventure coloniali”, “Il matrimonio di Grazia Deledda” e “Si desta nei sardi una coscienza regionale”).
Simpatico un altro… autoritratto del giornale, o del suo fratello minore L’Informatore del lunedì, che invece del proprio… canonico lunedì, per una (forse unica) volta si era spostato – per salvare la festa del Santo Natale (anno 1955) – al martedì, e raccontava se stesso, in apertura della cronaca cittadina: “Questo giornale del lunedì” e l’occhiello “Considerazioni sentimentali su una giornata di vacanza”, con un sommario molto discorsivo: «Domenica era Natale e le macchine tipografiche si sono fermate per consentire anche alla famiglia giornalistica di festeggiare la ricorrenza: e questo foglio, puntuale dopo ogni parentesi domenicale, esce con un giorno di ritardo».
Nel febbraio di quello stesso anno aveva visitato redazione e tipografia il ministro Ezio Vigorelli, bella figura di socialista partigiano antifascista, e con il PSDI ministro del Lavoro e della Previdenza sociale. Non furono rare, in quegli anni, le visite delle personalità politiche regionali e nazionali: il consigliere delegato Luigi Porcu (marito di una Sorcinelli) e Crivelli se ne deliziavano ogni volta considerandole, ben a ragione, un riconoscimento di autorevolezza della testata.
Nel 1956 il giornale aprì una sottoscrizione a favore degli isolani colpiti dal maltempo, e per alcune settimane avrebbe dato conto della larga partecipazione dei lettori all’iniziativa di solidarietà (all’insegna di “I sardi per i sardi”). Fu quello un modo, oltreché santo per il santo obiettivo umanitario, anche funzionale alla fidelizzazione del pubblico che sentì il giornale come efficace strumento di collegamento civico o comunitario.
In tempi di primi impianti televisivi – l’anno è sì il 1956, ma le antenne non avrebbero ricevuto nulla fino al 1957 – una iniziativa era lanciata dal quotidiano per “agganciare” la novità fidelizzando ancora, e secondo un modello presente qua e là nel continente, il suo pubblico: un apparecchio TV Marelli venne sorteggiato fra chi prendeva parte al “veglione” allestito da L’Unione presso il teatro Massimo («riscaldato») nel martedì grasso di chiusura del carnevale. Due orchestre – una ritmica ed una melodica – allietarono la serata danzante, bar e ristorante fecero il resto… in vendita al bar Vanini i biglietti di partecipazione per 2.500 lire l’uno «in distintamente per dame e cavalieri», e i ticket per i tavolini-bar e la cena, rispettivamente a 500 e a 2.500 lire. Con preghiera di abito scuro per gli uomini (meglio lo smoking), e da sera per le signore «lungo o corto non importa, purché da gala». Garantito «fino all’alba», per i non provvisti di auto, il servizio tramviario «per tutti i punti della città». «Fiori, verde, festoni e pannelli e soffitti falsi e luci e schermi in ogni angolo, uno splendore insomma», veniva assicurato dagli organizzatori (quelli della San Remo) che, presentandolo, promettevano un veglione da passare «alla storia della vita mondana cittadina come il più grande avvenimento di tutti i tempi»… L’animazione era affidata a Tullio Vanni, noto partner radiofonico di Renzo Romiglioli.
A calendimaggio, naturalmente, la festa di Sant’Efisio. Eccezionale nel 1956 perché coincidente con il 300° del voto della municipalità cagliaritana al martire guerriero. L’Unione Sarda non poteva mancare all’appuntamento si presentò con uno speciale di due pagine: “Da trecent’anni sulla vita di Nora”. Contributi di Francesco Alziator (“Efisio nell’arte e nella letteratura”: una traccia importante utilizzata come base per il prossimo capitolo efisiano de La città del sole), naturalmente di Antonio Ballero (“Quel maggio c’era il silenzio”, rifluito poi nell’antologia Le case di fango. Cagliari ed altri scritti, Roma, Serafini editore, 1985), di Marcello Serra (“In due epigrafi la prova dell’esistenza del Martire: il nome del giudice che condannò Sant’Efisio rilevato su due pietre miliari nei pressi di Olbia”), di Mario Pintor (“I volontari dal berrettone rosso: uno squadrone di cavalleggeri scorterà sino a Nora il simulacro di Sant’Efisio indossando la storica uniforme dei Miliziani”) e di Pietro Leo (“Dopo la rivolta temevano i tumulti: solo il 1° maggio 1794 Efisio non partì”).
A complemento, le foto delle sfilate più recenti ma anche l’istantanea più antica, datata 1886, una del tragico 1943 ed un’altra ancora riguardante un’antichissima stampa datata 1798.
In quella stessa primavera 1956 le elezioni comunali avrebbero segnato il passaggio, a Cagliari, dal centrismo largo di Luigi Crespellani e Pietro Leo – sindaco dal 1949 – al monocolore democristiano (appoggiato dalle destre monarchiche e missine) di Mario Palomba. Il giornale avrebbe seguito con spirito critico, fino al 1959-60, quell’avventura amministrativa ritenuta non commendevole dal punto di vista dell’interesse politico della città: inquiete e sfibrate, sempre incerte le maggioranze parlamentari a Roma, fino a Tambroni e a quanto comportò il suo governo, idem quelle regionali con Brotzu che fino al 1958 guidò anch’egli monocolori appoggiati dalle destre, così fino alla presidenza di Efisio Corrias che riorientò verso politiche più aperte Consiglio e giunta e, dopo lungo combattere, ottenne da governo e Parlamento l’attesa legge del Piano di Rinascita.
Crivelli osò scendere in campo, quella volta, non giocando con il classico editoriale del direttore ma con un invito-appello al voto e contro l’astensione (“Una scelta responsabile”) firmato proprio «L’Unione Sarda» e rivolto, come in un colloquio diretto, al lettore-elettore: «Tu oggi sei chiamato…, tu cittadino sei il centro intorno al quale gravitano…, sei un giudice davanti al quale si aprono tutte le possibilità di valutazione… E’ quella che ti si chiede di formulare, col voto, una scelta di incalcolabile peso, che ti pone di fronte a gravi responsabilità, perché il tuo voto avrà influenza, non soltanto sul tuo personale avvenire, ma sull’avvenire dei tuoi concittadini…». Infine: «Vota in piena serenità, lasciando che soltanto il tuo criterio guidi la tua scelta: il tuo voto, a chiunque tu voglia darlo, avrà lo stesso peso, perché la legge che regola queste elezioni è stata studiata col preciso intento di dare un uguale valore a tutti i voti, a quelli dati a grandi partiti, ed a quelli dati a partiti piccoli…, il tuo giudizio non deve subire distorsioni per il timore (oggi infondato) di dare un voto inutile, un voto che vada disperso. Vota senza nessun timore: nessuno, te eccettuato, potrà rimproverarti il tuo voto che hai il diritto di dare al partito ed agli uomini che ti ispirano maggior fiducia. Tu solo, oggi, sei il giudice. Tu solo, elettore».
Un appello da prendere per quello che è nel suo testo letterale, nudo e crudo, un appello da leggere in chiave pro-liberale, pro-Cocco Ortu a volerlo inquadrare negli orientamenti dichiarati della testata “indipendente”: quegli specifici riferimenti ai temi presenti nella propaganda dei partiti di massa – sul rischio di dispersione o sull’inutilità del voto alle forze di minoranza – erano, di tutta evidenza, portati al fine di incoraggiare una partecipazione ed un consenso all’area data pregiudizialmente per sconfitta, quella laica intermedia (dai liberali ai sardisti ai socialdemocratici).
Ubaldo Nieddu, già fascista in recupero liberale
Torno al 1958, per avviarmi nuovamente a riferire dell’inserto sul tremendo 1943 cagliaritano.
Ho accennato prima, fra una divagazione e l’altra, alle celebrazioni del 70° del giornale. Il Convegno di Nicola Valle e degli Amici del libro (e della Dante) uscì con un prezioso numero monografico dedicato al giornale: “Settantennio de L’Unione Sarda 1889-1958”. Quell’edizione speciale del mensile (datato ottobre) riportava una decina di testimonianze degli “uomini dell’Unione” nelle stagioni trascorse, da Pasquale Marica a Guido Scano, da Giuseppe Asquer ad Antonio Ballero, da Gino Anchisi a Mario Pintor, da Giuseppe Musio ad altri ancora, a Valle, a Leo, e i ritratti di Rafaele Contu, Antonio Scano, e in mezzo ancora Nino Alberti e Luigi Pompejano, Renato Manzini e Raffa Garzia e Rafaele Gessa…
Fra i pezzi – tutti gustosi – quello più gustoso di tutti, se mai sia possibile fare classifiche (sempre odiate), segnalerei quello di Ubaldo Nieddu (“Eroici lettori”) riportato anche sul quotidiano del 31 ottobre appunto 1958.
Lascio l’intero excursus di memoria ambientata in una borghese casa cagliaritana nel primo decennio del Novecento e l’originalissimo insegnamento paterno nella lettura del giornale, lascio anche il tratto di esperienza maturata da Nieddu come cronista de L’Unione negli anni di passaggio fra ’20 e ’30, fino al trasferimento a Roma fra le gerarchie intellettuali del regime, una volta perfino – perfino! – nella redazione di La difesa della razza! (e magari qualche collaborazione alle testate isolane, da Mediterranea a Pattuglia a Sud Est) e arrivo alla fine, ormai al secondo dopoguerra, alla metà o fine degli anni ’50 addirittura, quelli con Crivelli direttore.
Ecco una pagina, l’ultima, del bellissimo memoriale:
«Per chi hai votato questa volta?» chiesi a mio padre, rivedendolo dopo le ultime elezioni.
Esitava come se non volesse rivelare chissà quale segreto. Infine si decise, posò la mano aperta sull’ultimo numero dell’“Unione Sarda” che aveva davanti e disse: «Sai quanti anni ha questo giornale?».
«Lo so bene».
«Ricordo il giorno della sua nascita – riprese mio padre – perché era la prima volta che andavo a votare. Sono dunque settant’anni che voto liberale». Detto questo, sembrò rifugiarsi in un sogno particolare di baffi all’insù, di gilè fantasia, di bombette e scarpe di coppale.
Ora mi chiedo: che cosa sarebbero i Sardi e la Sardegna se, per settant’anni, tutti avessero sempre votato allo stesso modo? Chissà! Ma, forse l’“Unione Sarda” è rimasta soltanto il titolo di un giornale.
Ecco la testimonianza e la domanda di Ubaldo Nieddu.
Giuseppe Susini, essere liberale essere antifascista
Ho scritto molte volte, e non vorrei ripetermi, della doppia affezione: personale a Fabio Maria Crivelli e… istituzionale (anche da studio) al giornale da quando egli ne ebbe la direzione. Direi che per L’Unione, collaborazioni giovanili (e meno) a parte, ho un interesse sentimentale che rimonta alle letture quotidiane familiari, dalla fine degli anni ’50, e un interesse che chiamerei civico le cui origini collocherei nei primissimi anni ’70, quando in Biblioteca universitaria cominciai a macinare annata dopo annata (lì trovando anche quelle collezioni purtroppo perdute, nei maciulli della guerra, all’interno della sede di Terrapieno dove pure ho passato quotidianamente lunghi mesi, consultando le annate incomplete di prima della dittatura).
Su questi presupposti, nella tarda primavera del 2004 potei intervistare, presso la sua abitazione di via Petrarca, Giuseppe Susini ormai più che novantenne, che del giornale era stato il direttore per sei mesi, da giugno a dicembre 1946, e de L’Informatore del lunedì il fondatore e il direttore fino al 1949. Funzionario del Banco di Napoli sul piano professionale (quello che gli dava di che vivere), nel 1945 e ancora l’anno dopo, in dirittura di referendum ed elezioni dell’assemblea costituente, aveva diretto, con Francesco Cocco Ortu, il settimanale Rivoluzione Liberale, in stampa nella tipografia della SEI. Così conosciuto dai Sorcinelli, questi, riottenuta la piena disponibilità degli impianti e i diritti della testata proprio all’indomani del voto popolare, a lui chiesero d’emblée di assumere la responsabilità del quotidiano. Susini era anche critico letterario di fama nazionale, amico e sodale di Salvatore Quasimodo dai tempi della residenza cagliaritana di questi, giornalista nel senso lato del termine. In quanto liberale ed in quanto antifascista egli poteva senz’altro centrare i bisogni del giornale nell’indifferibile suo nuovo posizionamento: il passato ne assicurava la reputazione di distanza dal regime, il presente la fedeltà moderata o centrista. Del colloquio che ebbi con lui e della esperienza al giornale così come me la raccontò ho riferito nell’articolo “Dopo la guerra, nel ʼ46 lʼUnione scelse Susini”, uscito su LʼUnione Sarda il 9 luglio 2004, all’indomani della morte cioè..
L’ottica secondo la quale ho preferibilmente cercato ed analizzato le condotte del giornale, tanto più nei lunghi anni della direzione Crivelli, è stata quella politica: mi ha interessato comprendere i termini della convergenza, lungo gli anni ’50, con il liberalismo di Malagodi e Cocco Ortu (rivali interni al PLI) e della speculare contrarietà alla giunta regionale di Giuseppe Brotzu ed a quella comunale di Mario Palomba, così come della dura ostilità al centro-sinistra nazionale all’inizio del nuovo decennio e, dopo la nazionalizzazione dell’energia elettrica (che rivelò la generosità non proprio… bolscevica, come invece temuta, degli indennizzi alla SES e alle altre società di produzione e distribuzione dell’energia elettrica), il ripensamento critico e l’accompagnamento più o meno convinto a quella formula di governo identificabile nel nome di Aldo Moro. E ancora: ragioni e modi di una certa manifesta simpatia per il socialismo unificato, almeno per il tanto che l’unificazione resse proponendosi come tendenziale bilanciamento laico del prepotere democristiano…
In bilico, o nel percorso, fra diffidenza e affidamento – sia concessa quest'altra breve digressione –, Crivelli si mostrò piuttosto attratto da quanto si agitava nel movimento socialista italiano da sempre combattuto fra pulsioni riformiste e pulsioni massimaliste e ancora dogmaticamente classiste. Nel suo book professionale il direttore avrebbe inserito un giorno i suoi lunghissimi servizi particolari dal congresso PSI dell’ottobre 1963, quello che deliberando per l’intesa governativa e parlamentare di centro-sinistra – secondo la proposta Nenni – determinava anche la scissione della sinistra “carrista”, dei lussiani cofondatori allora del Partito Socialista di Unità Proletaria. E sarebbe molto interessante poter indagare, oltre la superficie, quale giudizio, fra editoriali e corrispondenze da quel XXXV congresso svoltosi all’Eur, egli formulasse anche immaginando le possibili proiezioni di quella svolta nella politica regionale ancora tutta presa dai piani esecutivi della Rinascita, dalle illusorie programmazioni industriali e dalla crescente pressione delle campagne sofferenti (in Sardegna l’intesa fra democristiani e socialisti ancora non si era realizzata, e sarebbe stata dunque coda degli accordi nazionali).
Superato il decennio, nuovi scenari sociali e politici si sarebbero dovuti affrontare, ed il giornale sarebbe stato chiamato a profilarne ancora eventi e protagonisti: dopo gli strappi eversivi di piazza Fontana e, nel 1970, di Reggio Calabria, con quanto derivò allora di rinforzo della destra monarco-missina a guida Almirante, L’Unione Sarda avrebbe mostrato qualche difficoltà di posizionamento per poi, a far data dal 1974 e contestualmente all’uscita in edicola del concorrente Tuttoquotidiano, opzionare una collocazione nell’area progressista, evidenziata anche da un corpo redazionale che fu allora irrobustito con fresche energie provenienti dal mondo universitario ed associativo segnato, apertamente o meno, dalla sinistra. Un attentato dinamitardo allo stabilimento di Terrapieno avrebbe bollato, per avversione neofascista, quella stagione.
Né si tratta soltanto di questo, dell’orizzonte nazionale cioè. Perché di estremo interesse mi sembrerebbe dover registrare anche gli orientamenti del giornale circa la politica attuativa della Rinascita e, ancora negli anni ’60, gli indirizzi degli investimenti pubblici o sostegno della industria di base e in specie della petrolchimica, la carica contestativa delle giunte Dettori e Del Rio anche con riferimento alle repressioni (con i baschi blu) del banditismo e, per altri aspetti, con riferimento alle risalenti correnti nazionalitarie e neosardiste che soltanto un decennio più tardi avrebbero espresso in pieno la loro portata antisistema (dalla teoria delle lingue tagliate si sarebbe arrivati alle proposte del bilinguismo perfetto, ecc.).
Proprio con riguardo particolare a queste ultime “micce accese”, mi parrebbe degna di speciale considerazione la “liberalità” degli spazi concessi a un esponente della politica sardista come Giovanni Battista Melis – certamente lontanissima da ogni velleitaria deriva nazionalitaria – negli ultimi anni della sua deputazione e dopo (cioè nel 1969-1970, alla consumazione del patto parlamentare con il PRI e data la scissione interna che avrebbe allora condotto fra i repubblicani un buon terzo della militanza guidata da Pietro Mastino e, nel Cagliaritano, da Armando Corona).
Se Francesco Cocco Ortu era l’amico e referente ideale e politico di Crivelli – che della sua memoria avrebbe scritto più e più volte –, certamente Giovanni Battista Melis rappresentava, nel mondo sentimentale del direttore, l’alfiere sempre da ammirare per il disinteresse personale e la prodigalità nel servizio della politica. (Nell’articolo “Nella compagnia delle belle minoranze anticonformiste. Fabio Maria Crivelli e quelle nottate a L’Unione Sarda discutendo una volta con Ciccio Cocco Ortu e un’altra con Titino Melis”, uscito il 29 ottobre 2018 in Fondazione Sardinia, ho cercato di documentare questo duplice amore per l’umanesimo sociale espresso dai due leader: nella gran quantità delle circostanze esemplificatrici avevo ricordato l’apprezzamento per la loro convergente proposta di sblocco della paralizzante crisi comunale di Cagliari del 1960 attraverso la candidatura autorevole di Giuseppe Peretti, rettore dell’università e infatti eletto sindaco, democristiano indipendente, nella primavera di quell’anno e rimasto in carica fino al rinnovo elettorale di novembre; ed avevo ricordato un garbato scambio di opinioni del direttore con alcuni lettori, prima e dopo le elezioni politiche del 1958, che videro l’insuccesso degli sforzi generosi tanto dell’on. Melis – nella lista d’alleanza con Olivetti – quanto dell’on. Cocco Ortu: cf. 6 aprile, 31 maggio e 6 giugno 1958).
1958, a casa Crivelli, in America e al giornale
Non sembri, a questo punto, un’indebita insistenza sulla dimensione personale, peraltro quasi mai scissa da quella professionale, del direttore se ancora un po’ mi soffermo su vicende che lo riguardano in quell’anno ancora singolarmente capitale: sul piano strettamente familiare per la nascita, a maggio, di Ornella, la seconda figlia cagliaritana, la quinta della nidiata, una creatura sfortunata in capo alla quale, nella clinica medica di via San Giorgio, si strinsero ancor più e per altri versi, nel 1989, certe nostre personali solidarietà…
Non era a Cagliari, al policlinico Lay, quando la bimba nacque a metà maggio di quel 1958. Era in America, Fabio Maria Crivelli, con altri colleghi di periodici o quotidiani nazionali ed esteri. Tornando avrebbe goduto della famiglia allargatasi di un’altra unità. E subito dopo avrebbe dato conto di quel viaggio da tempo programmato ed evidentemente non rinviabile: ne avrebbe riferito in una conferenza tenuta, ai primi di giugno, al Rotary club cittadino. Il cui testo, sbobinato da qualche collaboratore, egli avrebbe poi pubblicato a tutta pagina sul giornale del 9 giugno (titolo “Il giro dell’America in ottanta ore di volo” e occhiello “Impressioni di un viaggio attraverso gli Stati Uniti”; così il sommario: “A Washington si respira aria di provincia – Ventimila case nuove per i poveri di Filadelfia – Fiori senza profumo nell’impero dei Du Pont – «In questo paese potete comprare una bomba atomica, se avete denaro. Ma se perdete un bottone siete un uomo finito» – All’avanguardia del progresso tecnico, l’America riceve dall’Europa ogni soffio di vita spirituale”). Così in esordio:
«Vi prego di prendere il titolo di questa conversazione “Giro Volante degli Stati Uniti” in senso letterale. Perché d’un volo soprattutto si tratta, d’un lungo volo dall’Oceano Atlantico al Pacifico, attraverso buona parte dell’America, 22mila chilometri percorsi con un Convair, 26 giorni piuttosto intensi, con ricevimenti, visite d’obbligo, pranzi d’onore, che si prendevano buona parte della giornata. In complesso 80 ore di volo, e soste in dieci stati e in undici città fra grandi e piccole, oltre che in tre grandi basi aeree e in quella navale di Norfolk. Ma di queste non vi parlerò perché penso che di armi, di aerei, di missili ne leggete già abbastanza sui nostri giornali e piuttosto cercherò, imitando se possibile la rapidità con la quale il viaggio s’è svolto, di darvi qualcuna delle immagini che in un carosello così affannoso sono rimaste più in evidenza, immagini naturalmente più fotografiche e superficiali che complete ed esaurienti, e non potrebbe essere altrimenti…». (Conto di poter prestissimo, in coincidenza con il prossimo centenario della nascita, ripubblicare il resto integrale di quella conferenza/articolo, omaggio dovuto all’indimenticabile f.m.c.).
Crivelli osservatore del mondo fra meridiani e paralleli, Crivelli uomo perennemente diviso nel suo intimo, nel suo proverbiale riserbo, fra le nostalgie istriane della prima infanzia e l’oggi delle esperienze formative e professionali romane prima ancora che cagliaritane… Ogni anno Mario Pintor, che la prima guerra mondiale aveva combattuto sul fronte nord-orientale antiaustriaco, soleva pubblicare un articolo di memorie. Proprio nel 1958, segreto omaggio al suo direttore, ne aveva confezionato uno così titolato: “Oltre le transenne del confine la bianca visione di Capodistria” (occhiello “Itinerari triestini”, sommario “L’improvvisa scoperta della città ai piedi del colle. Un carabiniere sardo alla frontiera”. E a Capodistria-Koper, rivisitata da anziano, o quasi anziano, negli anni ’80, il direttore avrebbe dedicato alcune sue nuove pagine tenerissime).
Pressoché negli stessi giorni del flash istriano un secondo ne era accolto dalla pagina culturale del giornale: il “Ricordo di Ruggero Ruggeri” nel quinto anniversario della morte. A firmare l’articolo il celebre critico teatrale Giuseppe Lanza. Indiretto, segreto omaggio al direttore che per il grande attore aveva sempre mostrato, sia pure discretamente, un’autentica venerazione? Lo aveva conosciuto ai tempi delle prime rappresentazioni di Questi nostri figli, la commedia ch’egli aveva scritto fra il 1950 ed il 1951, il cui testo venne integralmente pubblicato dal mensile milanese Il dramma (15 gennaio 1952). Il lavoro, in tre atti, fu portato sul palcoscenico dell’Excelsior meneghino, appunto dalla compagnia Ruggeri, il 30 novembre 1951, ed in replica a Roma e altrove ancora.
(Non sarebbe stata però la celebrata compagnia di Ruggero Ruggeri e Giovanna Caverzaghi, Germana Paolieri, Mario Colli ecc. a portare in Sardegna, nell’ottobre 1960, quei tre atti allora ampiamente rivisti dall’autore d’intesa con il regista Giacomo Colli: il compito sarebbe toccato a Fosco Giachetti, Vivi Gioi, Liliana Trouché e Mario Valdemarin, ecc., ad una più giovane generazione di attori cioè, come il copione richiedeva. E fu successo, al Massimo di Cagliari, al Verdi di Sassari e all’Eliseo di Nuoro).
Ormai pienamente inserito nella vita cagliaritana (ma pur sempre alieno alla mondanità e capace di ritrarsene con buon mestiere), nella forza e nella lucidità dei suoi 37 anni che ne valevano cinquanta e più per l’autorevolezza subito conquistata in redazione e nelle relazioni, ancora per buona parte del 1958 – circa quattro mesi – Crivelli decise di rinunciare alle funzioni di editorialista preferendo riservarsi per i “Colloqui domenicali” – così il titolo della rubrica inaugurata nel novembre dell’anno precedente – con i lettori. A censirli oggi, scorrendo le collezioni ingiallite del quotidiano, sono in tutto qualcosa come venti e più appuntamenti, qualcosa come cento interlocuzioni, direi libere e piane e oneste interlocuzioni sugli argomenti i più vari... Era risaputo (nel giornale di cinquanta e più anni fa) l’importanza che egli annetteva alla “posta dei lettori”. Gli pareva che il giornale guadagnasse meriti speciali, tutti morali, tutte le volte che, nelle complessità geometriche dei menabò, il capo redattore trovava spazio – uno spazio protetto e intangibile – per le esternazioni, talvolta lunghe o lunghissime, dei quidam di città e provincia, del Sulcis o del Nuorese… (Con i “Colloqui domenicali” si cercò di sperimentare una pagina delle rubriche comprensiva de “La foto della settimana” e de “Il parere del medico”).
I settant’anni de “L’Unione”
Nel 1958 partirono le celebrazioni, o autocelebrazioni – autocelebrazioni legittime, direi doverose – del giornale che arrivava ai suoi settant’anni.
Domenica 30 novembre quasi duecento corrispondenti da tutti i centri dell’Isola si dettero convegno in sede ed i Sorcinelli con il consigliere delegato Porcu e, naturalmente, il direttore responsabile del giornale li accolsero accompagnandoli nella visita dello stabilimento, anche e soprattutto alle tipografie dove i loro pezzi dattiloscritti erano impaginati. Furono messi al corrente del dettaglio tecnico delle fascinose procedure della composizione e delle rotative… A tutti il direttore spiegò poi come operasse la catena distributiva delle copie e degli sforzi in corso perché anche il più piccolo centro fino ad allora escluso potesse entrare nel giro e ricevere, dalle corriere se non ancora dalle macchine aziendali, il mazzo del quotidiano.
Tutti poi nella sede degli Amici del libro. Parlò il presidente Efisio Corrias (che per suo conto, e con alcuni dirigenti della Regione, avrebbe visitato la sede di Terrapieno qualche settimana dopo), prese quindi nuovamente la parola il direttore che, con la sua solita sintesi – poche parole ma chiare – e… un marcato accento romano che, facendo sorridere e forse anche intimorendo i sardi del Bosano o del Guspinese o chissà di dove, tenne una vera lezione su cosa sia e come vada trattata una “notizia”. Riferì sugli obiettivi di sviluppo e sulla permanente missione de L’Unione Sarda nella vita civile dell’Isola e – ricevuti i consensi di Nino Tola (corrispondente da Nuoro), dell’avv. Dore e di Nicola Valle, storico collaboratore - invitò infine tutti a trasferirsi all’albergo Excelsior, nella via Roma, per una colazione… di famiglia.
Antonio Ballero colse l’occasione per imbastire un suo spumeggiante colonnino su L’Informatore dell’indomani: “L’auspicio di un raduno”, e il ricordo della distribuzione del giornale in un tempo lontano… E per un po’, del 70° compleanno de L’Unione Sarda, avrebbero parlato e scritto in molti, cominciando da Francesco Alziator (concentrandosi sulla “terza pagina” culturale) e da Pietro Leo…
Giovanni Gronchi e l’inserto doloroso
L’anno era però partito con le cronache della visita del presidente della Repubblica nei tre capoluoghi provinciali e al medio Flumendosa per la inaugurazione della nuova colossale diga, una delle maggiori in Europa. Molte le pagine speciali de L’Unione Sarda (e naturalmente anche de La Nuova Sardegna), numerosi gli articoli di cronaca – mobilitati in primo luogo Peppino Fiori e Gianni Filippini della redazione ed anche collaboratori del giornale. In vari incorniciati i saluti dei sindaci delle città (Piero Masia per Sassari, Pietro Mastino per Nuoro) per la presentazione alla massima autorità dello Stato dei titoli e dei bisogni locali.
In linea, naturalmente, il fondo di Crivelli, sabato 1° febbraio, dal titolo “Il saluto dell’Isola” tutto impostato sui nessi obbligati Sardegna/Italia, dovendosi tradurre – la visita presidenziale – in «un felice, festoso e concreto incontro fra un popolo fiero delle sue tradizioni e tutto proteso verso un migliore futuro e l’uomo che nella sua altissima carica rappresenta per tutti gli italiani, di ogni regione, di ogni condizione sociale, di ogni fede politica, la continuità dello Stato e l’unità della Patria».
«Sbarcando a Cagliari – questo uno dei passaggi più rilevanti dell’articolo – egli vedrà una città che quindici anni fa sembrava cancellata dalla carta geografica e che oggi si protende sul mare quasi tutta nuova, ardente di vita, sintesi singolare di contrasti fra iniziative operose e progettazioni disordinate o trascurate o non risolte, una città che è risorta in un ritmo febbrile ma senza un piano preciso, una città in cui convivono spesso fianco a fianco il nuovo e il vecchio, il bello e il brutto, l’opulenza e la miseria. Cagliari veramente apparirà al Presidente Gronchi come la naturale capitale di un’Isola in cui tali contrasti sono ancora, ovunque, una regola, il segno e la caratteristica di una terra in trasformazione, di una regione che faticosamente sta riguadagnando il tempo perduto e che nell’ansia di progredire non sempre trova subito la strada giusta, la via più breve.
«Ma poi da Cagliari, andando sulle dighe del Flumendosa, il Capo dello Stato vedrà un altro capitolo… Vedrà nascervi il profilo di una nuova terra, di quella che sarà un’altra Sardegna, una Sardegna che attraverso un’opera ciclopica colmerà finalmente la sete secolare dei suoi campi e dei suoi abitanti…
«A Sassari, città saggia, colta, animata da fervidi e operosi impulsi, e a Nuoro, città maschia e indomita, il Presidente troverà il volto più tradizionale e più genuino della Sardegna, ancora saldamente attaccata al suo passato e pur aperta ai nuovi problemi, troverà regioni in cui molto si è fatto e in cui ancora c’è molto, troppo da fare…
«Ed è un peccato che altri centri non possano essere inclusi nella rapida visita del Presidente Gronchi: Carbonia, fra gli altri, al cui nome è legato un problema doloroso e vitale per tutta la Sardegna, e Oristano, pervasa da un febbrile fervore di vita, da troppi mesi lasciata in ansiosa attesa del compimento di una promessa nella quale è impegnato il più illustre parlamentare dell’Isola» (chiaro il riferimento all’on. Segni e alla promessa della quarta provincia).
Il presidente vedrà – ecco la conclusione dell’articolo – «Un volto complesso in cui sofferenze, fierezze e speranze si mescolano e si compongono», ma anche – e sarebbe questa una annotazione degna di speciale rilievo – «un grato animo e deferente affetto» di «fedeli italiani».
Questa la motivazione (inevitabilmente, forse, retorica e roboante) della medaglia d’oro al gonfalone di Cagliari: «Capoluogo dell'Isola Nobile e Generosa, scolta invitta d'Italia al centro del Mediterraneo, sopportò per anni, con l'indomita fierezza della sua gente, lunghe, terrificanti ed assillanti distruzioni di guerra recate dall'intensa offesa aerea. Fiera del suo destino, accolse con fierezza ogni prova dolorosa. Dilaniata, stroncata e ferita a morte, non smentì mai le sue alte civiche virtù e la fama gloriosa acquisita nei secoli dal suo popolo eroico, sublime in ogni sacrificio per l'onore della Patria. Sardegna-Guerra 1940-43».
E l’inserto del giornale. Ad ognuno dei partecipanti il suo. Gli otto autori – due per pagina (Serra poi doppiava con alcuni versi poetici) – la raccontarono, la vicenda della «morte» e/o della «resurrezione», da un punto di vista particolare, in una logica musiva, traendo così ispirazione per il proprio contributo dalle esperienze maturate sul campo. Eccoli i titoli (nella sequenza dell’impaginato): Cocco Ortu, “Non volle morire”, Alziator “I santi cadevano uno ad uno”, Lorrai, “Perché?”, Fiori, “Non bastava la maschera”, Ballero, “Notte nelle caverne”, De Murtas, “Lungo viaggio senza una meta”, Serra, “Sfollati”, Leo, “Una Cagliari nuova”.
Taluno degli articoli è poi rifluito in raccolte uscite in volume, segnatamente quello di Ballero e quello di Alziator: il primo, con il titolo “Notte delle caverne” in Le case di fango. Cagliari ed altri scritti, Roma, Serafini editore, 1985; il secondo, senza titolo, in L’Elefante sulla Torre. Itinerario cagliaritano, Cagliari, 1979 (e in successive ristampe).
Sarebbe proposito santo se il giornale programmasse, per il prossimo futuro, una ristampa in reprint delle quattro pagine da donare ai lettori. Occasione buona, forse, anche per onorare ciascuno di quei testimoni che a noi offrirono racconto ed emozioni, il loro dolore per la tragedia vissuta, la loro speranza di una vita tutta da riagguantare. Io aggiungerei: in pace, certo, ma anche in democrazia, in democrazia certa, in democrazia repubblicana.
Da Alberto Lorrai
«…Il principio dei bombardamenti indiscriminati, imposto dai tedeschi sin dall’inizio della guerra, era stato dottato dagli americani che disponevano di armi capaci di attuarlo con terribile efficacia. Se ne avevano già fatto triste esperienza altre città italiane perché si doveva sperare che Cagliari aperta sul mare davanti alle basi nemiche, sarebbe stata risparmiata?
«L’evacuazione della popolazione civile dalla città doveva essere ordinata sin dal gennaio 1943; molte vittime innocenti sarebbero scampate al massacro.
«Il 26 ed il 28 febbraio quando i piloti dei B 17 e dei Liberator sganciarono le bombe certo non si resero conto della tremenda tragedia che si svolgeva settemila metri sotto di loro, dove, sotto una nuvola acre di fumo e di polvere ogni raffica di bombe induceva nelle vecchie mura le convulsioni dell’agonia. Sotto questa nuvola i cagliaritani componevano il loro dolore e nell’esodo triste, ma muto delle reazioni che il nemico si proponeva dei suscitare, mostravano i segni di una battaglia che non avevano perduta e davano una prova di coraggio e di compostezza che per l’avvenire dovrebbe suggerire la ricerca della vittoria per vie meno crudeli…»

Da Francesco Alziator
«… La prima guerra mondiale la Città l’aveva vissuta solo sulle lettere dei Cagliaritani lontani, nei bollettini di Cadorna e di Diaz e nell’anilina pallida dell’oscuramento dei pretenziosi lampioni del Largo Carlo Felice e della Via Roma.
«Ora la guerra le era veramente addosso, incredibile e feroce come nessuno aveva pensato che potesse succedere, nel doloroso finire di quel febbraio rifatto pieno di vento boreale e piovoso ed ogni passo scricchiolava di calcinacci delle macerie e tra la mota desolata durava il sangue rappreso. Allora cominciò per la Città l’inutile martirio.
«Con le case della gente comune e i palazzi dell’aristocrazia vennero giù le chiese più famose. Cagliari non aveva cento chiese come Roma, ma ne aveva tante lo stesso, tante e belle e là erano le testimonianze della sua storia: nel Duomo giuravano gli Stamenti; a Sant’Antonio giuravano i Gremi; a Bonaria pregavano tutti. Sotto il pavimento delle più antiche dormivano gli antenati di mezza città.
«Ognuno di noi aveva sempre guardato con affetto particolare alla chiesa del suo battesimo, della prima Comunione, delle nozze e della Cresima. Ognuno di noi aveva la sua Chiesa, che non era magari la sua parrocchia ma quella del suo Santo più invocato o dei ricordi più custoditi. E le chiese caddero ad una ad una.
«Fu Sant’Anna, per prima, con l’orribile squarcio della bella cupola, ad aprirsi come una cavità di sepolcro. La statua del Beato Amedeo, mozza e infranta fra i resti della navata colpita, pareva una statua imperiale travolta dai Barbari…».

I versi di Marcello Serra
«Frana la terra a spasimo di schianti:
ogni luce s’abbuia,
s’accascia ogni pensiero
come veltro battuto.
Or centomila uomini supini
con le viscere attorte
rapina e miete un panico maligno.
«- Vergine di Bonaria, una tua grazia!
proteggete, salvateci, Signora,
non ha peccato questa mia creatura!
O Santo Efisio martire, perdona,
dov’è mio figlio? guardalo dal male!
Gesù, mio Dio, son giovane, ho paura;
Gesù, Signore, stendi la tua mano.
«Tutto crolla d’intorno, Anime Sante,
pietà di noi: Stammi vicina, mamma!
Signore Iddio, perché tu ci abbandoni?
«Il cielo torbo introna la ruina:
il mondo è una maceria
e l’Anticristo sprona i suoi destrieri
ed inarca vermigli fortilizi
da divelti quartieri.
«Dove più il sole? la florida marina,
la mia nitida casa e quel balcone
dove indugiavi all’ora mattutina?
«Ad una sosta, un bimbo adulto prega:
-o madre mia, conforta;
non pianger più, egli non può tardare! –
Ed ancora, profondo, un vento squarcia
ululando alla terra disumano
e spazza ogni sembianza.
«S’abbioscia un campanile e svela in fuga
un nudo di navate:
come un gioco spettrale, la campana
rintocca la sua morte.
Alberi proni snudano radici
e capovolti gemono: riverso
tra loro foglie un bimbo sogna eterno.
E il vento ringhia e spiana il camposanto:
rizza sepolcri assorti
scrolla divelti tutti i nostri morti.
Fosca riga di scheletri s’addensa
agli inerti cipressi, o si raccoglie
in attesa alle soglie.
Come a vespro il mandriano nello stabbio
la Morte fa la conta dei suoi morti.
«L’ultima cattedrale ossificata
arrossa in fiamme spera di foschia;
lampeggia morte su arroccate case,
folgore rompe folgore sul mare:
ogni baleno un seme di follia,
che accima da memoria per millenni.
«- Mamma, è finito: senti, sono andati:
mamma, vedi, ancora s’è salvato
il pesco in fiore: ride nel giardino;
perché taci, perché sei così bianca?
ormai tutto è passato
mamma, torniamo. E’ fredda la tua mano:
rispondi… parla… mamma mia, ho paura».

Da Angelo De Murtas
«… Fuggirono quando ancora la polvere delle rovine e il fumo delle navi che bruciavano nel porto facevano sulla città una nuvola bassa e densa. Presero con sé quel che poterono (i materassi: come se ad essi si affidasse l’ultima speranza di sopravvivere, e racchiudessero, in seme, il benessere immemore del sonno e il tepore sicuro della casa: perciò furono diligentemente ripiegati e posti sui veicoli della fuga: il manubrio di una bicicletta, la carrozzella del bambino più piccolo. E parve che i cagliaritani fuggissero, non per vivere, ma per dormire). Lasciarono le case. Era, per i più, una fuga senza meta, o, piuttosto, verso una meta vaga e incerta: la salvezza. Molti la cercarono nei campi, altri nei rifugi scavati nella roccia; soltanto pochi trascorsero nelle case quest’ultima, conclusiva notte di febbraio. Dalle strade veniva il rumore dei colpi di piccone che si affondavano nelle macerie, le voci degli uomini che sotto le travi schiantate cercavano brani di carne; dalle finestre si affacciavano, più alte dei tetti, le vampe degli incendi. E in quel silenzio sospeso, sotto il cielo rosso, i superstiti udivano, in ogni suono, il gemito di un morente. Quella notte non conobbe il sonno.
«I sopravvissuti si trovarono, molto prima dell’alba, alla stazione delle ferrovie complementari, o a San Paolo, da dove partivano i treni delle ferrovie dello Stato. Per quei due punti passavano le vie della salvezza. Quali criteri avevano presieduto allo smistamento dei cagliaritani fra le due stazioni, fra i due treni che fuggivano dalla città distrutta, uno verso est, l’altro verso nord? L’ordine provinciale, un legame di parentela, il ricordo di una lontana villeggiatura, l’affiorare alla memoria del nome di un paese sconosciuto, o anche soltanto la maggiore vicinanza ad una delle due stazioni, insegnarono a ciascuno la via della fuga. Andare verso oriente, andare verso settentrione, del resto poco importava; i naufraghi non scelgono la direzione nella quale li porterà il relitto cui sono aggrappati…».

Da Marcello Serra
«… Solo una minoranza, avendo già stabilito dove rifugiarsi, era partita da Cagliari con una destinazione precisa. Il resto della popolazione invece, dopo essere stato risucchiato dal panico fuori della città massacrata, si sparpagliò nell’isola come una nuvola torbida di uccelli incalzati da una tempesta apocalittica, e andò a sbattere nei luoghi più impensati […].
«In quei paesi, non molti in verità, dove la popolazione si dimostrò ostile o indifferente, oppure tardò a venire in soccorso, la condizione di quegli infelici diventò lacrimevole. Chi non ricorda le lunghe code dei più miseri presso gli spacci sforniti, dinanzi alle languide fontanelle, all’ingresso delle case comunali, alle porte degli asili? […].
«Questi fatti incresciosi si verificarono soprattutto dove l’afflusso fu più massiccio, dove con l’arrivo di tante migliaia di profughi la popolazione normale, in pochi giorni, risultò triplicata ed anche quadruplicata. Questa invasione repentina era inevitabilmente destinata a squilibrare in maniera paurosa la pace arcaica di quei piccoli centri, l’ordine e la vita degli abitanti […].
«I torti comunque non furono da una parte sola: le polemiche o i dissidi, sorti da quell’incontro improvviso e forzato, furono talvolta inaspriti dallo scarso spirito di adattamento di certi sfollati, dalle loro proteste, dalla loro insofferenza, espressa con termini incauti, dinanzi alle deficienze di quei paesi, alla loro attrezzatura primordiale, all’esistenza rudimentale degli abitanti.
«Molti cagliaritani infatti scoprivano soltanto allora la Sardegna, le sue regioni più povere ed oscure, i suoi villaggi arretrati e negletti, la miseria di certe famiglie, che era rimasta finora dissimulata gelosamente dietro i muri di fango e di pietra grezza e che adesso veniva alla luce tutta insieme e senza veli.
«Essi, che non avevano mai visto questa faccia spettrale dell’isola, che non immaginavano neppure questa realtà dolorosa, perché in sostanza, come la maggior parte dei sardi, sapevano così poco della propria terra, si meravigliarono di quel che si rivelava ai loro occhi e non riuscivano a dissimulare questo stupore offensivo…».

Da Antonio Ballero
«… Gli uomini erano tornati nelle caverne contendendosi lo spazio e contendendolo ai topi, giganti e famelici, guizzanti dalle tane sotterranee. Uomini e topi. Insieme sotto lo stesso tetto di roccia, lungo le gocciolanti pareti, durante la spartizione del magro pasto, negli angoli umidi e bui dove aveva trovato posto il giaciglio. Con le grida e i lamenti, con il lungo piangere dei bambini, con l’eco spaventosa della promiscuità miserabile e lurida, pesante ed asfissiante tanfo scaturiva dalle brevi aperture protette da improvvisate paratie di legno e di cemento e dilatava oltre la soglia. E gli occhi, gli occhi smarriti nella tenebra, quasi ciechi per la tenebra, tentavano di fissare la luce dal profondo degli antri, vagando di spiraglio in spiraglio, scoprendo di spiraglio in spiraglio, a tratti ed a momenti miracolosi miraggi di verde e di azzurro, e dopo questo intercalare del monte e del mare, ancora a tratti ed a momenti, brandelli della città: della città morta.
«La città era morta in un meriggio di febbraio rantolando col mulinello di una immensa nube di polvere e gli abitanti più non avevano voluto vederla, fuggendo prima che la nube si dissipasse, prima del sinistro bagliore degli incendi quando, sopraggiunta la notte, bruciando le navi nel porto, le alte fiamme la illuminarono: e fu una apocalittica visione. Partiti i treni nella notte, treni di grappoli umani, snodatasi su tutte le strade fuori porta l’interminabile teoria delle macchine, dei carretti carichi di masserizie, delle famiglie costrette e percorrere a piedi il cammino, la città restò con le sue macerie. Le macerie, rovinio di case quasi le avesse risucchiate un cratere, prospetti ed angoli di case come quinte di scenari su un palcoscenico in disordine, selciati di strade rigonfi o inabissati, cumuli di pietre e frantumi di mattoni, saracinesche contorte, pendule ringhiere di balconi, cornicioni tremuli sul ciglio, porte spalancate nel vuoto, precipizi improvvisi e improvvise barriere e la polvere: polvere, polvere, polvere. E nella immensa polvere i morti ancora senza sepoltura, i corpi dilaniati e martoriati, le tracce di sangue, l’acqua sprizzante dai tubi rotti, i colombi impazziti, i cani randagi, i vasi di geranio abbandonati nei davanzali, i bambini seduti su un gradino con un gatto sulle ginocchia ed ai quali nessuno, passando o sostando, si rivolgeva, nessuno chiedeva cosa facessero…».

Da Peppino Fiori
«…Dopo l’uragano ci abituammo a vedere con occhi diversi quei lati della vita cittadina che in tempi normali inclinavamo a giudicare, per nostra sazietà, molesti e scoloriti. Le serate al Bastione, il turbinio nella via Roma, certi angoli di caffè, i soliti luoghi di sosta all’uscita dalla scuola e insomma itinerari, consuetudini e schemi di vita per i quali avevamo talvolta sbadigliato adesso andavano accumulandosi nella nostra memoria glorificati dal rimpianto. Vivevamo (parlo delle poche migliaia di persone rimaste per diversi motivi a Cagliari anche dopo i bombardamenti del febbraio 1943) in una città decomposta, dove le strade in certi momenti addirittura selciate di topi e le case sbilenche e le condutture aperte e fradicie di limo effondevano un afrore di cosa putrefatta. Ricordo la prima volta che, spinto da malinconica curiosità, mi avventurai in via Roma.
«Era una sera lucida, il maestrale aveva pulito il cielo dando all’aria trasparenza di cristallo. Nella luce bianca, la via Roma mi apparve nuda, spettrale. I tronchi marciavano sul marciapiede un tempo alberato, saracinesche sventrate, il manifesto di un film incollato dal vento su un frammento di porta.
«Camminavo a passi lenti: nel silenzio li sentivo di una sonorità allucinante. E intorno a me case vuote, pali divelti, colonne prostrate, muri anneriti dal fumo degli incendi.
«Adesso quelle pietre (quanti infantili trasalimenti tra quelle pietre e quanti visi lì conosciuti e quante idee e quanti sogni maturati tra portico e portico), quelle pietre fredde e sbrecciate che sino a qualche mese prima sembravano suscitare in me solo noia – mi pesavano, mi pesavano, mi pesavano sul petto.
«Immerso nel clima di tragedia, ero lontano dall’immaginare che presto al cigolio delle carriole trainate dagli alpini per lo sgombero delle macerie si sarebbe sostituito l’affannoso respiro della città risorta…».

Da Francesco Cocco Ortu
«… Ma Cagliari in fondo rifiutò di completamente morire anche nelle ore più buie. Visse ancora nelle grotte della periferia cui erano rimaste abbarbicate alcune centinaia di famiglie, nelle superstiti case della periferia con rifugi naturali, ben più sicuri di quelli artificiali degli uomini dalle striscioline di carta sui vetri. Ed appena poté riprese a vivere oltre che per sé per la Sardegna e l’Italia in quella grotta dalla quale parlò con un apparecchio di fortuna proprio da Cagliari distrutta la prima Radio Sarda “Qui Radio Sardegna: libera voce d’Italia, fedele al suo Re" e le note di “Il Piave”.
«Quanti Sardi, quanti Italiani, nell’udire quella voce, mentre sentivamo che la vita riprendeva oltre la distruzione e la morte, indovinavano quella grotta, non lontana dalle grotte fenicie della collina, della città più volte millenaria risorta, dalla quale partivano le nuove prime parole di fiducia e speranza? Quanti regolando l’ora sul segnale orario di quella radio indovinavano quel bossolo, appeso alla volta, sul quale si percuoteva con un pezzo di legno e non con l’ora di Monte Mario o di Greenwich, ma con l’ora media degli orologi di tutti i presenti?
«Volontà di vivere. Di vivere ad ogni costo.
«Poi dalla grotta uscì la radio, dalle grotte e dalla periferia rifluirono al centro gli uffici ed intorno al profilo antico delle torri salvate dalla tempesta di fuoco, per la laboriosità di cui una generazione di Cagliaritani può andare orgogliosa fu la realtà viva e pulsante di una grande città risorta».

Da Pietro Leo
«… il piano di ricostruzione, già reso esecutivo fin dal 1949 con la firma dell’Alto Commissario Regionale, non poté entrare nella sua fase di attuazione se non molto più tardi per le solite difficoltà burocratiche e solo dopo che lo Stato aveva concesso un contributo di circa mezzo miliardo per il primo stralcio. Ma altro finanziamento sarà difficile poter ottenere e ci si dovrà contentare di quello che si è fatto o che si sta attuando: apertura della grande strada che da Piazza Yenne porta ai complessi ospedalieri e dall’altra che dal Largo Carlo Felice porterà a Sant’Avendrace. L’Amministrazione comunale non può assolutamente pensare ad attuarlo in pieno con mezzi propri, tanto più che anche il già fatto, pure col contributo dello Stato, ha notevolmente inciso sulle finanze municipali, perché si è dovuto naturalmente provvedere a dare alloggio alle famiglie che hanno forzatamente dovuto sgomberare le case demolite. Diciamo sin da ora che lo stesso problema si porrà quando sarà pronto il piano regolatore, perché se è facile imbastire progetti, difficile è trovare i mezzi, a meno che non si voglia gravare troppo i contribuenti.
«Del resto molto di quello che è stato fatto nel campo della ricostruzione appare superato perché troppo spesso si è rimasti aderenti al principio di rimettere le cose nel pristino stato, come per esempio è avvenuto per le due stazioni ferroviarie, quella dello Stato e quella delle Complementari, di cui sente sempre più evidente l’opportunità del trasferimento se non si vuole intralciare l’ulteriore sviluppo urbanistico…».

Lawrence e Vittorini, e Levi, e un giornale nella tragedia e nella nuova vita
Così gli scrittori de L’Unione Sarda convocati da Fabio Maria Crivelli a comporre uno speciale di straordinaria cultura civica. Di questo non parlai mai, non ce ne furono le occasioni forse, con il direttore: per capire quanto da queste colonne di alta scrittura entrò nelle sue consapevolezze di nuovo sardo che già aveva marciato per Cagliari e l’Isola tutta, nello sforzo generoso di conoscere la terra e le terre cui ogni giorno offriva il lavoro suo e dei suoi colleghi. Posso immaginare che molto, molto entrò nelle sue vene e dunque nelle sue responsabilità di servizio alla Sardegna.
Chiudo qui. Avevo accennato, all’inizio di questo lungo scritto affabulatorio, alle riflessioni di Crivelli giunto ormai ad una età matura intorno alla città che sposò alla fine di dicembre del 1953 e scoprì la prima volta vedendola, come Lawrence (che ne lascia traccia in Sea and Sardinia), dal mare, come Lawrence e Vittorini (in Sardegna come un’infanzia) e magari anche Carlo Levi (in Tutto il miele è finito)...
Lawrence, gennaio 1921: «Ed ecco, d’improvviso, Cagliari: una città nuda che sorge ripida, ripida e dorata, ammucchiata spoglia dalla pianura verso il cielo, al vertice della vuota insenatura informe. E’ strana e un po‘ incantata, non ha nulla di italiano. La città si ammucchia verso l’alto e nobile e quasi in miniatura, e mi fa pensare a Gerusalemme: senza alberi, senza riparo, sorge così un po’ nuda e fiera, remota come se fosse rimasta indietro nella storia, come la città di un messale monastico miniato. Ci si domanda come sia capitata qui. E sembra Spagna, o Malta: non Italia. E’ una città ripida e solitaria, senza alberi, come in un’antica miniatura antica. Ma ha pure qualcosa del gioiello: un nudo gioiello d’ambra che si apre improvviso, a rosa, nel profondo dell’ampia insenatura. L’aria soffia fredda e pungente, il cielo è tutto grumi. E quella è Cagliari. Ha uno strano aspetto, come se si potesse guardarla ma non penetrarvi. E’ come una visione, un ricordo, qualcosa di tramontato. Impossibile poter veramente camminare in quella città: metterci piede e mangiare e riderci. Ah no! Eppure le navi scivolano sempre più vicino, e stiamo cercando il porto…».
Vittorini, settembre 1932: «La città ci è apparsa sopra un monte metà roccia e metà case di roccia, Gerusalemme di Sardegna […].
«[Alla Scala di Ferro] Mi sento in un vero albergo d’una vera città, ma non d’una qualunque città, anzi d’una stranissima, diversa da tutte le altre come le conosco e come le immagino. Perché – non so spiegarmi. Vedo mare, vedo piroscafi, vedo gente, vedo automobili, vedo tranvai, vedo case, vedo alberi, vedo quanto è molto comune vedere ovunque, e tuttavia sento che Cagliari è una città diversa da qualsiasi altra.
«E’ fredda e gialla. Fredda di pietra e d’un giallore calcareo africano. Spoglia. Sopra i bastioni pare una necropoli: e che dalle finestre debbano uscire corvi, in volo. I tetti sono bianchi, di creta secca. Da qualche muro spunta il ciuffo nerastro, bruciacchiato, d’un palmizio. Ma non è Africa. E’ ancora più in là dell’Africa; in un continente ulteriore, dove sia città essa sola. Attorno la terra sfuma in nulla; logora di stagni e saline che sembrano spazi vuoti, spazi puri. E il mare, al di là del cerchio delle gettate, anche lui è di nulla; d’una bianchezza di mare morto.
«Ma uscendo dall’albergo sull’or di notte mentre s’accendono i lumi, mi trovo dentro una folla singolarmente vivace, in un brulichio di folla, che non è di gente che cammina e s’incontra, come ovunque, ma quasi di gente che ròtei intorno a se stessa. Un verminìo […]. I caffè, con tutti i tavoli fuori, sono zeppi…».
E’ pittura letteraria, impressionismo puro, e poesia.
Carlo Levi, maggio 1952, dicembre 1962: «E’ una città bellissima, aspra, pietrosa, con mutevoli colori tra le rocce, la pianura africana, le lagune, con una storia tutta scritta e apparente nelle pietre, come i segni del tempo su un viso: preistorica e storica, capitale dei sardi e capitale coloniale di aragonesi e di piemontesi; una delle più distrutte per i bombardamenti dell’ultima guerra, e, in pochi anni, una delle più completamente ricostruite.
«Cagliari è stata rifatta, mi dicono, col danaro e l’opera dei cagliaritani: cosa assai diversa da quella eternata nel bronzo nel cuore della città. Qui sorge la statua del re Carlo Felice, mascherato da antico romano, con toga e mantello di ermellino, o forse di agnello, e il braccio oratoriamente protesto, a proteggere o a benedire, come un santo […].
«Alla “Scala di ferro” entro, e mi fermo a colazione, per la curiosità di ritrovare un luogo fissato per sempre sulla pagina, in un libro che, se anche può parere poco felice nelle sue tesi, è però ricco di autorità poetica e visionaria, sì da poter servire paradossalmente di guida o di richiamo della memoria, il Sea and Sardinia di D.H. Lawrence. L’albergo è rimasto in piedi tra una bomba e l’altra: sotto, si apre la vista dei ruderi di un recente Foro, un teatro distrutto. C’è un’aria simpatica qui: nel giardino sono stese le maglie della squadra gloriosa del calcio, coi numeri bianchi cuciti […].
«Macerie se ne vedono ormai poche; interi quartieri nuovi si allargano verso il mare: la città è cresciuta. Vicini uno all’altro sono i monumenti storici, la chiesa degli Stamenti, il palazzetto spagnolo di Carlo V, la Prefettura piemontese, il Vescovado; poco più in alto, davanti a una casa aperta e diroccata, paradiso dei bambini che vi hanno graffito e dipinto certe loro figure magiche, ragazzi giocano con un fuoco di sterpi. Più su, l’Arsenale è crollato: la facciata vuota, a pochi passi dalla cava torre pisana, e dalle celle per i prigionieri “aegrotantibus” benignamente tagliate nella rocca da un re di Piemonte, sembra un perfetto palcoscenico antico.
«Anche la Passeggiata Coperta, più sotto, è in parte crollata: ma in questo ultimo esempio cagliaritano di stile coloniale già tardo e imbarbarito al contatto con l’accademia italiana ed i primi fermenti classico-imperiali, si sono installate da mesi trentasette famiglie che hanno perso la casa per le inondazioni dell’autunno scorso, questo autunno 1951, così piovoso e rovinoso. E’ lo spettacolo ormai troppo consueto del dopoguerra: dei tramezzi di legno e di latta, dei mobili accatastati, dei bambini formicolanti. Altre famiglie abitano invece in grotte, come a Roma al Viale Tiziano sotto i Parioli, o dietro il Campidoglio o tra gli archi degli acquedotti: ma le grotte di Cagliari sono forse più impressionanti di quelle di Roma, e forse altrettanto antiche di quelle di Matera. Le trovo, oltre il Buon Cammino (che è il carcere, così come Bonaria era il luogo di malaria) sul colle di roccia che sta sopra il quartiere operaio di Sant’Avendrace. E’ una montagna cava, bucata, brulla, bruciata dal sole; una specie di maligno e grandioso deserto meridionale, dove, come gli eremiti nella Tebaide, si sono rintanati qua e là uomini e donne, e nascono e muoiono bambini…».
Altre pennellate degne dei migliori autori che hanno rappresentato Cagliari nelle sue povertà. Penso adesso a J.E. Crawford Flitch ed al suo Sardegna 1911. Sensazioni di un viaggio, ripubblicato nel 1998, a cura di Lucio Artizzu, dalle Edizioni della Torre.
Crivelli 1983, ripensando al primo giorno, al primo anno cagliaritano
Nell’inserto de L’Unione Sarda andato sotto il titolo generale “Cagliari. Gli anni della resurrezione”, il 19 maggio 1983, così scrive Crivelli firmando il suo “Dai cumuli di macerie nasce una città nuova”: «Nel 1954, il primo anno della mia residenza a Cagliari, la città aveva ancora addosso le piaghe aperte dalle bombe di undici anni prima ma dava l'impressione di essere troppo occupata a costruire il nuovo per avere la voglia e il tempo per curarle e liberarsene. Lasciava che cicatrizzassero da sole, e guardava oltre, verso i nuovi quartieri che sorgevano a ritmi febbrili, tutta tesa ad espandersi più che a risanarsi. In pieno centro cumuli di macerie restavano fra le nuove costruzioni come se si esitasse a liberarsi di memorie tanto dolorose; percorrendo di sera, con l'illuminazione ancora scarsa, certe zone fra via Garibaldi e via Sonnino sembrava di essere in un luogo remoto, abbandonato, destinato a restare così per sempre. In realtà era solo un tempo d'attesa: l'edilizia che per i primi anni aveva trovato più facile e più economico espandersi verso la periferia, presto sarebbe ripiegata sull'interno e, sempre frettolosamente, avrebbe rimosso le macerie unendo in un unico, e non sempre felice impasto, ciò che rimaneva della vecchia Cagliari con i contrassegni di una città pretenziosamente moderna.
«Cagliari, insomma, risorgeva ma sotto le spinte che chiaramente mancavano di coordinazione e di piani razionali: la gente aveva bisogno di case e l'iniziativa privata copriva il vuoto lasciato dalla burocrazia troppo lenta. Nel 1954 e ancora dopo l'immagine prevalente della città era quella di un grande, disordinato, disseminato cantiere. Dal bozzolo pieno di crepe usciva un nuovo agglomerato cittadino: capi-mastri improvvisatisi imprenditori allargavano senza soste il perimetro urbano senza curarsi troppo della mancanza dei servizi. Così nelle nuove abitazioni continuava a scarseggiare l'acqua, la condotta fognaria diventava sempre più insufficiente, gran parte della città nuova mancava di illuminazione pubblica. Il progetto per la diga del Flumendosa era ancora alla fase iniziale: presto Cagliari avrebbe riscoperto il problema della sete. Ma si andava avanti: l'atmosfera del cantiere contagiava tutti, e in definitiva le note positive superavano quelle negative se Guido Piovene, giungendo in città nel 1956 per scrivere il capitolo sardo del suo Viaggio in Italia, dedicava una pagina, piena di ammirativa sorpresa per la vitalità dei suoi abitanti, a questa Cagliari miracolosamente risorta dalle distruzioni belliche».
Crivelli: «I mesi prima della tragedia»
All'alba del primo settembre 1939 le divisioni corazzate naziste invasero la Polonia e dettero inizio a quella catastrofica vicenda mondiale che nel corso di sei anni avrebbe provocato milioni di vittime, immani distruzioni, il sacrificio di un'intera generazione. A cinquant'anni di distanza i superstiti, seguendo le tante rievocazioni che giornali e televisioni ripropongono in questi giorni, ritrovano nella memoria le confuse sensazioni che li accompagnarono in quei lontani momenti, quando ragazzi o giovanissimi si sentirono d'improvviso calati in una tragedia che avrebbe mutato il corso della loro vita.
Il sentimento che prevale nei miei personali ricordi è quello di un malinconico addio ad un'età e ad una stagione che mi sono state sottratte; la cocente disillusione di un diciottenne che ha avuto una sola estate spensierata e libera, il rimpianto di un'adolescenza interrotta brutalmente da un uragano che ha disperso in un attimo speranze, attese e sogni non più realizzati.
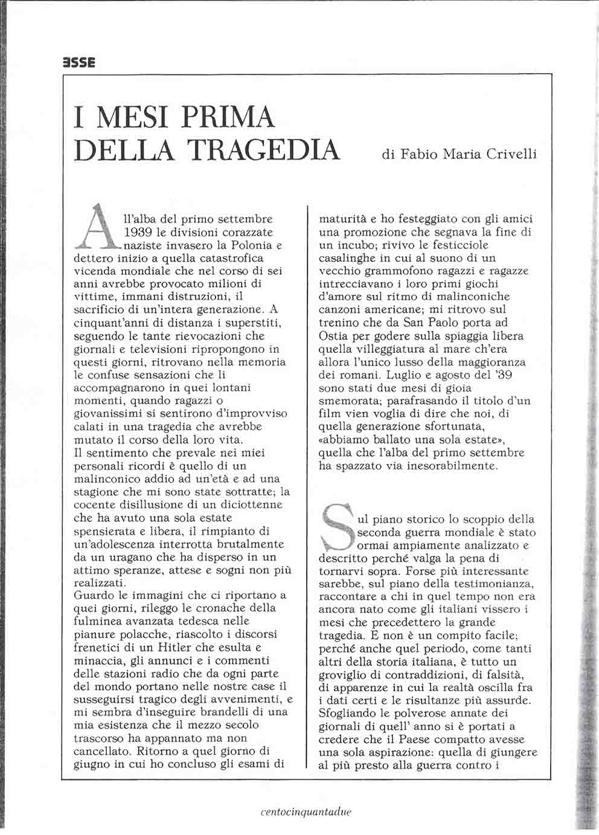
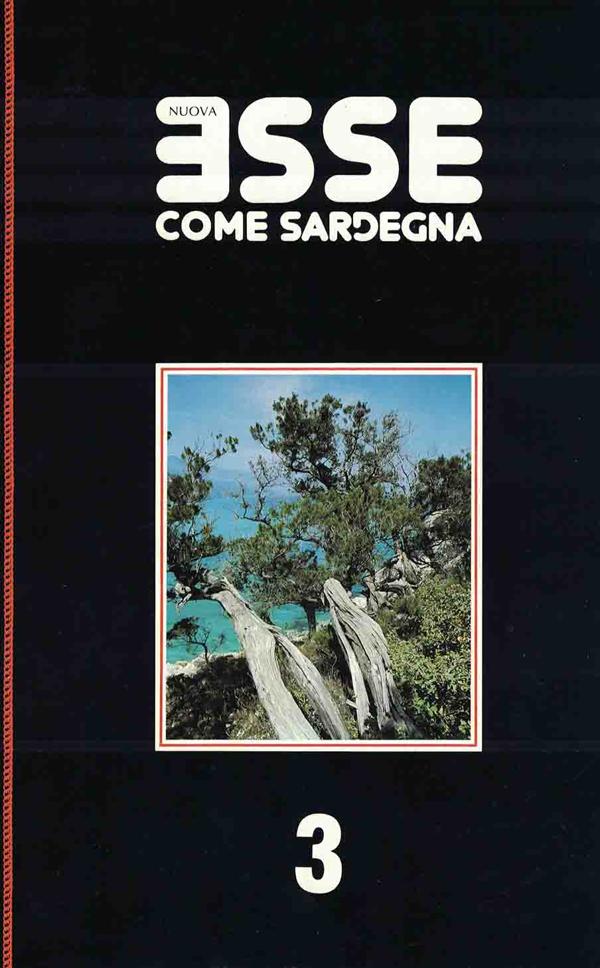
Guardo le immagini che ci riportano a quei giorni, rileggo le cronache della fulminea avanzata tedesca nelle pianure polacche, riascolto i discorsi frenetici di un Hitler che esulta e minaccia, gli annunci e i commenti delle stazioni radio che da ogni parte del mondo portano nelle nostre case il susseguirsi tragico degli avvenimenti, e mi sembra d'inseguire brandelli di una mia esistenza che il mezzo secolo trascorso ha appannato ma non cancellato. Ritorno a quel giorno di giugno in cui ho concluso gli esami di maturità e ho festeggiato con gli amici una promozione che segnava la fine di un incubo; rivivo le festicciole casalinghe in cui al suono di un vecchio grammofono ragazzi e ragazze intrecciavano i loro primi giochi d'amore sul ritmo di malinconiche canzoni americane; mi ritrovo sul trenino che da San Paolo porta ad Ostia per godere sulla spiaggia libera quella villeggiatura al mare ch'era allora l'unico lusso della maggioranza dei romani. Luglio e agosto del '39 sono stati due mesi di gioia smemorata; parafrasando il titolo d'un film vien voglia di dire che noi, di quella generazione sfortunata, «abbiamo ballato una sola estate», quella che l'alba del primo settembre ha spazzato via inesorabilmente.
Sul piano storico lo scoppio della seconda guerra mondiale è stato ormai ampiamente analizzato e descritto perché valga la pena di tornarvi sopra. Forse più interessante sarebbe, sul piano della testimonianza, raccontare a chi in quel tempo non era ancora nato come gli italiani vissero i mesi che precedettero la grande tragedia. E non è un compito facile; perché anche quel periodo, come tanti altri della storia italiana, è tutto un groviglio di contraddizioni, di falsità, di apparenze in cui la realtà oscilla fra i dati certi e le risultanze più assurde. Sfogliando le polverose annate dei giornali di quell' anno si è portati a credere che il Paese compatto avesse una sola aspirazione: quella di giungere al più presto alla guerra contro i francesi e gli inglesi, a fianco degli alleati tedeschi, per consolidare l'Impero conquistato tre anni prima e completarlo con l'acquisizione di Nizza, della Savoia, della Corsica, tutte terre «italianissime» e in attesa di essere «liberate». Le fotografie che accompagnano quelle cronache mostrano folle di studenti in divisa del Guf che manifestano nelle piazze con grandi cartelli rivendicativi; gli articoli di fondo dei vari quotidiani riecheggiano in toni bellicosi queste aspirazioni ed esaltano lo spirito marziale del nostro popolo, la potenza dei nostri armamenti, la fede incrollabile nella saggezza del Duce che pochi mesi prima, a Monaco, ha imposto il suo volere alle altre potenze evitando, prematuramente, quello scoppio del conflitto che però, si lascia intendere, è stato solo rinviato. A corroborare questa sensazione di una pace provvisoria provvedono tutta una serie di fatti: grandi manovre militari si susseguono, più volte si fanno prove d'oscuramento delle città in previsione dei bombardamenti aerei, alcune classi vengono richiamate alle armi per prolungati periodi d'addestramento. Si stanno già stampando le tessere per il razionamento di alcuni generi alimentari e i giornali quotidianamente richiamano i lettori all'austerità, li ammoniscono a non comperare prodotti stranieri, suggeriscono il modo di surrogare con articoli autarchici quelle merci che fino ad allora abbiamo importato dall'estero. Ma chi ha vissuto quei tempi sa che questa, come balza dai giornali, è solo un'immagine di facciata, una retorica costellata di menzogne, una realtà in cui pochissimi credono. I primi a non crederci sono quelli che scrivono sui giornali, strettamente controllati dal Minculpop, i gerarchi che occupano le più alte cariche, i collaboratori più vicini a Mussolini.
Le famiglie italiane quando si ritrovano la sera a cena, per un magro pasto, parlano di ben altri argomenti, non certo di Nizza e della Savoia, e se il discorso scivola sulla guerra è solo per deprecarla, per esprimere la speranza che questa follia sia evitata, che quel matto di Hitler sia finalmente costretto a fermarsi nelle sue continue farneticazioni e proditorie conquiste. Quando sui giornali e alla radio si comincia a parlare con insistenza di Danzica e della pretesa tedesca per la conquista di questa città, gran parte degli italiani esprime una convinzione che in Francia viene più liberamente gridata e secondo la quale «nessuno è disposto a morire per Danzica».
Naturalmente anche allora esistevano conflitti generazionali, che però variavano da famiglia a famiglia, da ceto a ceto. «I vecchi» che hanno vissuto gli orrori della prima guerra mondiale guardano con giustificata preoccupazione a questa smania bellicistica che sembra pervadere il Paese; i giovani, nati e cresciuti nel fascismo, sono più permeabili al fascino dell'avventura, allo spirito della conquista, molti sono davvero convinti che l'Italia deve muoversi «nel senso della storia». Tuttavia le distinzioni sono numerose, talvolta radicali. Lo staracismo che impregna il fascismo degli ultimi anni ha già cominciato ad intaccare l'entusiasmo della gioventù più sensibile; i divieti spesso assurdi, la retorica spropositata, il malcostume dei gerarchi che malgrado la censura è un fatto sempre più noto, hanno già seminato i primi germi del dubbio in una generazione che sulla propria pelle, nelle più tragiche esperienze, dovrà fra poco scoprire il vero volto di un regime che per tanti anni, fin dalla più tenera età, l'ha allevata col motto «Credere, obbedire, combattere».
Questi giovani che nell'estate del 1939 scoprono nelle esercitazioni della premilitare del sabato i primi segni di un'assoluta impreparazione italiana per una guerra moderna, che sfidando gli ordini di Starace leggono i libri dei grandi scrittori americani, inglesi, francesi, che alle banali canzonette dell'Eiar preferiscono «Polvere di stelle», e «Smoke gets in your eyes», nei giorni d'autunno e d'inverno che stanno per sopraggiungere si aggrapperanno alla speranza che la «non belligeranza» decisa a sorpresa da Mussolini sia un reale segno dl ripensamento e di svolta, e che se si dovrà combattere lo si farà, come nel 1915, non con i tedeschi ma contro. Purtroppo questa speranza sarà solo la loro ultima disperata illusione, che il dieci giugno del 1940 Mussolini distruggerà, segnando tragicamente la loro sorte e la propria.
Essendomi trasferito in Sardegna nel 1954, nove anni dopo il tragico epilogo della guerra, non ho, naturalmente, ricordi diretti di come sia stata vissuta qui nell'isola quella che per milioni di uomini e di donne fu l'ultima estate di pace. Ma mi è abbastanza facile rievocarla attraverso i racconti che me ne hanno fatto Franco Porru, Antonio Ballero, Francesco Cocco Ortu, Francesco Alziator, in quelle interminabili conversazioni notturne che hanno accompagnato i miei primi anni di direzione de «L'Unione Sarda», in quella stanza sul Terrapieno che spesso ci vedeva ancora riuniti al sorgere dei sole.
Nel luglio e nell'agosto del 1939 Cagliari era una città straordinariamente animata: una grossa fetta della flotta italiana era ancorata nel porto e la sera via Roma, il Corso, Piazza Costituzione, i Bastioni erano invasi dalle bianche divise di ufficiali e marinai che sciamavano fra i caffè pieni di gente, si fermavano ad ascoltare le orchestrine che suonavano all'aperto o sotto i portici, seguivano e corteggiavano le belle ragazze nella passeggiata vespertina, si addentravano nelle straduzze della Marina in cerca delle case dalle persiane chiuse. Di giorno stormi di aerei sorvolavano a bassa quota la città per decollare o atterrare nell'idroscalo di Elmas; dai piroscafi scendevano battaglioni di fanti che attraversavano le strade preceduti dalle bande per poi essere avviati verso i centri dell'interno dove si allargavano i presidi militari destinati a difendere l'isola in caso di attacco nemico. Altri piroscafi raccoglievano invece sempre più folti gruppi di reclute, soldati di classi richiamate, destinati a lontani reggimenti in continente.
Tutto questo movimento militaresco, i proclami e gli annunci trasmessi in continuazione dalle radio, i cortei fascisti che si intensificavano, facevano di quella estate una stagione gravida di attesa e di ansie. E tuttavia la gente sembrava non volersi rassegnare al peggio che s'intravedeva, cercava di non mutare il suo stile abituale di vita, voleva godersi quei mesi che sono sempre stati i più belli in questa città prediletta dal sole. Così al Poetto la vita balneare riempiva Io stabilimento del Lido e le spiagge libere, si facevano ancora i bagni a Giorgino, la sera il Politeama Margherita era gremito di spettatori che gustavano le ultime novità di prosa presentate dalle compagnie di giro, anche i cinema erano affollatissimi. Nelle case in Castello i ragazzi ballavano anche loro al suono dei grammofoni, mentre i genitori andavano al Lido dove compagnie di avanspettacolo o di operette diventavano occasioni d'incontri mondani.
Dopo il primo settembre si vissero momenti di estrema trepidazione; la radio descriveva in toni trionfali la fulminea avanzata delle truppe naziste in Polonia, poi annunciò la dichiarazione di guerra dell'Inghilterra e della Francia; qualche sparuto gruppo di studenti in divisa del Guf si raccolse in Piazza Yenne per inneggiare al Duce e reclamare la partecipazione italiana e la conquista della Corsica e della Tunisia. Gruppi di dimostranti in camicia nera attraversarono la città e insultarono gli abituali frequentatori del Caffè Genovese che al loro passaggio continuarono tranquillamente a sorbirsi la loro granita facendo finta di non vederli. Due giorni dopo venne l'annuncio della «non belligeranza», la formula inventata dal Duce per camuffare una scelta della neutralità che gli era stata imposta dall'assoluta impreparazione delle nostre forze armate e che lo rendeva furioso.
Ma quella scelta fu invece accolta dalla stragrande maggioranza degli italiani con sincero entusiasmo. A Cagliari la gente sentì allargarsi il cuore vedendo ripartire gran parte delle navi da guerra che per due mesi erano rimaste alla fonda in perenne stato di allarme; cessarono anche i continui sorvoli di aerei e l'arrivo delle cartoline di richiamo alle armi. La lunga estate cagliaritana invitava ad un prolungamento dei bagni e delle passeggiate serali; furono in molti ad illudersi che stavolta Mussolini «avesse fatto il furbo» e che l'Italia restasse in pace a guardare la guerra degli altri. Fu un sogno di pochi mesi; dopo un tranquillo inverno, la primavera portò i drammatici segnali della realtà; e la città, e tutta l'isola, si trovarono in prima linea nella tragedia che si abbatteva sul Paese. Cagliari pagò duramente l'illusione di quell'ultima estate felice: due anni dopo era ridotta ad un cimitero di rovine, abbandonata dalla gran parte dei suoi abitanti, votata ad una sorte che sembrava irreparabile. Quando, nel 1954, io l'ho vista per la prima volta era già in piena ricostruzione; solo qua e là restavano i segni delle ferite inferte dai bombardamenti. Ma bastavano per farmi capire quanto feroce era stata la distruzione e quanto tenace e dura la volontà e la fatica di chi aveva lavorato per farla risorgere.
Crivelli: «Due “cronisti” un po’ speciali»
Finita la baraonda dei mondiali di calcio che ha coinvolto in discreta misura anche Cagliari la città ha ripreso il ritmo un po' sonnolento delle sue estati fatte di fughe, disservizi, nevrotiche attese del refrigerio notturno. La capitale della Sardegna ha tutti i requisiti per considerarsi città balneare, aperta ai desideri dei turisti che in numero crescente cercano nei luoghi più lontani una meta per le loro ferie; e nello stesso tempo sembra votata al destino di respingere questa vocazione di luogo ideale per le vacanze, finendo sempre più col diventare un agglomerato urbano da cui al primo insorgere del solleone tutti desiderano fuggire, magari ammucchiandosi nei centri che a pochi chilometri diventano fette di una metropoli in temporaneo trasferimento.
Questo di Cagliari città turistica mancata è un discorso che meriterebbe approfondimenti e ricerche di responsabilità che non sono poche e non sono di pochi. Ma girando per la città nei giorni della baraonda dei mondiali, rinserrato dentro il caos di un traffico impazzito, scoprendo ad ogni passo le mille magagne che rappezzi improvvisati, stravaganti toilettes d'occasione, abbellimenti affrettati e pacchiani tentavano di nascondere, m'è venuto fatto di paragonare questa Cagliari '90 con quella che più di trent'anni fa incontrai per la prima volta e di cui pian piano m'innamorai, scoprendola nelle sue intime e nascoste bellezze; e ho sentito con un moto d'improvvisa nostalgia che quella città, certo più piccola e più provinciale, sta giorno per giorno scomparendo, entra nel novero delle cose di cui noi vecchi amiamo parlare sospirando, appartengono insomma al bel tempo che fu.
Attraversando via Roma, il Largo, piazza Martiri, piazza del Carmine, percorrendo a fatica le viuzze della Marina fra la ressa dei turisti venuti per le partite di calcio, assistendo alle sfilate tumultuose degli hooligans nelle loro oscene divise, assordato dai clacson delle auto, dalle sirene delle macchine della polizia, dagli urli di comitive di varia estrazione, ho per un momento pensato che cosa avrebbero detto e scritto di questa Cagliari improvvisamente impazzita e irriconoscibile quei miei due amici che furono Francesco Alziator e Antonio Ballero, i due grandi cronisti che con i loro scritti, i loro discorsi, i loro ricordi mi hanno svelato una città da amare e che solo rileggendo le loro pagine mi riesce oggi possibile ritrovare.
Definendo Alziator e Ballero «cronisti» invece che scrittori non intendo di certo sminuire il valore delle loro prose; al contrario ritengo di interpretare esattamente quello che essi con orgoglio sentivano e volevano essere. La loro frequentazione, quotidiana per moltissimi anni con Antonio Ballero, più saltuaria e più breve con Francesco Alziator, è uno dei ricordi più gratificanti del lungo periodo trascorso a «L'Unione» come direttore. Ballero fu il primo dei redattori del giornale che mi capitò d'incontrare entrando nei provvisori e dissestati locali che nel 1954 costituivano, in Terrapieno, la sede del quotidiano; un incontro fatto di poche parole, forse per l'imbarazzo che un trentenne piovuto all'improvviso da Roma provava di fronte ad un uomo più maturò in cui mi sembrava di cogliere una non tanto sottintesa vena di ironia e di scetticismo. Confesso che nei primi tempi quel cronista più anziano di me di una decina d'anni, magro, fumatore accanito, portato a lunghi silenzi e a improvvise battute sarcastiche, suscitava in me più perplessità che simpatia. Delle sue bizzarrie spinte talvolta alla stravaganza mi aveva parlato Franco Porru, il mio prezioso e indimenticabile braccio destro; ma v'erano momenti in cui la sua riluttanza non nascosta a rispettare gli orari della tipografia, la sua tendenza ad accogliere con aria critica I miei sforzi per dare un certo ordine e una necessaria programmazione alla fattura quotidiana del giornale, mi irritavano anche se facevo finta di niente. Antonio Ballero, come scopersi piano piano, era un uomo incapace di sostare a lungo dietro un tavolo; il suo istinto lo portava a girare per la città, ad osservare la gente, a parlare con tutti. Il suo luogo di lavoro preferito era il tavolino di un caffè, meglio se all'aperto. Là, fra il chiasso degli avventori e dei camerieri, le lunghe gambe intrecciate fino ad assomigliare ad una grù, riempiva fogli su fogli adoperando una vecchia stilografica; rileggeva con calma quello che aveva scritto, spesso ne gettava via gran parte per riscrivere quello che non gli piaceva, e poi, a piedi, s'avviava su per il Terrapieno verso quella che egli considerava una sorta di prigione in cui doveva passare qualche ora per adempiere ad altri e assai più noiosi doveri.
I fogli che Ballero con la sua disordinata grafia riempiva al tavolino di un caffè costituiscono quelle prose che sotto il titolo di «Terrapieno» sono uscite per moltissimi anni nella «Cronaca di Cagliari» de «L'Unione».

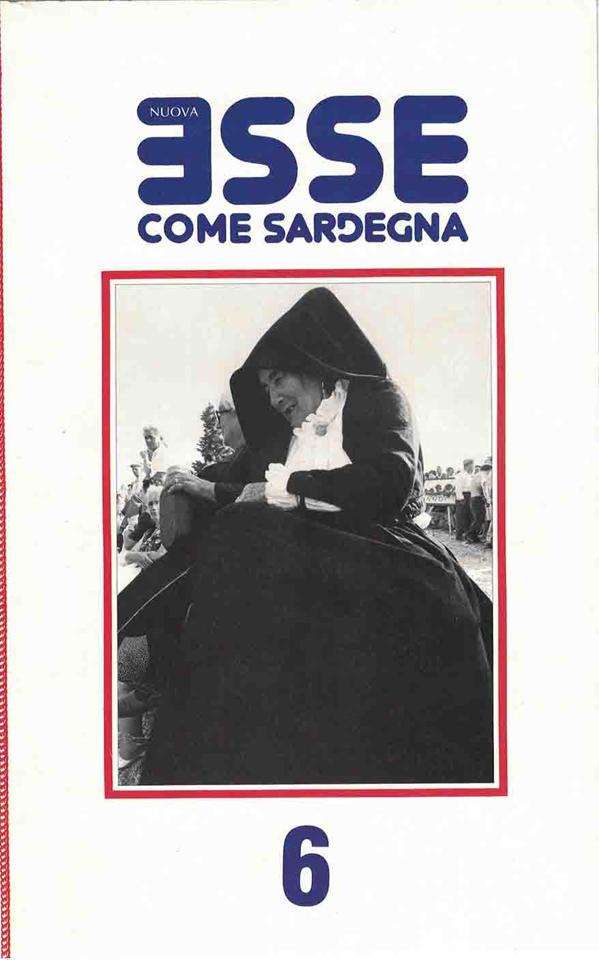
Chi vuole oggi ritrovare un ritratto preciso, una proiezione puntuale e assieme un po' magica di quella che era allora, fra l'immediato dopoguerra e la fine degli anni Sessanta, la nostra città dovrebbe ricercare quei brani nelle polverose collezioni del giornale, senza accontentarsi della ristretta selezione che è stata raccolta in un libro. In quelle brevi prose c'è tutta una città che risorge dalle sue distruzioni e si apre a nuove speranze in un tumulto di polemiche, fra errori e scelte obbligate, fra aspirazioni deluse e una crescita non immaginabile, portatrice di vantaggi e insieme di guasti. C'è Cagliari con le sue bellezze segrete che nessun forestiero frettoloso potrà mai scoprire, Cagliari con le sue stagioni oscillanti fra il maestrale purificatore e lo scirocco della sonnolenza, Cagliari attaccata alle sue tradizioni ma anche attenta al nuovo che viene dal porto; in quelle prose passano personaggi famosi o famigerati, ricchi e poveri, nobili di Castello e borghesi che creano interi quartieri nuovi trasformando in tentazione di metropoli una vocazione legata all'ambito più colorito e vivace del centro di sapore provinciale.
Ballero raccoglieva i suoi spunti girando a piedi per la città con la vocazione del cronista d'altri tempi; ma quando si trasferiva al consiglio comunale per seguire i lavori dell'assemblea riusciva a trasmettere con estrema chiarezza e rigorosa obiettività ai lettori il senso dei dibattiti e dei problemi in discussione. Sempre con un sottofondo in cui il suo sviscerato amore per la città natale prevaleva su tutto.
Naturalmente in pochi mesi i rapporti inizialmente difficili fra Antonio Ballero e me mutarono profondamente; divennero da prima di reciproca stima, poi di sincera amicizia. E fu allora che spesso gli tenni compagnia nei caffè che prediligeva, che cominciai a girare con lui per quelle zone di Cagliari che egli riteneva ancora note solo a lui, e che erano occasioni per rievocare antiche storie, vicende drammatiche o burlesche, una specie di ricerca di reperti su una città che stava sparendo, come egli sentiva, con non nascosto rimpianto.
Quando, nel 1970, Antonio Ballero dovette per ragioni familiari lasciare il giornale e Cagliari, per trasferirsi a Venezia, sentii che lasciava un gran vuoto nel giornale. Ma da Venezia cominciò presto ad inviarmi degli articoli; e non erano pezzi dedicati alla città pur bellissima in cui ora viveva, ma ancora brani su Cagliari, ricordi di tempi passati, descrizioni di luoghi e persone conosciute lungo l'arco di mezzo secolo. C'era, in quegli articoli, un così acuto sentimento di nostalgia per la sua Cagliari, il suo sole, la sua gente, che non mi era difficile, leggendoli, immaginare Antonio mentre li scriveva, seduto ad un tavolino di un caffè veneziano, probabilmente intristito dalla nebbia e dal freddo di una città per tanti versi magica ma così diversa e lontana da quella in cui era nato e vissuto per la gran parte della sua vita.
Francesco Alziator, che pur ho definito un «grande cronista» di Cagliari, in realtà non era di professione giornalista, ma docente universitario. Tuttavia quando gli dicevo che io lo consideravo un ottimo giornalista non solo non si offendeva ma rispondeva felice, e sospirando, che quella sarebbe stata in realtà la sua vera vocazione. Anche Alziator era per molti versi un personaggio straordinario; anche lui, come Ballero, amava girare per Cagliari a piedi, scoprendone pezzetto per pezzetto le bellezze meno apparenti, i ricordi, i sapori, gli umori segreti. I suoi articoli pubblicati su «L'Unione» e poi raccolti in volume costituiscono nell'insieme un magico affresco in cui la nostra città rivive lungo l'arco di un secolo con le sue vicende più drammatiche, le sue bellezze sfiorite o quelle che nessuno potrà mai intaccare, i suoi sogni delusi e le sue speranze dure a morire.
Piccola chiosa
Mi riferisco ad Antonio Ballero Pes, al capocronista di tanti anni a L’Unione Sarda, al redattore reggente fra la direzione Spetia e la direzione Crivelli, nel dicembre 1953.
I motivi cagliaritani saranno stati senz’altro i prevalenti… e ci mancherebbe! fra il giovane direttore e il più anziano cronista, cronista decano (sedici anni li separavano, ma nel 1953-54 Ballero non era certamente, per l’anagrafe anziano. Anziano soltanto per il giornale nel quale lavorava ormai da quasi trent’anni). Dovevano esserci anche motivi romani. Fatto romano Crivelli, che nella capitale aveva seguito la sua famiglia quando non aveva che otto anni, in passaggio romano Ballero negli anni in cui Crivelli nasceva a Capodistria. Nipote di viceprefetto, egli era andato per far qualche studio universitario. Ma non studiò granché, per sua stessa ammissione. Più interessato alle perlustrazioni della città, fra le suggestioni di Campo de’ Fiori e del Pantheon, di piazza Navona e piazza Barbarini, Montecitorio e, soprattutto, via Tomacelli (per corteggiare, con educazione e discrezione, una piccola stiratrice dai «corti capelli a riccioli spioventi sulla fronte e sulle tempie»). Ma non solo alle perlustrazioni, anche alle rappresentazioni teatrali, come quella volta al Quirino – erano i primi mesi del 1924 e la compagnia di Antonio Gandusio aveva portato in scena “Le anime gemelle”. La volta che in qualche loggia del teatro si vide anche Mussolini già presidente del Consiglio. Vigilia di elezioni e vigilia di delitto Matteotti. Restò a Roma, Antonio Ballero, ancora qualche mese e ne registrò le tensioni politiche. Il fascismo autoritario non era ancora divenuto regime. All’ingresso della Camera fermò una volta l’on. Mario Berlinguer «sperando di ottenere un biglietto d’accesso ad una delle tribune»: desiderava ascoltare l’annunciato intervento del deputato Giovanni Amendola. Talvolta gli accadeva di sostare «in via della Mercede, dinanzi alla tipografia de Il Mondo in attesa dell’uscita del quotidiano che era tra i più accaniti e conduceva una battaglia forte e coraggiosa».
Fra i ricordi di quella stagione – evocata da Ballero nell’articolo “Vita di studente”, uscito nella meravigliosa serie “Memorie di tempi lontani” su L’Unione Sarda dell’11 febbraio 1973 e riportato anch’esso in Le case di fango, cit. – entravano anche le insolenze del Farinacci nei pressi della «fitta siepe dei tavolini del Biffi», alla galleria Colonna, una delle tappe preferite dal giovanissimo studente domiciliato temporaneamente in via di Ripetta, vicino a piazza del Popolo ed al collegio gesuitico del Nazareno, e vangante per caffè, come l’Aragno «che invitava per la tranquilla lettura del giornale» e «consentiva i primi fantasiosi scarabocchi» e, appunto, il Biffi. «D’improvviso un gruppetto di squadristi circondò il tavolo in cui sedevo con alcuni amici – scrive Ballero – e, dopo aver fracassato con i manganelli bottiglie e bicchieri, inveì asserendo che si parlava male del fascismo»: «gli amici ed io fummo costretti a seguire gli agenti sino al commissariato, a subire un lungo interrogatorio, a sottoscrivere un verbale, prima di venir rilasciati già a notte inoltrata». Un episodio che, per qualche verso, s’accoppiava a quello riguardante il cagliaritano caffè Genovese quindici anni dopo, richiamato da Crivelli nel suo articolo su Esse come Sardegna…
Devi accedere per poter commentare.


