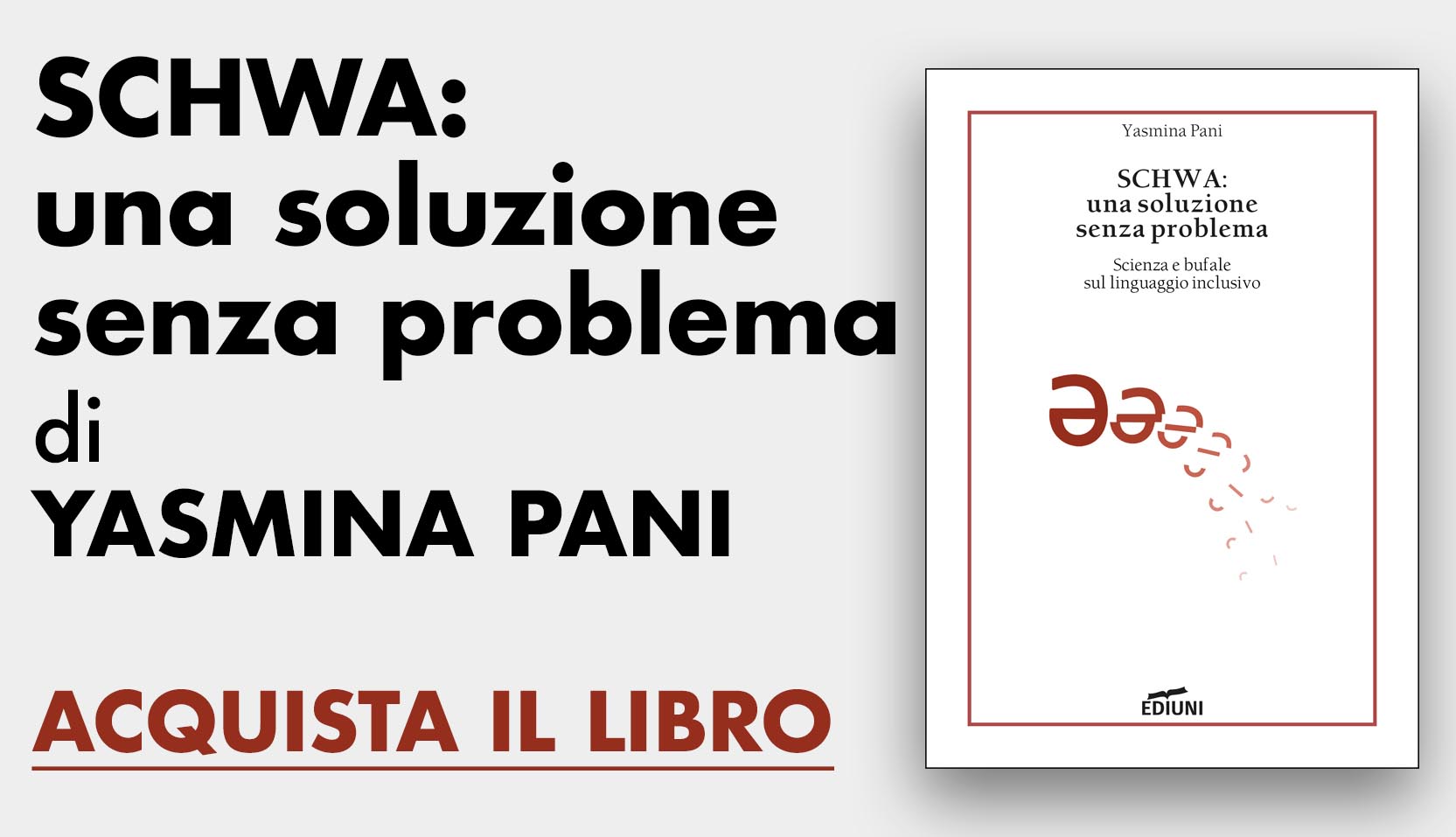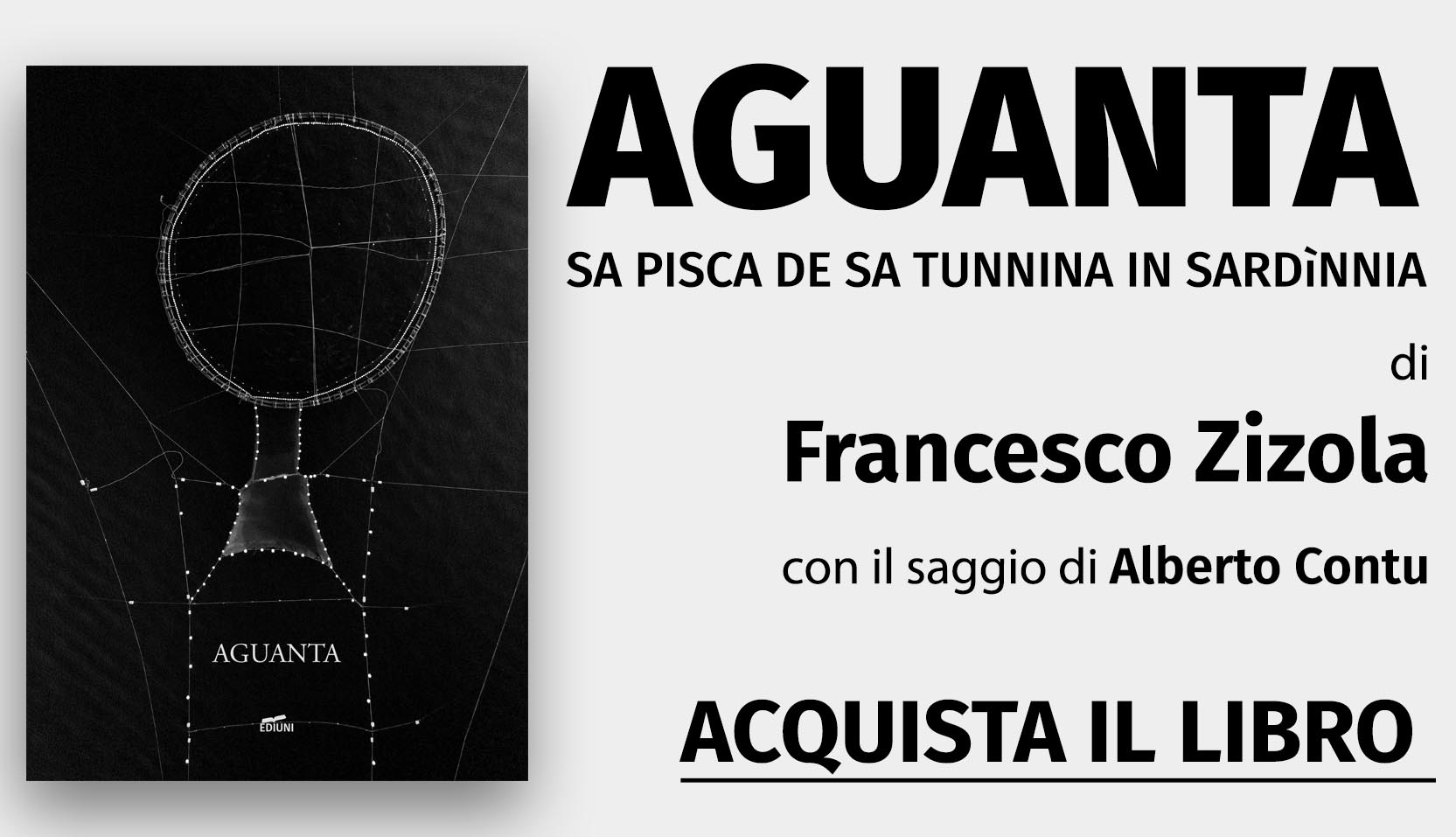Mille anni di Tribunale ecclesiastico. E dal 1632 a Ozieri per “promessa di matrimonio non rispettata” e altro
di Gianfranco Murtas
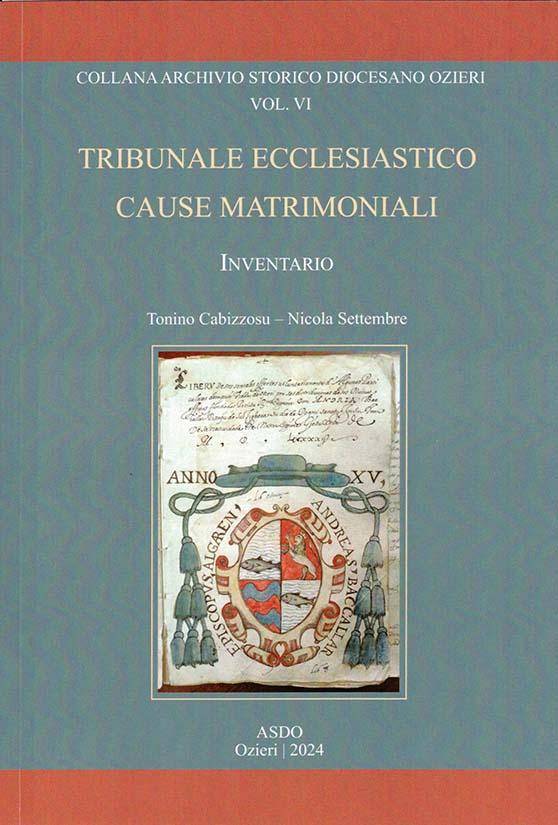
Sembrerebbe, a prima vista, di interesse soltanto degli specialisti il recentissimo volume che Tonino Cabizzosu e Nicola Settembre hanno partorito dagli affondi d’archivio da essi, e da altri felici collaboratori, effettuati per dar conto al mondo degli studi ma poi anche a chi altri ami comunque la storia, ed ovviamente e in primo luogo alla Chiesa locale e al suo diritto/dovere di conoscere il proprio passato, delle cause matrimoniali trattate dal Tribunale ecclesiastico della diocesi di Ozieri. O per meglio dire, di questa e, prima della sua rinascita come Chiesa di Bisarcio (passata nel 1915 con il titolo del capoluogo logudorese), dal Tribunale della diocesi di Alghero che sul territorio di Monte Acuto (promosso capofila anche di Logudoro e Goceano) aveva una postazione vicaria. Ché, come forse si sa, la bella diocesi consacrata al martire Antioco (patrono anche della Sardegna tutta) ed attualmente affidata all’ottimo don Corrado Melis vanta, nella sua duplice espressione di Bisarcio e di Castro, una bella e antica storia, con radici medievali/giudicali (XI secolo) ed un patimento di sospensione (diciamo pure soppressione, per volontà di Giulio II) di tre secoli pieni, centomila giorni, prima della resurrezione decretata dal romagnolo Pio VII Chiaramonti nel 1803 con la famosa bolla Divina disponente.
Allora – dico degli effetti della decisione del guerresco papa della Rovere – la cura animarum (con tutto il resto, che era il più) venne affidata al vescovo di Ottana che intanto la sua sede l’aveva portata ad Alghero. Dalla città catalana si cercò quindi di amministrare la giurisdizione canonica, già pacificamente riconosciuta dai sovrani aragonesi (soddisfatti dell’investitura ex donazione di Costantino, vera o presunta che fosse delle potestà pontificie) e, dopo l’unità spagnola, da quelli di Madrid, ma anche dai Savoia arrivati nell’Isola nel 1720, da costa a (quasi) costa, nella Sardegna settentrionale. Confinando quel vasto territorio con le altre giurisdizioni sassarese e gallurese e, a sud, barbaricina (peraltro questa stessa assorbita, per lungo tempo e con buona compagnia, dalla bulimica mitria cagliaritana). Insomma, in altre parole, la Chiesa sarda dei secoli lontani fu una specie di elastico teso o allentato a seconda delle necessità storiche impostesi tanto alla Chiesa stessa quanto al potere politico ora indigeno ora iberico o italiano nella fuga diacronica ben conosciuta…
L’autorità vescovile era piuttosto piena: nelle sue attribuzioni s’era fatto rientrare tutto e la religione divenuta “tutto” sul piano amministrativo-giuridico-giudiziario finì allora, infatti, per confinare ai margini la fede, e di questa lo spazio e le ragioni.
La voglio dire meglio: certo è che quando anche l’autorità politica ritenne di intervenire per attenuare il privilegio del foro ecclesiastico allargatosi e ingessatosi su molte materie che si sarebbero dette – a pensarla come la pensiamo nel XXI secolo – di stretta e necessaria competenza dei Tribunali civili e penali dello Stato, la potestà di vescovi e strutture giudiziarie ecclesiastiche era piena e quasi assoluta, sussumente quella certa dimensione laica astratta in teoria ed inesistente in realtà. La delega o l’esproprio, da parte della Chiesa temporalista, di quanto sarebbe stato di competenza di Cesare – come il Gesù di Nazaret che abbiamo frequentato aveva suggerito dover essere, insegnandolo a farisei ed erodiani – segnò marcatamente la vita sociale del mondo latino e dunque anche della nostra Sardegna per lunghi secoli.
Si tratta dunque, per comprendere e… gustare – per i sapori della storia s’intende! – le pagine di questo Tribunale ecclesiastico Cause matrimoniali Inventario ora dato alle stampe dall’Archivio storico diocesano di Ozieri e curato, come detto, da Cabizzosu e Settembre, di entrare nella logica del millennio (e di più e di meno) che anticipa le salutari leggi eversive – chiamale liberali – del Regno di Sardegna e poi d’Italia. E di non scandalizzarci – perché alla storia non siamo tenuti a dare la pagella – per il pratico rovesciamento di quei valori che il Vangelo s’era illuso di proiettare nel tempo sociale del lungo periodo ricollegandoli alla capacità di testimonianza dei suoi. E d’altra parte, se ancora quando erano vivi e attivi i nostri bis-trisnonni Pio IX Mastai Ferretti, eletto beato della Chiesa universale pochi anni fa, azionava la ghigliottina e sottraeva (rapiva) alla famiglia ebrea un piccolo soltanto perché a questi era stato amministrato il battesimo da una domestica fidata, ben possiamo comprendere, e così pacificarci, quanto la pretesa immacolatezza e infallibilità (nella corrente rubrica della autorità apostolica) di un papato governatore d’altro che del bonum animarum fosse, nella realtà, una costruzione tutta umana, autoreferenziale e fallibile…
Ben a ragione i curatori del nostro volume hanno richiamato insistentemente in bibliografia i lavori dell’algherese professor Antonio Era, importante storico del diritto all’università di Sassari. (Quando morì, nel 1961, era già in corso una raccolta di saggi da pubblicare in suo onore, e poco dopo infatti usciti: fra essi, per connessione tematica, mi parrebbe giusto citare qui almeno quello di Carlo Guido Mor: Vescovadi e Giudicati in Sardegna).
Va detto – e lo richiamano opportunamente, con luminosa apprezzabilissima sintesi, i due curatori nella nota introduttiva che manca ancora, allo stato, una storia compiuta dell’origine e funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Utili tasselli di quella storia ancora da scrivere sarebbero, comunque, quelli forniti fin dal VI secolo da papa Gregorio Magno – che con la Sardegna ebbe a che fare (si pensi alla questione di Ospitone e dell’attesa sua conversione al cristianesimo in Barbagia) – da cui parrebbe già affermato un privilegio del foro ecclesiastico sui chierici s’intende anche nelle cause civili.
Superato l’alto medioevo o l’arco dei secoli bui ante-Mille, ed organizzata la potestà politica dei giudici in capo ai quattro regni isolani, parrebbe che da parte di questi fosse rivendicata ed ottenuta una primazia giudiziaria, subita ed (ob torto collo) riconosciuta dalle istituzioni ecclesiastiche, con l’eccezione della materia matrimoniale: un campo in cui la Chiesa tenne sempre fermo il suo piede, incontrando in questo – per la natura sacramentale del vincolo – una larga comprensione dalla/dalle corone giudicali.
Ecco poi la stagione aragonese (magari, ma con qualche riserva, prolungatasi in quella spagnola), di nuova espansione autopromossa della potestà papale e/o episcopale e meglio strutturata con i livelli diocesani per l’istruttoria e il primo grado di giudizio, e metropolitani per l’appello, lasciando alla Santa Sede il rango della… Cassazione. Per qualche tempo, e ferma restando la superiore classe romana, operò nell’Isola (a Cagliari) un Tribunale di Appellazioni, come ad evitare che, appunto gli… appellanti, dovessero passare il Tirreno per difendere le proprie ragioni.
Fu in questo stesso contesto ora spagnolo che s’alzò, codificato senza riscontro col Vangelo, il Tribunale dell’Inquisizione, che a Sassari ebbe la sua sede stabile. Triste periodo.
Molto molto opportunamente, Cabizzosu e Settembre si diffondono a chiarire chi e per che cosa si poteva entrare nell’orbita dei giudici chiamati a pronunciare sentenze di giustizia, accontentando o scontentando, a seconda dei casi, gli innocenti ed i colpevoli: persone giuridiche (come i capitoli canonicali delle cattedrali o i conventi/monasteri di pertinenza delle famiglie religiose, ecc.) e persone fisiche individuabili nei chierici ordinati ma anche quelli soltanto tonsurati nonché i confratelli di questa o quella corporazione o seguaci di questa o quella terza regola…
Circa poi le materie del contendere, qui entravano i patrimoni, quelli mobili od immobili direttamente o indirettamente appartenenti alla Chiesa. Nel gran novero delle competenze giudiziarie ecclesiastiche – lo evidenziano bene i curatori – entravano naturalmente e in primo luogo “le cause di natura spirituale (celibato, matrimonio, sepoltura, ecc.), le cause criminali (ad esempio per eresia, scisma, sacrilegio o altri delitti ecclesiastici, oppure per delitti più secolari quali l’omicidio, il furto, la concussione, la frode e altro) e le cause civili”.
Non tutto fu semplice e non tutto andò sempre liscio. (In questa mia nota non voglio fare facili le cose complesse: intendo soltanto accennare con qualche necessaria approssimazione, al tanto che costituì, per secoli, e quanto più e quanto meno, la prepotenza orgogliosa degli apparati di una Chiesa – gli stessi che sul largo scenario continentale concorrevano per la primazia addirittura con re ed imperatori! – e il loro transeunte, soltanto transeunte ma sempre sofferto, arretramento dalle “profanissime” posizioni conquistate).
Bonaccia, all’inizio soprattutto del loro governo in Sardegna, con i Savoia: paghi i sovrani torinesi di metter mano nelle nomine vescovili che, infatti, furono per larghissima parte concordate o patrocinate. Ed a scorrere la cronotassi episcopale sarda di almeno cento anni – fino appunto alla cessazione delle secolari autonomie (?) ed alla “fusione perfetta” con i territori metropolitani, si vedrebbe pressoché per tutte le diocesi sarde una provvisione che per i due terzi investì presuli piemontesi o liguri!
Poi gli schiaffi delle leggi Siccardi, anticipatrici di quelle cosiddette eversive della metà degli anni ’60, a Regno d’Italia già proclamato. Capitolo tremendo per chi, bypassando il Vangelo dall’interno della Chiesa, aveva perduto il senso della storia, della liberà liberatrice… Capitolo tremendo per chi ancora s’arroccava nella creta molle del temporalismo.
Sì, caduto già prima della unità d’Italia il diritto alle decime – quello difeso a Cagliari da monsignor Emanuele Marongiu Nurra che s’oppose al giusto con scomuniche e interdetti, pagandone lui il fio di rimbalzo con l’esilio per tre lustri nell’isola Tiberina – sarebbe arrivata la drammatica stagione delle leggi eversive che tanto piacquero a un democratico che pure teneva Dio (e la libertà repubblicana) come ispirazione e ragione di vita… dico Giorgio Asproni, già canonico della cattedrale nuorese. Caduto il privilegio del foro, soppressi gli ordini religiosi non finalizzati a un diretto beneficio sociale…
Il focus documentario del volume di Cabizzosu e Settembre guarda naturalmente ad un periodo ben più ridotto. Sono 294 le schede delle cause matrimoniali riesposte nell’inventario che le raggruppa come segue: 21 riferite al periodo precedente la ricostituzione della diocesi di Bisarcio/Ozieri, coinvolgendo i comuni di Buddusò, Tula, Ozieri, Pattada, Oschiri, Nughedu, Illorai, Benetutti, Nule, Monti e Berchidda; 273 al periodo successivo e fino al 1909, considerando però – sempre a voler guardare il calendario storico – che di esse 139 sono inquadrabili ancora in un contesto stretto di Regnum Sardiniae, altre 53 sono comprese nel dodicennio intercorrente fra il rilascio dello statuto albertino e la proclamazione della unità nazionale (un dodicennio che ancor più e meglio si presentava in fibrillazione laicista ed interessato a realizzare la piena separazione dei poteri, con il sogno di Roma capitale), e ulteriori 81 successive all’atto solenne del Parlamento riunito a Palazzo Carignano in Torino il 17 marzo 1861.
Con qualche aggiustamento nei numeri si presenta la tabella che, con generoso rigore, i curatori offrono in fin di libro traendola dalla fatica archivistica del canonico Raimondo Murgia, il quale già nel 1909 aveva proceduto a una classificazione delle unità raccolte nelle stanze vescovili di lato alla cattedrale dell’Immacolata: assommavano esse a 219 (datate fino al 1907), essendone andate perse, nel frattempo, una settantina a causa di una infestazione di termiti negli anni del secondo conflitto mondiale, come segnalato dall’indimenticato monsignor Amadu che, anche lui, aveva messo mano al gran patrimonio nel 1999.
In conclusione va detto, o meglio specificato, che il volume ancora fresco di stampa fotografa soltanto una parte del materiale documentario di stretta pertinenza del Tribunale ecclesiastico: perché accanto ai faldoni delle cause matrimoniali altre due sezioni s’affacciano nel fondo: la serie delle cause civili (309 unità) e quella delle cause criminali (124 unità).
Il lavoro di ricercatori ed archivisti continua. E continua l’attesa di chi ama la materia.
Devi accedere per poter commentare.