Paolo Fadda, patriarca 91. Il biografo di Cagliari e della sua borghesia ai nuovi appuntamenti di studio e narrazione
di Gianfranco Murtas

In diverse occasioni ho dedicato qualche scritto a Paolo Fadda, alla personalità pubblica che per la sua vita onesta e saggia di amministratore – lo ricordo giovane consigliere e capogruppo in Consiglio comunale nei cruciali anni della Rinascita (e nel passaggio di sindacatura da Giuseppe Brotzu a Paolo De Magistris, dopo l’approvazione del primo piano regolatore postbellico di Cagliari) e anche in altre sedi, compresa l’Università e compresi il Banco di Sardegna e l’Ente Minerario Sardo (per non dire poi del management privato) – e la sua cultura operante in molte pieghe associative della nostra città mi ha dato motivo ed onore di esserle amico. Richiamo qui, adesso, soltanto gli ultimi contributi ampiamente biografici usciti rispettivamente nei siti di Fondazione Sardinia e di Giornalia (e cito “Paolo Fadda, l’86° compleanno di un patriarca civico” del 29 marzo 2016 e “Paolo Fadda, patriarca 90. Al compleanno del manager e scrittore cagliaritano ‘amico dei potenti’” del 29 marzo 2020). Ricorderei anche, almeno per omaggio doveroso a Vittorio Scano che l’ha ospitato, il mio articolo apparso sull’Almanacco di Cagliari edizione 2016 dal titolo “Prolifico quanto acuto: Paolo Fadda, lo scrittore cagliaritano autore di vari saggi sull'economia isolana negli ultimi due secoli”. (Neppure dimentico, pur se lontano ormai più d’un decennio, il solido ed originale sodalizio – munito di un giornale e di un sito internet chiamati entrambi Cresia –, che ci unì a sostegno delle ragioni sociali di don Mario Cugusi contro le prepotenze arroganti di un vescovo canonista e padrone).
In quegli ed altri scritti ho cercato di riepilogare al meglio, in ordine tematico e temporale, oltreché vari aspetti biografici, la cospicua bibliografia di questo nostro intellettuale sardo di primissima cifra ed autentico “defensor Karalis”: colui che, azzardo questa impressione personale che so condivisa da molti, dopo Alziator e Romagnino per alcuni versi, dopo Paolo De Magistris per altri – personalità tutte d’oro che abbiamo perduto alla nostra confidenza negli anni passati – costituisce oggi la più sana e robusta memoria civica della capitale isolana. E, allargando lo sguardo in quanto alle presenze storiche dell’imprenditoria e della politica, della regione tutta intera. Non cronista, o cronista soltanto – meglio dire però memorialista (per molti aspetti davvero memorialista, lui discendente dagli Scano così come dagli Zedda-Piras e da quante altre dinastie d’ingegno fabbricatore!) –, ma interprete critico, con la potenza culturale del saggista, di un secolo e più della nostra vita di comunità sarda, vista nelle dinamiche urbane ed in quelle che relazionavano, con diverse e talora opposte valenze, i maggiori poli dei due capi provinciali con i rispettivi territori d’intorno. Si pensi soltanto, centrando ora, in positivo, le personalità da lui briosamente raccontate nella collana Delfino dei “grandi dell’imprenditoria in Sardegna”, a Giovanni Antonio Sanna ed Alberto Castoldi e Montevecchio, a Francesco Zedda-Piras e Tiana, a Franceschino Guiso-Gallisai e Nuoro, ai fratelli Pinna e Thiesi, a Francesco Sisini e Sorso…).
Ora il commendatore compie il suo 91° compleanno e fortunatamente, per lui e per noi, alle buone condizioni di salute continua ad accompagnare la meravigliosa lucidità e fertilità di una mente sempre al galoppo – magnifica la memoria, lineare lo spirito indagatore, continua la produzione di libri ed articoli (è anche uno degli editorialisti de L’Unione Sarda) – sicché è compito gradito dei suoi amici ed estimatori confermargli, nella circostanza, tutto intero il carico di stima, affetto e riconoscenza per quanto egli ha donato e ancora dona senza riserve o parsimonia.
Non mi fa velo, scrivendo di lui, il fatto che io gli voglia bene. Nessuna apologia lo inorgoglirebbe e perciò ne annoto considerando lo scontato chiaroscuro che è proprio della nostra condizione umana, sua e mia e di tutti. Il che non toglie che possa e debba dirsi che chi lo conosce sa come nella sua vita privata e privatissima, oltre che in quella pubblica ben conosciuta, la virtù intesa come materiale adempimento del dovere, stretta aderenza ad una coscienza esigente, secondo l’insegnamento avuto in famiglia e, negli anni dell’adolescenza, presso il collegio cagliaritano dei salesiani, si combini ad una rettitudine intellettuale e a una indipendenza di giudizio che fanno, e l’una e l’altra, la differenza.
Ho evidentemente, per percorsi personali, distanze ideologiche e politiche dalle sue tende preferite – cattolico democratico (o democristiano) lui, azionista repubblicano di matrice liberale e di minoranza io –, ma ciò non di meno ho sempre avvertito, nella quarantennale relazione con Paolo Fadda, un largo idem sentire ideale nella passione democratica e nell’affezione tutta sarda a radici e fronde delle generazioni da cui veniamo e che proiettiamo nel futuro…
Confessione personale. In Paolo Fadda colgo ad un tempo e il galantuomo cui la sorte, ora benigna con lui per l’età e la salute, non ha avareggiato amarezze e dolori di grande momento, felicemente superati con le energie della sua fede profonda e intelligente e di un carattere saldamente equilibrato anch’esso grazie ad insegnamenti ed esempi raccolti nel campo delle sue frequentazioni formative prima e dopo la seconda guerra mondiale, e il produttore originale ed apripista di studi sociali ed economici che resteranno nell’utile di molti.
Gli eroi della modernità: i borghesi
Nelle considerazioni di Paolo Fadda, espresse nei suoi scritti importanti e tutti sostenuti da dati di fatto (tabelle statistiche comprese, magari del Nitti) oltreché impreziositi dall’autorevolezza delle sue fatiche trascorse di manager privato e pubblico, sono centrali le funzioni assunte dalla borghesia isolana di fine Ottocento-primo Novecento. Intendo quella borghesia che egli ha conosciuto dall’interno e tanto più quando, nella sua giovane età ed anche nella prima maturità, ha potuto fare vivida esperienza delle saldature – ecco la parola giusta – fra il genio progettuale dei protagonisti della stagione postrisorgimentale o tardo-ottocentesca e, metti, bacareddiana e quello che ancora nei primi decenni del Novecento, e perfino in tempi di dittatura (ad Arborea per esempio), hanno portato avanti, col “miracolo idroelettrico”, la modernizzazione dell’economia, e dunque, più complessivamente, anche delle condizioni di vita e del costume sociale della Sardegna.
C’è un capitolo, fra i più intensi del suo bellissimo saggio da Karel a Cagliari (Delfino, 2013) in cui egli si diffonde in una illustrazione, che è anche difesa da letture spicce e superficiali, tutte dottrinarie di marca socialista (dei pur generosi socialisti di un tempo! ché oggi i socialisti, come i sardisti, sono diventati… berlusconiani/leghisti, di molto molto molto peggiorando l’insegna), del contributo decisivo offerto dalla borghesia produttiva e professionale all’Isola, e innanzitutto – anche per il trascinamento conseguente che ne sarebbe venuto – alla sua capitale, nello storico passaggio di secolo, nell’era umbertina e successiva.
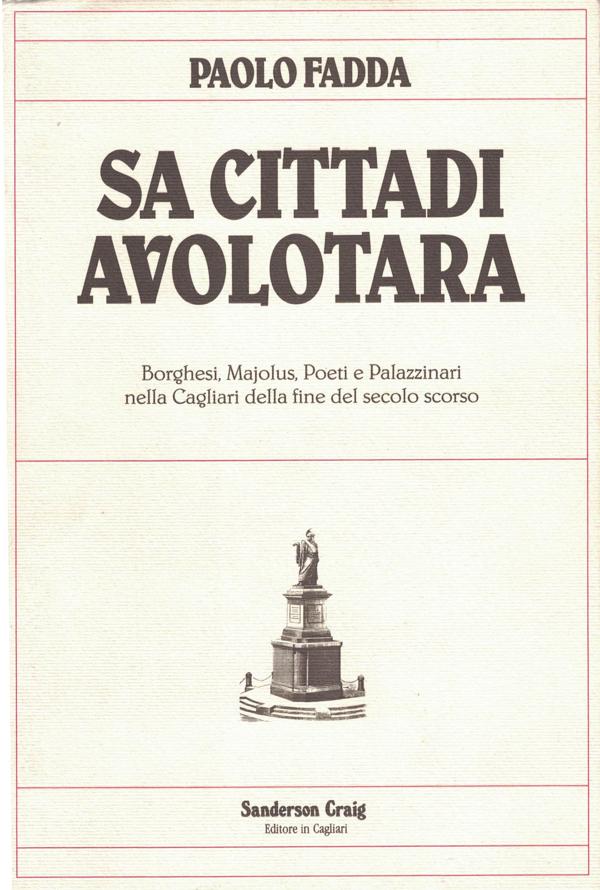
E’ un testo che qui appresso ripropongo con la sobria aggiunta di alcune personali riflessioni a latere, anche in parziale dissenso con Paolo Fadda. Bacareddiano l’uno e bacareddiano l’altro, sono convinto anch’io che il contributo intellettuale e tecnico-professionale della borghesia dei palazzi (non solo status symbol ma pure investimento reddituale) e delle imprese, in esse compresa l’agricoltura degli hinterland urbani, abbia avuto ricadute sociali rilevantissime nella crescente professionalizzazione anche degli antichi bastascius e giornaderis così nelle fonderie come nelle società ferroviarie dello scartamento largo o ridotto ed altrove: ché sempre, ed è inevitabile, il successo di un’idea o di una competenza, volgendosi a meritato accumulo di profitto, coinvolge in progress tutti i partecipanti alla filiera, anche i marginali. Però…
Può dirsi così: vero è che alle case popolari si arrivò tardi, a Cagliari, nella stagione della pubblicizzazione del gas e dell’acquedotto, in quel passaggio da Bacaredda a Marcello imposto dalla inarrestabile fibrillazione civica derivata dai moti del maggio 1906. Moti che non furono soltanto popolari, moti sui quali soffiarono elementi neppure tutti trasparenti del ceto medio – si ricordi il processo Bacaredda-Cao celebrato nel 1907, con la condanna del leader radicale seppure con derubricazione delle responsabilità sanzionate – e con intenti di greve corporativismo ed apertamente luddistici, cioè antimodernisti, ostili alla rete tramviaria e per il lavoro autonomo dei carrettieri, ostili alle tecnologie frigidarie comportanti una difesa dei prezzi decisi dai banconieri del Partenone… Ma anche fatta quella tara in pro del governo cittadino, restava a carico d’esso l’obiettivo ritardo nella determinazione di diretti interventi nella costruzione di case operaie, non soltanto nel calmieramento dei prezzi al banco.
Vale anche qui il discorso accennato per l’emancipazione dei bastascius e giornaderis: è vero che le grandi opere – fosse il municipio di via Roma o fosse il rifacimento del bastione con lo spianamento e l’unificazione della Leona e della Zecca, o fosse anche la scuola nuova di Stampace o quella di Castello – offrivano molte giornate di lavoro a un numero rilevante di operai domiciliati nei sottani senza luce ed aria dei quattro quartieri (come accertato dalla commissione consigliare Barrago-Aresu del primissimo Novecento); ed è anche vero che il “sistema”, e cioè la legislazione regolatrice della materia, ben più decisiva d’ogni delibera sindacale o consiliare, autorizzava la mano d’opera della provincia rurale a concorrere con parità di diritti nelle assunzioni dei cantieri cui aspiravano (spesso vanamente) i disoccupati cagliaritani, e che una scomoda concorrenza ad essi veniva altresì da una quota dei lavoratori ristretti per il resto del giorno in quel di San Bartolomeo… Insomma la questione sociale era allora piaga autentica dalle molte facce – e sopra tutto contavano le malattie della povertà che bruciavano i corpi e gli spiriti (anemie, scrofala, tisi, certi eczemi e talune oftalmie croniche…) – sicché un qualche rimedio per meglio saldare gli interessi della popolazione in miseria, appunto con il lavoro retribuito e con le case luminose e non tubercolotiche, a quelli espressi dalle dinamiche moderniste reclamate di tempi – ché, ripeto, della vita di persone in carne ed ossa si trattava! – si sarebbe potuto volere ed ottenere. E d’altra parte il discorso del novembre 1911 del sindaco Bacaredda tornato alla suprema magistratura civica dopo il fallimento della destra clericale intruppatasi senza sogno di domani nella giunta Nobilioni, pareva riconoscerlo alludendo ad altre prospettive ed altri equilibri, con quell’insistito (e poetico e moraleggiante) richiamo alla democrazia che superava il liberismo (o il liberalismo) trascorso, pur se ancora impegnava tutti a un patto di lealtà intergenerazionale, evitando che il bilancio comunale fosse gravato da un eccesso di debiti che altri un domani avrebbero dovuto ripagare…
L’antisocialismo di Bacaredda con Cocco Ortu avversario di sempre
Resta anche da dire – riprendendo un passaggio delle analisi di Paolo Fadda, un passaggio che temporalmente si fa intermedio fra la prima politica delle grandi opere pubbliche (che Bacaredda poté permettersi per quello straordinario introito, graduale ma certo, di oltre tremilioni e mezzo di lire derivante dalla composizione della trentennale vertenza con le Finanze statali a proposito dei tributi ostinatamente negati al Comune dall’Erario) e quello delle pubblicizzazioni delle infrastrutture idriche ed energetiche (e anche della costruzione delle prime case popolari a Campo Carreras): resta anche da dire dell’incontro pacificatore fra i partiti della Casa Nuova (o quel che d’essa era rimasto a quasi vent’anni dalla fondazione) ed i cocchiani. Né si dimentichi qui che L’Unione Sarda era sorta, proprio alla vigilia del voto popolare (ad elettorato invero ben ristretto) del novembre 1889, per sostenere le ragioni dei prossimi perdenti (ma sempre maggioritari alla Provincia), sicché dal quotidiano di viale Umberto (poi Regina Margherita) mai fino ad allora era venuto, con Vinelli alla direzione o con quella di Raffa Garzia, comprensione e perdono per le fatiche amministrative della giunta in carica.
Spinta anch’essa da un giornale – quella Giovine Sardegna del poeta ateo (ma fratello di due preti) ed infelice Emanuele Canepa – la stella bacareddiana era sorta, aggregando uomini delle professioni, degli impieghi, delle associazioni e delle imprese, per illuminare e dare prospettiva ad una società impoverita dall’inopinato crollo bancario del 1887, addebitato sì al Ghiani Mameli ma non di meno al suo referente politico e parlamentare Francesco Cocco Ortu, benché anche il Salaris – l’avversario giurato e tenace di Cocco Ortu – non avesse mai espresso, in proposito, un giudizio divergente da quello del futuro guardasigilli (che prenderà ad essere eletto, per ben otto legislature dal 1892, nel collegio di Isili – la patria di Ghiani Mameli – abbandonando Cagliari fattasi ostile).
Ma dunque il 1906, con quei radicali e socialisti (e repubblicani) che avevano guidato la rivolta popolare, pagando per essa lunghi mesi di detenzione di vari loro dirigenti, aveva spaventato il ceto moderato ed entrambe le fazioni liberali di Cocco Ortu e Bacaredda (e per qualche tempo anche quella guelfa). Saldare le forze era diventato necessario ed urgente. Sicché può ben dirsi che l’ideale parabola bacareddiana comprende nella sua permanente (nonostante gli interregni dei commissari prefettizi) ascesa un prima del 1906 ed un dopo: prima contro Cocco Ortu, il quale s’accontenta della provincia e del controllo del Consiglio Provinciale (Deputazione compresa) e lascia il capoluogo ai primati del sindaco-mito, dopo con Cocco-Ortu in chiave antisocialista o antisinistra ma pure con un’accelerazione insieme sociale e modernista: così soprattutto dal 1911, dopo la lunga crisi determinata dalle dimissioni della giunta Marcello (e del Consiglio da lui presieduto) per protesta contro il governo romano non adempiente circa la terza coppia di treni promessa alla composita linea Golfo Aranci-Cagliari e in seguito anche, nel fare municipale, al fallimento del centro-destra Nobilioni-Sanjust della primavera-estate di quell’anno cinquantenario.
La formazione dell’Associazione Democratica (con il suo organo ufficiale tutto giacobino dichiaratosi Il Giornale Democratico) e il patto stipulato con gli avversari di sempre – in primis i repubblicani (che tireranno calci soltanto nel 1914 per le spese eccessive sostenute dalla giunta offrendo il benvenuto al duca degli Abruzzi) – avvierà un’altra fase nella linea politico-amministrativa di Bacaredda, marcata sempre da un laicismo difensivo e sorvegliante (nessun saluto d’accoglienza al nuovo arcivescovo Francesco Rossi) e da un pragmatismo più aperto alle novità, anche nazionali, del tempo che s’avvia alla grande guerra e alle dispute anche cittadine fra interventisti e neutralisti.
Certo sono da apprezzarsi, a mio avviso, le tavole di difesa borghese che Fadda estende alla città capoluogo contro le sentenze (invero datate) di Carlo Baudi riducenti Cagliari ad una sanguisuga del contado. La “città-magnete” evocata da Fadda era invece quella che offriva, per le sue dimensioni anche demografiche, quotidiano sbocco alle produzioni agricole della provincia e opportunità di lavoro, come detto, a molti precari dei centri rurali del Campidano e non s’appassionava alle venalissime gare con la borghesia della rendita paesana.
Non meno apprezzabili sono le considerazioni che l’autore esprime riguardo alla pari dignità, in quanto a creatività e gusto del rischio (ma anche sensibilità sociale e filantropica), dei concorsi fra i borghesi detti AGDGADU e quelli più fedeli alle direttive papali o vescovili: «Ci sarà dunque, anche nel campo della fede in Domineddio, una Cagliari bifronte (di laici atei e di laici credenti), ma che, sotto sotto, avrebbe manifestato una sua convinta coesione su quell'agognato destino di progresso, rappresentato dalla conquista di migliori condizioni di benessere e di vivibilità sociali». E non trascuro che già nel 1865 – anche allora tempo di conta elettorale municipale (oltre che parlamentare) – i famosi “goccius de is frammassonis” identificavano, se davvero l’autore era un aristocratico decaduto, la borghesia con il liberalismo modernista e laico che aveva portato la capitale da Torino a Firenze, ma per trasferirla appena possibile a Roma, sottraendola al papa-re ed al boia che ancora nel 1868 avrebbe decapitato Monti e Tognetti…
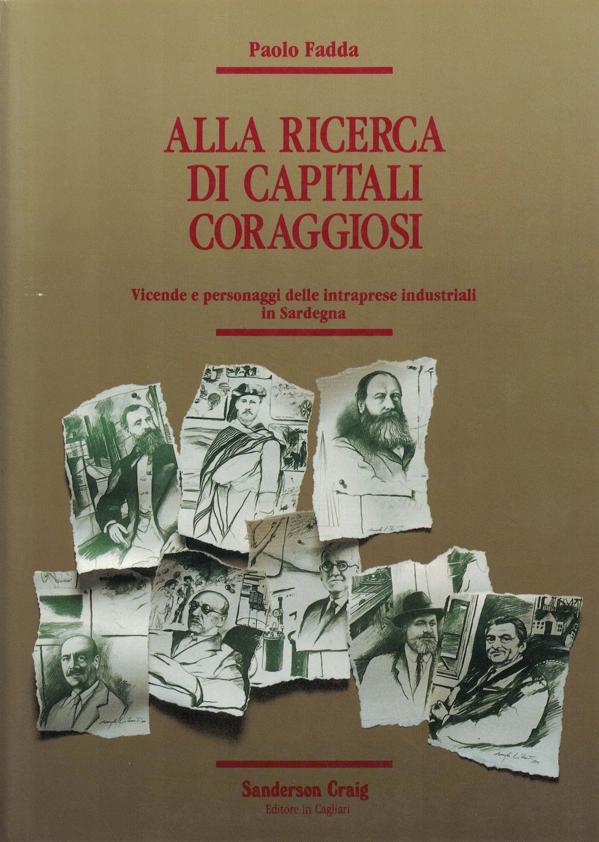
Illuminanti sono altresì – ed ampiamente presenti anche nelle pagine di altri storici, da Aldo Accardo a Gianfranco Tore – i giudizi di Paolo Fadda sulla “cagliaritudine” rapidamente acquisita dai borghesi continentali ed esteri di nuova residenza da noi e portatori di esperienze e culture che ancor più elevano il rango modernista della città e la sua propensione allo scambio, non solo materiale e di mercato, con le città d’oltre Tirreno.
Una città italiana
Pur nella relativa umiltà del confronto con Palermo o Napoli o Bologna, per non dire Roma e Milano, Cagliari nel suo epocale passaggio di secolo si trasforma, urbanisticamente, restando fedele a se stessa: l’abbandono dei vincoli di piazzaforte militare ha consentito, con l’abbattimento delle mura interne ed esterne, un migliore raccordo fra i quartieri che prima erano cittadelle semiautonome (tanto da aver autorizzato Fazio degli Uberti a pensarla frazionata più che policentrica, e così fu per quasi seicento anni!), ma anche di più: ha consentito il ridisegno delle direttrici viarie, quelle aperture e nuove vocazioni del Largo e di su Stradoni, soprattutto della via Roma, dal Carmine a Bonaria… e, un domani che è già quasi oggi, quelle proiezioni ulteriori verso la città estiva del Poetto. Dall’altra parte, vigneti e cardeti e orti a valle di Villanova cedono (o cederanno) progressivamente spazio ai cantieri che dalla via Nuova (poi Sonnino) scendono verso la strada per Quartu, attorno al solitario convento di San Benedetto, e magari verso la periferia di su Baroni… Eleganza architettonica del municipio e del bastione, eleganza architettonica della palazzata che prende, edificio dopo edificio, la via Roma da casa Zamberletti a casa Magnini, e oltre il municipio, gli immobili che affacciano in recto/verso sulla stazione ferroviaria e la piazza del Carmine (poi XXVII marzo): Vivanet e Rocca, Boscaro e Cocco, Aurbacher e Chapelle… o lungo il stabilimento molitorio dell’on. Merello, ma anche in su Stradoni o nel Largo (si pensi ai Bonfils e Aresu, ai Serventi e Zedda-Piras, si pensi ai Devoto-Cao e Castangia, dagli Accardo e Scano)…
Resiste la Playa, con lo stradone provinciale e qualche stabilimento balneare verso Giorgino – resistente anche in concorrenza con il Poetto, dopo il 1913 –, si allarga la rete dei collegamenti tramviari fra i rioni, l’elettricità ormai sconfigge ovunque il gas-petrolio per illuminazione stradale lasciandone le riserve prevalentemente al riscaldamento domestico… e anche le condotte idriche e naturalmente quelle fognarie premiano, già per l’igiene fattosi valore universale, la nuova edilizia residenziale. Strade alberate in centro e un paradiso botanico a fasciare anfiteatro romano riscoperto dal can. Spano proprio in contemporanea alla dismissione della città come piazzaforte militare, ma a fasciare anche la collina di Monreale ed il suo camposanto fattosi ogni giorno di più un museo d’arte a cielo aperto; e industrie ed ingrossi insediatisi nel viale San Pietro (poi Trieste), vero interfaccia economico-commerciale fra il capoluogo e la provincia, o stabilimenti anche in centro, come la Manifattura Tabacchi ed il Gazogeno, e ad Is Stelladas, come il birrificio ex Vinalcool o, all’opposto della pianta urbana, a Sant’Avendrace o Tuvixeddu, come il forno della calce evolutosi poi nella monumentale cementeria… per non dire ancora delle saline di est e di ovest, agli estremi lontani dell’abitato…
Né tutto è trionfo del porto o è produzione (oppure consumo) materiale né lo è il decoro urbano, l’eleganza architettonica o, appunto, i viali alberati, da Buoncammino alla via Roma. E’ – come ben dice Fadda – la città dei teatri e dei cinematografi, dei circoli e delle associazioni le più varie, da quelle patriottiche a quelle letterarie, la città della statuaria pedagogica, la città che si specchia nei monumenti che, uno dopo l’altro, abbelliscono piazze e palazzi, dalla Vergine Immacolata innalzata nel 1882 a Giovanni Bovio nel 1905, da Giuseppe Verdi nel 1901 ai quattro risorgimentali repubblicani (Mazzini e Garibaldi) e monarchici (Vittorio Emanuele II e Cavour) nel cinquantenario, da Dante a Giordano Bruno nel 1913… La città dei santuari mercedario e cappuccino, delle parrocchie e degli asili religiosi – valga a compendiarli tutti il nome di suor Giuseppina Nicoli (e dopo sarà tempo di suor Teresa Tambelli) –, la città dell’università e di una scolarizzazione crescente fino alle secondarie, la città dei giornali e dei partiti, la città della dialettica politico-sociale cui certamente contribuisce la bella novità della Camera del lavoro che coordina le leghe di mestiere… Città delle nuove librerie per soddisfare il gusto della lettura dei quidam e città dei quadri ad olio in abbellimento dei saloni d’incontro nelle case… Città che accoglie, in crescendo, i congressi di società nazionali – non solo gli ingegneri o gli agricoltori (da leggersi come proprietari-imprenditori agricoli) con tanto di ministro a dar conto e far promesse, ma anche, nel 1907, la Dante Alighieri, nata per sostenere o accompagnare la giovane emigrazione italiana all’estero, verso le Americhe, non soltanto per celebrare il mito del Sommo Poeta nel recinto patrio…
Naturalmente le tratte marittime e le linee telefoniche (dopo quelle telegrafiche) favoriscono questo accresciuto coinvolgimento e questa più matura consapevolezza nazionale di Cagliari ed anche il recepimento della città nelle consapevolezze del continente, ben prima delle stagioni turistiche che saranno cosa di anni ’30 e ’50 e naturalmente successivi. Così come lo favoriscono, questo recepimento, le banche: ché dopo lo sconquasso del 1887 (ma a lungo preparato!) scendono nell’Isola e nel suo capoluogo, uno dopo l’altro dalle centrali continentali, gli sportelli del Banco di Napoli già nel 1890, quelli della Comit nel 1906, del Credito Italiano che rileva e converte le agenzie della SBS di Ferruccio Sorcinelli nel 1912, e così a seguire con il Banco di Roma e la Banca Nazionale di Credito (poi BNL)… mentre il Credito Fondiario Sardo e le Casse Ademprivili di Cagliari e Sassari che pure guardano al prevalente soccorso agrario…
S’implementano le correnti d’inurbamento, si spalma la nuova popolazione nei nuovi quartieri o nei vecchi in riordino. Cagliari si fa ad un tempo polo attrattivo e collettività relazionale con il suo entroterra neppure soltanto immediato – quello quartese o selargino o dei due Pauli: si pensi soltanto a Villacidro, e neppure soltanto per le vacanze premarine o di mezza stagione…

Fadda: ecco la città del primo Novecento, anni d'una nascita febbrile e convulsa
A Cagliari si discusse molto, il primo gennaio del 1900, se quel giorno fosse il primo del nuovo secolo o, invece, dell'ultimo anno del precedente. Si trattava, per essere di buona memoria, di quanto già accaduto per l'anno Mille, senza però che si fosse fatta, in proposito, una condivisa chiarezza. D'altra parte, per dare retta ad un opinionista del tempo, la questione poteva ritenersi di "lana caprina", non diversamente dell'insoluto quesito se fosse nato prima l'uovo o la gallina...
Quel che è certo, comunque, ed anche documentato, che i due quotidiani cittadini di allora - L'Unione Sarda e La Sardegna Cattolica - avrebbero salutato quell'inizio anno con grande entusiasmo, quasi fosse l'inizio di una nuova era. E questo, pur non sfuggendo alle quotidiane polemiche. Infatti il primo avrebbe polemizzato con la decisione del Pontefice per aver deciso di proclamarlo "Anno Santo" e caricandolo così di indulgenze e perdoni; mentre il secondo avrebbe biasimato il decreto del ministero Pelloux che elevava come festa nazionale quel 20 settembre, giorno in cui trent'anni prima i bersaglieri del generale La Marmora avevano conquistato Roma, sottraendola al dominio temporale del Papa.
Ora, che fosse, o meno, l'alba del XX o il tramonto del XIX secolo, quel capodanno del 1900 vedrà Cagliari in piena trasformazione. Per la verità, s'era quasi scordata d'essere stata la capitale d'un Regno ed aveva accettato, disciplinatamente, d'essere soltanto una (seppure la più vasta) delle province del nuovo Regno unitario d'Italia. Per i demografi si trattava d'una città in rapida crescita, avendo ormai raggiunto i 50 mila abitanti (dai 30 mila che aveva trent'anni prima) ed in piena trasformazione sociale, anche grazie alle provvidenze contenute nelle leggi "speciali" varate a fine secolo per risollevare l'economia isolana dal ministro cagliaritano Francesco Cocco-Ortu.
La città appariva, o sembrava fosse divenuta, il laboratorio di idee e di progetti per una profonda modernizzazione dell'intera isola, nell'intento di venir fuori da un passato non certo esaltante, e per avvicinarsi il più possibile al benessere "continentale". In città si notava infatti una forte "voglia" di dare vita ad una stagione di riscatto e di cambiamento, tanto da farla ritenere il motore per il progresso dell'intera isola.
La sua stessa crescita demografica era avvenuta perché circolava dinai mera e soprattutto s'aprivano molte ed importanti occasioni di lavoro. Proprio in quegli anni era divenuta un centro attrazionale per tanti giovani sardi che dai loro villaggi s'erano inurbati per liberarsi dalle condizioni "servili" della condizione agropastorale.
A Cagliari, si diceva allora, si può far fortuna, sia trovandovi un lavoro salariato e sia ancora mettendosi in commercio, come sarebbe capitato a Efisio Cocco che, giunto dal suo paesello, aveva impiantato a Cagliari un'attività commerciale nei pressi della Chiesa di Nostra Signora del Carmine, divenuta in breve tempo fra le più importanti della città (il figlio Antonio sarebbe poi divenuto uno dei leader dell'imprenditoria cittadina).
Cagliari, infatti, era stata la prima nell'isola a liberarsi dal giogo della feudalità e ad imboccare le nuove strade della modernità (di fatto le altre città regie non erano riuscite a liberarsi dai loro connotati rurali: città-paese, quindi, o, con termine inglese, delle "agrotowns"). Al contrario, l'antica residenza dei viceré forestieri era riuscita a far propria l'aspirazione di trasformarsi in città borghese (che è poi l'altro nome di "moderna"), diventando sede di un organismo economico pulsante di scambi, di commerci e di varie attività.
In un certo senso quest'evoluzione avrebbe favorito la piena maturazione del sentimento di "cagliaritanità" (cioè di quel gradiente d'orgoglio e di vanto degli abitanti della capitale dell'isola) che ne caratterizzerà appieno la cultura identitaria. Vi sarebbe infatti da considerare, proprio per quel che s'è detto, che la Cagliari del passato non era mai stata una città dei cagliaritani: lo era stata, invece, dei tanti dominatori che ne avevano occupato strade e piazze ed ancorato i loro battelli nel suo porto, ritenuto ospitale e sicuro.
La darsena è stato da sempre il centro della portualità, sede soprattutto delle vocazioni sportive e pescherecce cittadine.
Infatti, mentre le élite d'antico regime, cioè gli aristocratici locali, avevano sempre ricercato, per il loro blasone, valenze e riconoscimenti a Cartagine, come a Roma o a Madrid o a Torino, i nuovi ceti borghesi sine nobilitate - tra cui molti d'immigrazione forestiera e, quindi, non autoctoni - si sarebbero fatti autenticamente "cagliaritani", dimenticando le loro origini nell'oltremare e sposando, con un forte atto di fedeltà e d'amore, la loro nuova patria.
In questo loro atteggiarsi, i cagliaritani apparivano nettamente diversi dai loro corregionali dell'entroterra rurale, quasi si fossero liberati dai vincoli e dalle costrizioni di quella feudalità "di fatto" che continuava ancora a dominare, con la cultura dei is meris e dei prinzipales, le campagne. Non che la città avesse troncato per questo i legami per le produzioni agropastorali: tutt'altro: ma le sue architetture, le sue istituzioni ed i suoi servizi mostravano ed evidenziavano caratteri chiaramente urbani.
Per la verità, quel che avrebbe fatto Cagliari ancor più città di altre, non sarebbe stato soltanto l'essere sede d'Università, di Tribunale, di Prefettura e di quant'altri uffici di prestigio (privilegi che aveva, ad esempio, anche Sassari), risiederà nella forte presenza di una fiorente economia commerciale legata alle attività ed ai traffici portuali, sia in entrata che in uscita dall'isola, tali - per quel che ne testimoniavano le cronache del tempo - da consolidare una posizione di indiscussa preminenza (per quel che si poteva valutare, fatto eguale a cento il valore complessivo dell'import-export isolano, i tre quinti transitavano per il porto cagliaritano).
Le domande sono certamente intriganti, e si riallacciano poi al filo conduttore con cui si è ritenuto di illustrare questa visione storica d'una città bimillenaria. In parole povere, si tratterebbe di chiarire se Cagliari abbia più avuto o più dato al resto dell'isola; e se, da questo bilancio di dare e avere di benefici, vi si possa trovare un'idonea giustificazione a quel carico di disamore, di pregiudizi e di rincrescimento che gli "altri" sardi avrebbero continuato a nutrire per la loro capitale.
Proprio quel porto - ormai attrezzato per accogliere vapori e piroscafi d'ogni tonnellaggio - era divenuto, con i suoi movimenti in netta crescita (dalle 308 mila tonnellate movimentate nel 1899 si sarebbe giunti nel 1911 ad oltre 420 mila), il magnete dello sviluppo economico non soltanto cittadino ma dell'intera isola. E, per altro verso, uno dei principali richiami per l'inurbamento. Andrebbe infatti rilevato come l'incremento demografico di Cagliari fosse assai più sostenuto di quello dell'intera isola: se a fine Ottocento la popolazione cagliaritana rappresentava il 5,20 per cento del totale regionale, con il censimento del 1911 i suoi 58.500 abitanti erano il 6,75 per cento dell'intero totale.
Ci sarebbe innanzitutto da precisare se la maggiore disponibilità di denaro nelle tasche dei cagliaritani sia dipeso dall'aver succhiato il sangue agli altri corregionali, o, al contrario, se ciò sia stato possibile per via della loro lucrosa intraprendenza nel dare vita ai commerci ed ai traffici extraisolani. Questo perché - per dare retta ad un'osservazione allora corrente - ogni cagliaritano era in grado di indirizzare verso gli acquisti familiari (fossero di generi alimentari come d'ogni altro bendiddio) quasi il triplo delle lire di quelle che, mediamente, erano in grado di spendere gli altri sardi (non a caso, ci fu molta meraviglia in una famiglia di prinzipales paesani nell'apprendere che una loro parente, "maritata in Cagliari con un negoziante", spendesse annualmente, solo per vestiti e cappelli, tre o quattro volte in più del loro bilancio per sostentare sei-sette persone!).
Si può ben comprendere, quindi, che a Cagliari giungessero abitanti da ogni dove, provocando quelle "contaminazioni" che avrebbero determinato - a giudizio dei puristi della sarditudine - quell'inquinamento dell'identità originaria dei sardi, con una colpevole resa rispetto a quella che Giovanni Lilliu ha definito la "costante resistenziale" della gente isolana.
Si è dell'opinione che in un'analisi di questo genere non serva fare riferimento soltanto a numeri ed a cifre, ma occorra servirsi di quel po' di letteratura che esiste, delle impressioni cronachistiche rintracciabili, ed ancora, e soprattutto, di una buona dose di buon senso. La discriminante sta proprio in quella contrapposizione fra cultura del profitto e incultura della rendita, fra impegno nel lavoro e amore per l'ozio, su cui si sarebbero divise le due borghesie dell'isola: quelle urbane e quelle paesane.
Ma Cagliari - viene da domandare - avrebbe vissuto questa sua evoluzione da città viceregia a città-emporio, mettendo in luce una propensione egoistica ed egocentrica, da vera città-sanguisuga (come l'avrebbe battezzata Carlo Baudi di Vesme)?; o, al contrario, avrebbe collegato la sua trasformazione nella vita economica e sociale in una dimensione isolana (o almeno extraurbana) da moderna e aperta città-magnete?
È difficile comunque stabilire se la città (qui intesa soprattutto nella sua dimensione politica) avrebbe fatto qualcosa per diffondere al suo esterno quella superiore qualità della vita di cui disponeva; o se, al contrario, si sarebbe tirata indietro di fronte a quella cortina di sbarramento con cui le comunità rurali avrebbero difeso il loro ancoraggio a quei valori di civiltà aurorale, fatti più di miti consolatori che di fertili e prodighe realtà.
Cagliari era comunque - come avrebbe scritto la giovane Grazia Deledda - qualcosa di diverso, una sorta di sogno americano per tanti giovani delle zone interne, un luogo dove andare per sfuggire al triste destino del bracciante e del servo pastore. Non è difficile comprendere questi sentimenti e queste aspirazioni, se ben si tengano a mente le illuminanti pagine di tanti illustri geografi dello sviluppo, da Carlo Cattaneo a Giustino Fortunato ed a Gaetano Salvemini; pagine e giudizi che ritroveremo anche nei più contemporanei Francesco Compagna e Giuseppe Galasso. Si tratta di osservazioni che mettono ben in evidenza come lo sviluppo "armonico" di molte regioni del Sud (e di quel Sud del Sud com'era allora la Sardegna) sia stato impedito per via della mancata diffusione nelle campagne (per inedia o per ostilità) di una civiltà urbana, certamente più alta e capace di generare progresso, lasciando comunque «ai letterati ed ai sociologi il gusto e la velleità di contemplare e di esaltare una mitica "civiltà contadina", quella che intristisce i paesaggi ed avvilisce gli uomini, trasferendo loro il desiderio di emigrare altrove».
Non vi è dubbio che l'intera isola avrebbe avuto necessità d'accedere proprio a quella superiore civiltà fiorita nella città, in modo da poter rendere possibile anche un suo atteso rifiorimento. Proprio da Cagliari, in quei primi anni del secolo, erano infatti partite alcune iniziative capitalistiche destinate ad avviare una prima, seppur timida, trasformazione agronomica delle campagne, progettando delle opportune regolamentazioni dei corsi d'acqua. Non vi è dubbio, infatti, che in città, negli ambienti dei suoi ingegneri e dei suoi capitalisti, si fosse guardato al mondo agricolo circostante come ad un'occasione importante per realizzare progresso (e, con esso, profitti).
Il tutto era favorito dal fatto d'essere divenuta residenza di un dinamico ed intraprendente ceto di ingegneri e di tecnici (tra Cagliari ed Iglesias operava il 95 per cento degli ingegneri dell'isola), molto attenti, oltre che interessati, a realizzare un deciso riassetto dell'amenagément territoriale di un'isola, intristita per secoli da campagne vittime di pessime condizioni ambientali ed igieniche. "Bonificare le terre" era parso lo slogan più popolare in quel primo decennio del '900, anche perché, con il grande raduno nazionale degli ingegneri, svoltosi a Cagliari nel 1902, le opere di bonifica idraulica erano assurte a strumento fondamentale per riuscire a liberare le regioni del Sud Italia dal loro sottosviluppo e dalle miserie sociali.
Vi è da osservare, per la storia, che quell'attenzione della borghesia urbana verso il riscatto economico del mondo rurale, sarà oggetto di molta diffidenza e di altrettanta ostilità. Le chiavi di lettura per questi atteggiamenti non possono essere, obiettivamente, univoche, ma è certo che la costituzione di un'economia agricola di taglio imprenditoriale (così come nelle cascine lombarde o nelle fattorie toscane) era destinata a sconvolgere radicalmente gli assetti sociali delle campagne isolane con una proprietà assenteista e redditiera ed un ceto di contadini e di pastori "senza terra", ostaggio e succubi di meris e prinzipales.
Non vi e dubbio che anche questa discrasia fra città e campagna (fra i progetti di trasformazione modernizzante e la conservazione dei tradizionali assetti sociali in vigore nella gestione delle terre) darà nuova sostanza a quell'invidia che un'esautorata aristocrazia fondiaria e le depresse e povere comunità di contadini e di pastori avrebbero nutrito nei confronti di quegli uomini della città che erano divenuti i possessori di quella ricchezza "mobiliare" che aveva soppiantato le vecchie regole feudali d'una ricchezza e d'un potere fondati sulle proprietà fondiarie.
In effetti, quattro secoli di feudalesimo (condito, per di più, alla spagnola) avevano fatto nascere nelle campagne un forte ed agguerrito sentimento antiurbano (il che vorrebbe dire antiborghese).
A questo avrebbero inciso, e non secondariamente, anche talune remore religiose, con preti e frati che dipingevano il "dio denaro", venerato dai borghesi, come un temibile e famelico Belzebù, poiché s'erano schierati in difesa - parrebbe - dell'ostilità della borghesia verso i grandi privilegi - economici e politici - goduti dal clero nelle costituzioni feudali.
La stessa laicità di quei borghesi, spesso sconfinante in anticlericalismo, avrebbe giocato la sua parte, tanto che nella Cagliari di quegli anni dare del borghese ad uno valeva dargli del "mangiapreti", prima ancora, magari, che dello sporco affarista. Eppure, a scorrere le vicende di quegli anni, non ci si incontra con una omogenea identità borghese, dato che ci s'imbatte in borghesi massoni (e, quindi, per definizione atei) ed in borghesi credenti, talvolta con visibili ostentazioni di bigottismo religioso.
Quel che sembra unirli, così come s'è visto, appare l'identico obiettivo d'una migliore qualità della vita da conquistarsi attraverso quella che gli ipercritici avrebbero chiamato "l'industria del guadagno". Ora, per chi ha letto, e ricorda, il "Mastro don Gesualdo" del miglior Verga, potrà meglio intendere questa dicotomia sociale venutasi a creare fra chi "s'è fatto da solo la roba" e chi l'ha solo ereditata. Fra chi, con il lavoro d'impresa, è salito in ricchezza e prestigio e chi, invece, dopo aver consumato la roba, è rimasto a vivere il suo declino «con lo stemma marchionale logoro, scantonato, appeso ad un uncino arrugginito».
Perché - in questi anni per certi versi rivoluzionari - s'assisterà alla trasformazione dell'economia, con l'aristocrazia che si dissolve nell'ozio e nell'inedia, e con l'entrata in campo di chi ha fatto propria la massima (un'ossessione quasi religiosa, dirà Verga) di doversi impegnare per creare, con le proprie capacità, denaro, prestigio e potere.
La Sardegna, e Cagliari in particolare, non ha avuto il suo Verga, e di quelle vicende è giunto soltanto un tenue ricordo, forse inciso nelle case di quei "nuovi ricchi", nelle loro feste sibaritiche, e - ancora - nella loro ricerca d'emancipazione sociale, portando all'altare nobili ragazze (sarà il caso di un borghese Ghiani-Mameli coniugatosi con una contessa Cao di San Marco, quasi una replica cagliaritana delle nozze del Gesualdo verghiano con la nobile Bianca Trao).
Ci sarà quindi grande similitudine fra quella Sicilia e la coeva isola di Sardegna, ambedue gravate da un lungo e triste passato feudale, ed ambedue alla ricerca di una rivalutazione con l'emergere di un nuovo ceto di cittadini "di bono stato", com'erano chiamati i borghesi nei liberi comuni.
Ma quell'industria "del guadagno" era destinata ad ottenere risentimenti ed invidie, tant'è che in una delle prime elezioni comunali saranno molti a far propaganda perché gli elettori non votassero quei negozianti cittadini, rei d'essere soltanto degli affaristi succiasanguni, cioè degli avidi speculatori sui bisogni e sulle necessità della povera gente. Senza Dio e senza morale, li avrebbe accusati un predicatore dal suo pulpito, anche se gran parte dei marmi e delle pitture che ornavano quella chiesa erano poi dono munifico di quei peccatori.
Pur con molta difficoltà, e nonostante quelle ostilità, il pensiero borghese (che era poi una forma mentis più che una ideologia) era destinata a farsi strada. D'altra parte quel mito del progresso, delle grandi invenzioni e d'una più ampia libertà, di fratellanza e d'uguaglianza sociale, che ai borghesi di fine Ottocento erano serviti come arma contro le vecchie classi privilegiate, era ormai destinato a scontrarsi con l'ideologia antiborghese degli agitatori marxisti. Ma pur combattuta, quella forma mentis borghese sarebbe divenuto il filo conduttore del trasbordo della comunità cagliaritana verso la modernità ed il progresso d'intonazione "continentale".
Per certi versi, anche la valenza politico-elettorale della borghesia cittadina sarà oggetto di una contestazione-opposizione. Per via, certamente, di certi atteggiamenti lobbistici messi in atto da alcune fratellanze più o meno massoniche, tacciabili, non ingiustamente, d'affarismo occhiuto e spicciolo. Sarà questo il peccato-vizio più evidente, tanto da vedere sminuita quella che sarebbe potuta essere una positiva virtù: e cioè l'aver diffuso fra la gente una coscienza patriottica, legata al grande progetto risorgimentale, peraltro accompagnata, non sempre ma spesso, «dal senso di perseguire una via di sviluppo con più giustizia e più libertà. Per tutti».
Per la verità, quegli atteggiamenti lobbistici delle borghesie cittadine avrebbero anche sviluppato un forte patriottismo municipale, perché Cagliari potesse gareggiare in modernità e comfort con le città continentali più titolate. Sarà questo un patriottismo che avrà come obiettivo quello di migliorare l'immagine cittadina, di pensare a dei boulevard ed a promenade sul mare, spaziosi e pittoreschi, con dei moderni palais confortevoli ed imponenti (l'uso del francese è giustificato dal fatto che s'intendeva perseguire i rivoluzionari progetti parigini del barone Haussmann).
Che dentro a quel patriottismo ci fosse anche un po' d'affarismo, come corse voce, sarà poi anche vero, anche perché nella forma mentis di quei borghesi, il palazzo non sarà più soltanto un segno di prestigio come residenza avita per una casata nobiliare, ma diverrà soprattutto oggetto di business, d'un investimento capace di dare reddito.
Così i patrimoni più cospicui e gli investimenti più innovativi della città avrebbero imboccato la discesa verso il mare, tanto che per misurare le ricchezze cagliaritane non s'utilizzeranno più gli ettari di terra posseduti o gli starelli di grano prodotti, ma le migliaia di lire in portafoglio ed i profitti conseguiti con gli affari. Ed i più ricchi erano i negozianti e gli industriali, e non più i conti ed i baroni, ridottisi - come s'usa dire - "in bolletta", per via d'un costo della vita che ormai non lascerà più spazio all'ozio
Che la città si trovasse quindi in una fase convulsa (e forse anche disordinata) della sua trasformazione urbanistica, sarà certamente vero, ma è anche giusto affermare che in quell'essere en marche c'era tutta la voglia - patriottica ed affaristica insieme - di fare "grande" Cagliari. Pensando che qualche peccato veniale potesse pur doversi commettere, pur di raggiungere l'obiettivo.
Sarà questa la Cagliari delle prime fabbriche, dei cantieri e delle officine che poi rappresenteranno e testimonieranno le tappe del progresso. Così lo sviluppo sarebbe divenuto il denominatore comune dell'ideologia municipale della borghesia cagliaritana.
C'è infatti un discorso che ricorre spesso nei cultori delle tematiche dello sviluppo, e soprattutto fra quanti si sono occupati delle fasi di passaggio da un'economia dominata dal settore primario ad una più avanzata; ed è quello che attiene allo stretto legame esistente fra modernizzazione ed urbanizzazione. Cioè della necessaria diffusione dei valori urbani (della qualità della vita cittadina) nei paesi e nelle comunità rurali.
Si tratta ovviamente di un discorso che va visto nell'habitat sociale della Sardegna rurale d'inizio Novecento, con gran parte dei paesi privi di acquedotti, di fognature, di condotte mediche, di farmacie e talvolta anche di cimiteri, afflitti in più da eccessi di morbilità per la presenza di malattie derivanti da condizioni igieniche troppo spesso insufficienti ed indecorose.
Una condizione che farà sì che la città venga vista come una sorta di eden, con i suoi bei lampioni a gas, le fontanelle con l'acqua corrente, il water-closet "originale inglese", i caffè ed il restaurant, il grande ospedale sotto il colle del Buon Cammino ed i suoi 45 studi medici specialistici (dall'oculista al ginecologo ed al dentista). Una città da detestare e da invidiare, come il povero invidia il ricco.
Va ricordato come in uno dei centri della Trexenta (ma l'esempio potrebbe valere per molti altri centri della provincia cagliaritana), ancora nel 1900 solo undici degli ottocento abitanti sapessero leggere e scrivere, ed accanto a cinque famiglie definite di possidenti-benestanti, ve ne fossero almeno centotrenta in condizione d'indigenza, confermando percentuali molto simili a quelle che a metà Ottocento aveva rilevato il Casalis (quando ci s'alimentava con pane e saliva).
Differente appariva la situazione della città. Infatti nel medesimo periodo le famiglie benestanti (cioè quelle che vivevano solo di rendite) erano passate dall'i 1,5 al 4,3 per cento, mentre quelle dei commercianti ed imprenditori vari dal 7,9 al 12,9 per cento, e quelle dei liberi professionisti ed impiegati dal 13,4 al 18,4 per cento. Le famiglie operaie erano ormai circa il 48,5 per cento ed il restante poteva essere indicato come "indigente". Nel contempo era anche molto migliorata la condizione culturale, in quanto l'analfabetismo in città era sceso a meno del 50 per cento della popolazione maschile, ma era ancora quasi al 70 per cento quella femminile. Il dato cittadino dell'analfabetismo registrava comunque circa diciotto punti percentuali in meno di quella globale registrata nell'intera regione.
Non v'era dubbio alcuno che fosse una città en marche, come scrivevano i giornali locali, anche se la sua distanza, in termini di qualità e benessere della vita, con le città continentali del Regno era ancora abbastanza ampia. Fatto eguale a 100 il reddito medio di un milanese o di un genovese - stimava Francesco Saverio Nitti - ad un cagliaritano ne continuavano ad andare poco più di sessanta, ma il sardo mediamente non giungeva che ad averne quaranta. Utilizzando il ritrito esempio del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, si potrà dire che il cagliaritano era il meno povero od il più ricco dei sardi di quegli anni.
Ma, al di là del crescendo delle attività e, insieme, della popolazione, la città stava allargando i suoi confini, attraverso la conquista di nuovi spazi in pianura, sempre più somigliando alla Karalis descritta da Claudiano. D'altra parte gli stessi progetti d'espansione, come immaginati dal Todde-Deplano e perseguiti in un certo modo anche dai nuovi consoli civici, andavano prefigurando dei nuovi quartieri lungo un asse lineare che dalla chiesa della Madonna del Carmine ad Ovest giungesse ad Est fino a quella dedicata alla Madonna di Bonaria, scorrendo a bordo mare. Un altro asse, questo verticale in direzione Nordest, avrebbe allungato la città costruita oltre Campo Carreras (l'odierna piazza Garibaldi) in direzione dell'abitato di Pirri.
Sembrava che ci si fosse ispirati alle coeve idee dello spagnolo Arturo Soria y Mata (l'inventore della ciutad lineal) che avevano superato le concezioni medioevali della città chiusa e murata, proponendo una città nuova, fatta di spazi prima che di volumi, capace di interloquire anche urbanisticamente con il territorio circostante e che avesse il mare (e soprattutto il porto) come polmone di sviluppo e di progresso.
Seppure ci fosse, in quei proponimenti, un po' troppo di utopia mista ad interesse (divenuti oggetto di irrisione e di critica nelle sale del "Filarmonico" e nei foyer del Civico e del Cerruti), si trattava comunque di una visione innovativa della città, aprendola verso una nuova dimensione in cui il mare diveniva qualcosa da vivere da vicino più che da osservare da distante. Si tracciavano nuove strade, s'aprivano piazze e si costruivano case e palazzi con buona tecnica e con sapiente forma, dato che in città avevano studio una trentina d'ingegneri civili e si poteva contare su maestranze provette.
Memori delle "lezioni" di Gaetano Cima e degli esempi continentali di quella che verrà chiamata l'architettura umbertina, i nuovi fabbricati potevano a buon diritto fregiarsi del nome di "palazzi", e questo per il pregio dei materiali, l'armonia delle forme e la dimensione dei volumi. C'era certamente in quei progettisti molto delle idee e degli insegnamenti di chi, in quegli anni, andava per la maggiore in Italia, come Emanuele Rocco, Guglielmo Calderoni e Pio Piacentini.
Si assisteva, nelle tecniche del costruire e nel disegnare vani e volumi, al trionfo della luce e degli spazi ed all'utilizzo di nuovi materiali, tanto da far ritenere come l'architettura avesse avuto una parte importante. Questo perché, ricordando un concetto caro al Mumford, l'architettura riflette e mette a fuoco un'ampia varietà di fatti sociali, da quelli riguardanti i bisogni e le aspettative dei cittadini a quelli riflettenti le trasformazioni economiche in atto, fino ad interessare la cultura ed il pensiero di tutta una società.
Tra l'altro, l'abbandono dei pregiudizi d'ancien regime, conseguente al diffondersi ed al prevalere dell'ideologia borghese, avrebbe modificato radicalmente il concetto stesso del fabbricato per abitazione. Non più il "palazzo" come segno documentale del proprio status sociale (da utilizzare come residenza della famiglia), ma l'edificio signorile da offrire al mercato (in vendita o in locazione), come prodotto terminale d'un processo industriale che partiva dalla materia prima (i metriquadri del suolo) per trasformarsi poi verticalmente, attraverso l'utilizzo di capacità e tecniche nuove, in metricubi di volumi. Con l'obiettivo di conseguirne il profitto (o, per dirla con i critici, il maggior profitto possibile).
A quest'indirizzo avrebbe poi dato un forte ausilio quell'espansione demografica della città, in atto proprio in quegli anni, e, conseguentemente, il crescente incremento della domanda di nuove abitazioni da parte di nuovi ceti emergenti. L'affermarsi di un sempre più numeroso ceto mercantile e, conseguentemente, dell'incremento di un nuovo ceto di famiglie abbienti, avrebbe creato un interessante mercato soprattutto di abitazioni signorili.
Certo, al di là degli indubbi vantaggi conseguenti alle migliori condizioni di abitabilità e di vivibilità, questo considerare il palazzo non come oggetto d'uso ma come strumento di profitto, avrebbe determinato anche degli inconvenienti, come quelli conseguenti all'affacciarsi di quello che molti ritengono essere stato un pernicioso virus cittadino, la speculazione edilizia.
Pur non volendola ignorare, si è però dell'opinione che occorra ricercare una maggiore obiettività di giudizio In una città che continuava a soffrire di un forte deficit d'abitazioni e che, peraltro, era soggetta a continuativi flussi d'inurbamento, la "questione abitativa" era divenuta la principale emergenza cittadina. Promuovere e facilitare nuove costruzioni, favorendo l'impegno del capitale privato, era divenuto il programma delle amministrazioni cittadine più evolute, a Cagliari non diversamente che a Milano od a Genova.
D'altra parte, così come oggi s'incentivano gli investimenti industriali ed artigianali concedendo gratuitamente quote importanti di capitale, affinché si possa attenuare l'emergenza lavoro, così allora si favorivano, con deroghe ed esenzioni tributarie, i privati costruttori, perché dessero una mano nel risolvere i problemi dell'abitazione, soprattutto se destinata ai ceti "popolari".
Non vi è comunque dubbio alcuno che l'industria edilizia e gli investimenti immobiliari avessero facilitato la formazione di nuove ricchezze, capaci di sovvertire le precedenti gerarchie cittadine.
Anche per questo avrebbe continuato a trovare spazio, nelle chiacchiere cittadine, il rimpianto per la città viceregia d'un tempo, «rinchiusa tra le mura pisane e le tre torri», con quelle vie strette e quelle case trasudanti umanità, per via «di quei lunghi filari di panni stesi». In quel rimpianto per il tempo perduto, o per quelle memorie molto proustiane, non si teneva a mente quel poco che c'era dietro le mura o al di là delle porte; s'erano dimenticati «quei campi maleodoranti (dove sarebbe sorta la stazione) rimasti luogo di gettito di tutti gli immondezzai», e quel luogo da corte dei miracoli com'era diventato il porto cittadino, ben differente da quello che un tempo lontano era stato battezzato gloria Pisanorum.
Così la nascita della città di pianura verrà accompagnata da aspre censure e forti ostilità da parte di molti cagliaritani - eterni frondeurs, secondo un'opinione corrente -, mal disposti ad accettare, ed a condividere, quella nuova architettura che aveva sovvertito le gerarchie dei luoghi cittadini, emarginando dal progresso Casteddu 'e susu, e costruendo una nuova città con edifici per "nuovi ricchi", sovraccarichi di «ornati, sminuzzamenti, frastagliature, elementi tutti più inutili che giovevoli a discapito della vera eleganza ed imponenza».
Ora, al di là di queste osservazioni critiche, e senza per questo dover sopravalutare, nell'analisi dello sviluppo cagliaritano, l'incidenza del settore delle costruzioni - di opere pubbliche e residenziali - per la numerosità dei suoi addetti (esecutori e imprenditori), è certo che esso avrebbe caratterizzato in maniera significativa gran parte della storia economica cagliaritana per tutto il Novecento. Cagliari sarebbe divenuta in breve tempo "città di costruttori", favorendo la costituzione di un'importante filiera di attività accessorie (si pensi ai falegnami, ai ferraioli, agli idraulici, ai marmisti, ecc.) che avrebbero formato quello che oggi si potrebbe chiamare un distretto industriale "verticale". Sarà la città, come ne avrebbero scritto, del lavoro dei maistrus 'e linna, 'e muru, ferreris, arregioleris, pintoris, ecc.) e non più dell'inedia dei don e de is merisi così il fabbricare e il possedere belle case, comode e dai comfort moderni sarebbe divenuto motivo d'orgoglio e di distinzione per i cagliaritani e fonte di gelosia e di critica da parte dei paesani (avrebbe scritto un possidente di un piccolo centro del Sarrabus, invitando dei suoi amici cittadini, che sarebbe stato molto lieto di far conoscere loro la sua nuova casa «che neanche a Cagliari...»).
Il primo, grande cambiamento della città - quello che l'avrebbe portata ad eccellere nel firmamento isolano - era stato provocato proprio da quegli interventi nell'edilizia residenziale. La città, infatti, s'era estesa non solo territorialmente, ma aveva sempre più assunto un'immagine moderna, per via di fabbricati dalle linee eleganti, ampi e ben rifiniti, alla moda "continentale", come si diceva in giro.
Gli autori ed i protagonisti di quest'evoluzione "modernista" sarebbero stati, nell'ordine, gli uomini della borghesia, quelli della politica municipale, is maistrus ed ancora i tanti piccaperderis e manorbas del proletariato cittadino, ed infine gli ingegneri. Si potrebbe anche dissentire da quest'indicazione, ma è certo che proprio a quei protagonisti, alle loro capacità ed alle loro iniziative, si dovrà molto del "salto" che Cagliari farà nel suo assetto civile.
Può essere anche importante sottolineare la forte infusione di "secolarizzazione" (cioè di una laicità sconfinante nel laicismo areligioso) nella società cagliaritana di quegli anni. E, quindi, l'allontanamento dalla Chiesa di una parte, non minoritaria, dell'establishment locale. Soprattutto di quello d'estrazione borghese. Per contro, la nobiltà cittadina - proprio per marcare la sua distanza da quei nuovi ricchi "adoratori del dio denaro" - si sarebbe stretta attorno ai rappresentanti più autorevoli della Chiesa cittadina, provocando così un'altra importante cesura nella società locale. Di questa situazione, peraltro vissuta anche difficoltosamente in diverse famiglie cittadine (il padre "negoziante" e massone anticlericale e la madre, discendente d'antica nobiltà, terziaria francescana), ne darà testimonianza la discesa nelle competizioni elettorali, di un partito di cattolici (il PPI di don Sturzo). Un partito, come diranno criticamente le "gazzette" del tempo, che si sarebbe aperto quasi esclusivamente ai rappresentanti di quella aristocrazia papalina (ancora incollerita per l'affronto fatto a Pio IX con Roma capitale del Regno) da sempre "esulata" in is arrugas strintas di Casteddu 'e susu.
Non era poi una critica senza riscontri dato che quel partito, nella sua versione cagliaritana, mostrerà assai poco di «popolare», non solo per via dei modesti suffragi ricevuti nelle urne ma soprattutto dal nome dei suoi candidati, in gran parte beneficiati dal fatidico "Don".
Peraltro, nelle quasi cinquanta chiese cittadine, le liturgie, non solo domenicali, sarebbero state seguite da una assai numerosa folla di fedeli, e le pie congregazioni di carità avrebbero trovato sovvenzioni sempre più sostanziose anche dagli esponenti di quel milieu borghese targato A.G.D.G.A.D.U.
Né avrebbe destato meraviglia negli ambienti cittadini che un venerabile "trentatre" della massoneria locale avesse donato, ad un ordine religioso, un vasto appezzamento di terreno per edificarvi un collegio per impartire ai giovani locali un'educazione cattolica.
Ci sarà dunque, anche nel campo della fede in Domineddio, una Cagliari bifronte (di laici atei e di laici credenti), ma che, sotto sotto, avrebbe manifestato una sua convinta coesione su quell'agognato destino di progresso, rappresentato dalla conquista di migliori condizioni di benessere e di vivibilità sociali.
Fin qui si è già detto molto sulle borghesie cittadine, sul loro formarsi e sul loro moltiplicarsi soprattutto negli affari e nelle attività di commercio. È opportuno ora aggiungere che, dalle provenienze quasi esclusivamente forestiere del passato, si sarebbero aggiunti, man mano, nuovi apporti di provenienza locale, in gran parte dai paesi dell'interno.
Si è già detto di Efisio Cocco e delle sue vincenti attività mercantili, si dovrà quindi aggiungere - per dare conferma a quest'assunto - il ricordo di Francesco Zedda-Piras, giunto da Tiana (piccolo centro delle Barbagie) e divenuto uno dei principali attori dell'economia cittadina. Ma l'elenco di quanti immigrati dai loro paeselli avrebbero fatto fortuna in città, è molto più ampio, in quanto non andrebbero dimenticati Francesco Spissu, Ernesto Sanna-Manunta, Giovanni Mascia, Giovanni Zedda-Zedda, Guglielmo Cau, Felice Muscas, ecc.
Is piccioccus ’e crobi (i ragazzini con il cesto) fanno parte della simbologia duna Cagliari d'animi, quando per "tres o cincu soddus" aiutavano i "benestanti" a trasportare la spesa dal mercato.
Si trattava d'una borghesia fattasi sempre più indigena per nascita ed autoctona per formazione e, quindi, strettamente legata alle sorti della città. Ci sono diversi esempi a convalida di questo stretto rapporto: rileggendo, ad esempio, i resoconti della locale Camera di commercio (di fatto, il tempio dell'economia cittadina), si ha la percezione netta di quanta correlazione ponessero tra il successo dei propri affari ed il progresso della città. Alla quale, quindi, dedicavano mille attenzioni per promuovere e per sollecitare gli interventi atti a migliorarne gli standard civili.
«Quel che è necessario è fare della nostra Cagliari, la Livorno del Mediterraneo inferiore - aveva indicato l'ingegner Giorgio Asproni ai suoi colleghi dell'istituzione camerale - perché ne abbiamo le capacità e le possibilità, sol che si sappia sviluppare le grandi risorse sconosciute ed inespresse che sono nella nostra terra e nella nostra gente. Sta quindi a noi - aveva aggiunto - non rimanere con le mani in mano in modo da fare di Cagliari una città di livello internazionale».
Si trattava certamente di un invito alla mobilitazione, ad operare insieme verso un obiettivo che andava ben oltre (solo che lo si riferisca alla cultura di quel tempo) agli obiettivi molto autarchici allora prevalenti.
In effetti, gli intendimenti di quella borghesia erano ben in linea con la crescita ed il progresso della città, tanto da condividerne le stesse direttrici di sviluppo. Si può quindi sostenere, senz'ombra di dubbio, che quella borghesia s'era fatta "cagliaritana" a pieno titolo, anche perché sempre più stretti rapporti coniugali e familiari avevano fatto sì che anche casate forestiere come Gavaudò, Pernis o Devoto - intrecciatesi con quelle dei Tronci, dei Pisu, dei Melis od anche dei "sangue blu" come i Sanjust od i Villahermosa - fossero divenute titolari di una provata ed indiscussa cagliaritanità.
A fianco di questi borghesi c'erano poi gli uomini della politica municipale. Pare necessario spiegare il perché di quell'aggettivazione - municipale - con cui si è inteso meglio identificare quegli esponenti del potere locale, proprio per rimarcarne le differenze con quella del parlamento nazionale. Vi è infatti da sottolineare come il gruppo di comando del Municipio cittadino (il cui leader era il sindaco Ottone Bacaredda) avesse un legame molto stretto con gli ambienti economici locali, tanto che alcuni esponenti ne saranno cooptati come assessori nella Giunta. Nello stesso Consiglio comunale v'erano diversi "negozianti" ed "industriali", di fatto numericamente superiori ai liberi professionisti (assai pochi erano i nobili). C'era dunque quasi una simbiosi fra la politica bacareddiana e quella auspicata dai gruppi dell'imprenditoria borghese per far progredire la città, mentre sarebbero emerse, talvolta, delle polemiche contrapposizioni con la rappresentanza parlamentare egemonizzata dalla personalità di Francesco Cocco-Ortu.
Non appare facile capire quali fossero, effettivamente, le differenze fra i bacareddiani ed i cocchisti, anche se talune incomprensioni erano nate fin dai tempi dei fallimenti bancari di fine '800 e dei differenti atteggiamenti assunti nei confronti del banchiere Pietro GhianiMameli (peraltro, come già detto, da considerarsi come uno dei "grandi borghesi" della storia cittadina). Non ci sarebbe motivo, quindi, per indicarne la collocazione politica con le denominazioni classiche - sinistra e destra - e neppure con le amicizie parlamentari privilegiate (zanardelliani o crispini). Alcune male lingue la facevano discendere dall'appartenenza (o per la simpatia) a differenti camarille cittadine più o meno affaristiche, dato che le differenziazioni si sarebbero sempre manifestate su problemi cittadini (il vincolo degli interessi - avrebbe rilevato Aldo Accardo nella sua storia post-unitaria della città - sarebbe stato sempre più forte delle appartenenze ideologiche).
È certo, quindi, che i loro rapporti non furono mai molto buoni, anche perché al Cocco-Ortu, potente parlamentare ed uomo di governo, avrebbe dato ombra il favore che Bacaredda riscuoteva fra gli elettori cagliaritani, cioè della sua città.
Un aspetto anch'esso importante, e che ci riconduce al punto di partenza di quest'analisi, è che con Bacaredda sarebbero entrati nell'amministrazione comunale molti uomini "nuovi", quasi tutti provenienti dall'ambiente economico cittadino, rompendo così quello che era stato il "maso chiuso" dei cocchisti, come venivano chiamati i seguaci del Cocco-Ortu.
Al di là di questo, pare importante riconoscere a quegli uomini della politica municipale il merito d'aver saputo accompagnare, con intelligenza ed acume, il progresso della città, mostrando soprattutto molta sensibilità amministrativa ed una chiara visione prospettica sulle trasformazioni da urbane da realizzare.
Ha giustamente ricordato lo storico Gianfranco Tore come, dal 1900 in avanti, fosse stato avviato un imponente programma di opere pubbliche, «con un investimento annuo di più di un milione di lire, trasformando Cagliari in una vera città en marche». Era divenuta la città dei grands travaux, delle grandi sistemazioni viarie, del tracciamento dei grandi viali alberati, del completamento degli edifici scolastici, al servizio di una popolazione che al censimento del 1901 aveva superato i 50 mila abitanti.
Il nuovo Palazzo civico e l'imponente bastione di Saint Remy avrebbero contribuito, e non poco, ad arricchire l'immagine architettonica della città, da sempre così povera di monumenti. Era in atto, senza dubbio alcuno, una importante trasformazione urbanistica, di arricchimento dell'arredo e delle funzioni cittadine, nell'obiettivo di arrivare ad una effettiva "saldatura" fra quelle che erano state le "appendici" di pianura (Marina, Stampace e Villanova) con il centro di Castello, il piano comunale predisposto dall'ingegner Giuseppe Costa ne aveva tracciato le linee direttrici ed il grande impegno finanziario dell'amministrazione Bacaredda ne aveva avviato la realizzazione.
Cagliari era ormai un'altra città, aveva una linea tranviaria che l'attraversava e la collegava con l'entroterra quartese, aveva, nel litorale di Giorgino, i suoi stabilimenti balneari alla stregua di Genova e di Livorno, aveva i suoi caffè ed i suoi restaurant, non diversamente dalle grandi città continentali. Erano degli aspetti che la distinguevano ancor più dall'altra Sardegna, e se contribuivano ad aumentarne l'orgoglio, contestualmente ne aumentavano l'invidia, e, quindi, i pregiudizi per una città che la si indicava sempre più come sanguisuga (a tal proposito, rincarando la dose, l'oristanese avvocato Porcella, membro della Deputazione provinciale, avrebbe definito Cagliari «la beniamina della nonna», ed il suo municipio «il Creso della Sardegna»!).
Occorre ricordare che Ottone Bacaredda era divenuto sindaco della città nel 1889, appena quarantenne (era nato a fine dicembre del 1848), succedendo al professor Gaetano Orrù. Proprio nel suo discorso d'insediamento, così come riportato dalle cronache, avrebbe indicato pragmaticamente le linee della sua azione che s'impegnava a svolgere «con mente serena, con spirito elevato, non chiedendo consiglio alle nostre personali simpatie e amicizie od a rancori o ad animosità che abbassano e umiliano, non ubbidendo alla influenza di partigiane passioni, ma nel nome della moralità e della giustizia per il bene della nostra Cagliari. Il tutto - concludeva - senza odi e senza rancori».
Tutta la sua politica municipale sarà svolta quindi a far grande la città, nella convinzione di dover lasciare un suo segno indelebile nella storia cittadina e, contestualmente, imponendone le sue risorse e le sue qualità "d'eccellenza" sul resto dell'isola. Imponendo alla sua amministrazione d'essere - come spesso amava ripetere - una "casa di vetro".
In questo suo impegno avrebbe trovato non poche difficoltà nella situazione economica generale del Paese, e nell'emergere di aree di crisi e di malcontento fra gli strati più deboli della popolazione cittadina. Per quel che riporteranno le cronache politiche, sarà proprio all'inizio del Novecento che sarebbe emersa la "questione" delle due Italie: di un Centro-Nord in sviluppo e in continuo progresso e di un Sud (con le due isole) in gravi difficoltà e, soprattutto, con vasti problemi di malessere e di povertà sociali.
Forse ci sono dei dati che servono a testimoniare quel forte disagio e le ragioni del malcontento popolare. Li aveva elaborati nel 1902 Francesco Saverio Nitti: come ricchezza mobile (reddito) per abitante la Sardegna era sotto di poco meno di un terzo della media del Regno; la circolazione monetaria per abitante era, nell'isola, neppure un quinto, mentre la spesa pubblica nei quarant'anni unitari aveva visto l'isola penalizzata fortemente (neppure 12 lire per abitante rispetto alle 64 del Centro-Nord).
Saranno anche queste le ragioni (aggravate dalle ripetute penurie nei raccolti agrari) a motivare quei moti popolari che, nel maggio del 1906, porteranno all'attenzione della pubblica opinione cagliaritana la "classe operaia". La crescita dei prezzi nei generi di prima necessità ed i bassi salari con cui venivano retribuiti carichi di lavoro sempre più pesanti, avrebbero fatto esplodere una rabbiosa, ed anche violenta, sollevazione popolare.
Che la responsabilità fosse poi da addebitare all'amministrazione Bacaredda sarebbero legittimi molti dubbi, ma è certo che essa divenne l'oggetto-obiettivo dell'esasperazione generale. I ripetuti e prolungati scioperi dichiarati dalle diverse categorie di lavoratori (dalle sigaraie ai tranvieri ed ai portuali), insieme agli affollati cortei per le vie cittadine, avrebbero dato l'immagine di una vera e propria sommossa popolare, con scontri e devastazioni di cui ancor oggi c'è memoria.
Non è nella logica di questo racconto riportare la cronaca di quelle tumultuose vicende (che peraltro hanno avuto diversi attenti cronisti): si è ritenuto di farne menzione perché proprio da allora anche la classe operaia sarebbe divenuta, al pari della borghesia cittadina, protagonista della vita sociale cagliaritana. La stessa nascita della Camera del lavoro nel 1907 dovrebbe essere ricordata come una tappa importante nel cammino cagliaritano verso la modernità continentale.
Una modernità - occorre ricordare - che ormai andava investendo tutta la società cittadina. E che aveva il suo slogan nel verbo "costruire". Ed anche Cagliari diverrà protagonista di quello che in tutt'Europa sarebbe stato indicato come "il tempo degli ingegneri", cioè dei costruttori.
La tecnica e la scienza per saper ben costruire case, ferrovie, porti, navi e macchine d'ogni genere, erano divenute essenziali per attuare quella grande rivoluzione industriale in atto nel vecchio continente e nelle Americhe. Un po' dovunque la "scienza politecnica" veniva considerata la chiave giusta per aprire alla società del XX secolo le porte del progresso. Dovunque, quindi, ma anche a Cagliari, dove gli ingegneri sarebbero divenuti l'avanguardia virtuosa della borghesia cittadina, oltre che i protagonisti delle grandi trasformazioni sociali, tecniche ed ambientali portate dal nuovo secolo.
Lo stesso svolgimento a Cagliari, come già ricordato, del X Congresso nazionale degli ingegneri italiani, risulterà un'occasione straordinaria per portare questa professione a protagonista della modernizzazione della società e dell'habitat locale. In quell'occasione, attorno al centinaio e passa di ospiti, s'era unita una numerosa pattuglia di ingegneri cagliaritani (in gran parte provenienti dalla scuola ingegneristica del Valentino). Fra essi andrebbero ricordati Edmondo Sanjust, Beniamino Pirola, Giorgio Asproni, Stanislao e Dionigi Scano, Carlo Floris-Thorel, Enrico Stefani, Luigi Contivecchi, Gracco Tronci-Pernis, Antonio Cao-Pinna, Enrico Devoto.
Se la borghesia cittadina, come s'è visto, era assurta, con Bacaredda, a promotrice politica del progresso della città, quegli ingegneri ne sarebbero divenuti lo strumento tecnico, dato che ad essi - o a taluni di essi - si dovranno le linee guida utilizzate dal ministro Cocco-Ortu per varare la legislazione "speciale" a favore dell'isola.
Proprio ad essi - od a taluni di essi - si dovrà quel miracolo idroelettrico che, con l'elettricità e le bonifiche, darà il via alla più importante opera di redenzione sociale mai vista in Sardegna. Il fatto che si fosse formato a Cagliari il fertile laboratorio di quelle idee e di quei progetti (ricordiamo le opere sul Tirso, sulla piana terralbese e sullo stagno di Santa Gilla) avrebbe dato un nuovo importante titolo di merito alla città, divenuta quindi anche capitale del risorgimento isolano.
Ormai Cagliari, come avrebbero scritto Giancarlo Sorgia e Giannino Todde, era riuscita «a travalicare le vecchie mura medioevali per recitare un ruolo di primo piano nell'area isolana e mediterranea, pur trovandosi di fronte ad una crisi di crescenza resa ancor più grave dalla situazione di un'isola condizionata da pesanti squilibri socio-economici».
Comunque, pur con i tanti distinguo accennati, la città, per via di quelle nuove magnifiche case e quegli imponenti nuovi palazzi avrebbe suscitato un «nuovo e forte sentimento d'orgoglio e d'amor cittadino» in tutti i suoi abitanti.
Lo spirito borghese, introdotto da un intraprendente ceto di uomini "del fare", sarebbe così riuscito a prevalere sulle chiusure tradizionaliste ed attendiste del vecchio establishment feudale. La città, con quel suo febbrile operare, «si dimostrava attiva e partecipe, al corrente tempestivamente di quello che avveniva allora in Europa. E ritrovava anche in un ritorno all'antico, una vocazione mediterranea, che sarebbe stata l'ispiratrice della nascita di un cantiere navale [promosso dal Falqui-Massidda] e di operazioni commerciali nell'area tunisina [finanziate dal Credito Agricolo e Industriale Sardo di Pietro GhianiMameli]», come ci hanno ricordato proprio Sorgia e Todde in quella loro documentata istoria delle amministrazioni civiche cagliaritane.
La Cagliari degli anni bacareddiani andrebbe interpretata in questa sua ricerca di modernità e di collegamento con il resto del mondo, alla riconquista di quegli spazi che erano stati fenici e romani ed al riavvicinamento ad un porto che divenisse finalmente una risorsa per il progresso cittadino, occasione di lavoro oltre che di profittevoli affari. Una discesa verso la pianura che ha poi trovato il suo simbolo nel palazzo Civico progettato da Crescentino Caselli e da Annibale Rigotti.
L'asse "fronte mare" della via Roma, con i suoi palazzi ariosi ed i suoi portici monumentali, era un po' la risposta che la borghesia degli affari aveva inteso dare, come segno di modernità e di progresso, al conservatorismo edilizio d'una nobiltà che s'era caparbiamente arroccata nelle impervie stradine del Castello ed in quelle abitazioni che di aristocratico avevano ben poco. Così nella stessa forma e nella composizione dei palazzi edificati a Cagliari in pianura (accenniamo qui ai palazzi Vivanet, Accardo, Magnini, Zedda-Piras, Zamberletti, Serventi, Garzia, Manca, Chapelle, ecc.) si possono leggere, visibilmente, i complessi processi di cambiamento avvenuti non solo nell'arte del costruire (l'uso dei materiali, l'utilizzo dello spazio, l'introduzione dei comfort igienici, ecc.), quanto quelli attinenti ai nuovi e differenti bisogni e desideri che la comunità cittadina esprimeva per la qualità dell'abitare e del vivere.
Saranno poi queste le cause che avrebbero determinato, nel giudizio dei posteri, un'aspra critica nei confronti di quella borghesia locale che aveva assunto la guida della città e del suo sviluppo, sostituendosi alla nobiltà di Casteddu 'e susu. Ad essa verranno attribuiti peccati d'ogni genere, soprattutto miopie ed egoismi, affarismi ed ingordigie, oltre che una certa dose di incultura e di grettezza spirituale. Tralasciandone, purtroppo, la valenza degli indubbi meriti. Si sarebbe così sostenuto - con un evidente peccato di faziosità ideologica - che la Cagliari borghese sarebbe stata edificata non certo per far più grande e meglio vivibile la città, quanto per aumentare a dismisura il portafoglio di pochi furbi plutocrati (irridente e polemica definizione usata allora per chi, in nome del capitalismo, comandava e s'arricchiva «ai danni del popolo minuto»).
Anche di recente sono state espresse molte acide critiche su quest'esplosione edilizia della città del primo '900, espresse anche da pulpiti autorevoli, addebitando soprattutto alla borghesia locale (a quei ceti produttivi che avevano soppiantato la vecchia e oziosa nobiltà redditiera) d'avere pensato solo ai propri interessi materiali ed al proprio diletto, con l'arricchire la città di passeggiate, viali e piazze, dimenticando però di dare soluzione al problema abitativo delle classi più deboli.
Così lo stesso salto di qualità che Cagliari compie in quegli anni con il nuovo porto, l'acquedotto, la rete fognaria, l'illuminazione pubblica, ecc. non trova sufficiente valutazione, sopravanzato dalle aspre accuse rivolte a quel «sistema di potere clientelare e paternalistico» messo su dalla borghesia produttiva locale per «difendere e salvaguardare i nuovi modi di produzione capitalistica», fondati più sullo sfruttamento operaio che sull'innovazione tecnica e tecnologica».
Così anche quella stessa polemica sulle case popolari come alternativa al palazzo civico od al nuovo imponente bastione di St. Remy rischierà di essere niente più che un pretesto per poter definire reazionaria od antipopolare un'amministrazione civica che s'era voluta caratterizzare con un vasto programma di opere pubbliche, peccando più d'immagine - come s'è sostenuto da taluni - che di sostanza. Una critica che non avrebbe tenuto conto, non solo dell'atmosfera e delle condizioni di quegli anni difficili, ma anche delle stesse configurazioni sociali del tempo.
Poco importava, a quelle sirene marxiane, rilevare che il reddito medio d'un cagliaritano fosse aumentato del 40 per cento nell'ultimo ventennio; che i giovani iscritti nelle scuole secondarie cittadine fossero aumentati di due volte e mezzo; che gli interventi del "Monte di pietà" fossero in una fase di progressiva diminuzione, e che i consumi degli alimenti-base - come il pane e i legumi - si fossero triplicati (come noterà una rilevazione della locale Camera di commercio).
Seppure piegate più ai voleri dell'ideologia partigiana che a quelli dell'obiettività storica (come si potrebbe intuire), quelle accuse anti-borghesi paiono tutto sommato ingiuste. Perché dimenticano che è stato merito di quella calunniata borghesia (come avrebbe detto Bacaredda) se, pur tra indubbi peccati di egoismo e di omissioni, s'era potuto avviare e compiere il rinascimento della città, la sua entrata fra le comunità moderne, la sua emancipazione anche sul fronte del lavoro e del progresso (a Cagliari, si poetava allora, v'è mera traballu e mera dinai).
Con l'affermarsi di un gruppo sempre più numeroso, e per certi versi abbastanza coeso di uomini "nuovi" (interessati a far cambiare "marcia e direzione" allo sviluppo della città), si sarebbe riusciti a far sì che Cagliari si potesse allineare, «sempre più attiva e partecipe», a quanto «stava avvenendo allora in Europa». Ma, fatto assai importante, non avrebbe perduto i segni della sua identità passata, i valori della tradizione e l'orgoglio delle proprie origini. Ed in questo «ritorno all'antico ritrovava e rinnovava una vocazione sempre più in linea con il progresso, con quel che scienza e tecnica stavano regalando alla qualità della vita civica».
Andrebbe anche rilevato che - anche per merito di quella emergente borghesia - la città appariva ben più "acculturata", più in linea con i movimenti artistici e letterari che erano emersi nelle terre "continentali" Così, per far bella la propria casa, s'acquistavano oli e acquerelli (i più ricercati erano quelli di Guglielmo Bilancioni, di Enrico Castagnino e di Raffaele Ciuffo, tutti con atelier in città), si frequentavano gli studi di scultori come Cosimo Fadda e Giuseppe Sartorio, e, soprattutto, s'acquistavano e si leggevano libri.
Le librerie più frequentate erano quelle di Felice Muscas e di Camillo Brundu (ambedue in Marina, a dimostrazione di dove risiedessero i più fedeli acquirenti) e, fra i libri più acquistati, erano i romanzi di Antonio Fogazzaro e di Guido da Verona e le poesie di Giosuè Carducci. Per i ragazzi di allora il best-seller era l'avvincente storia dei loro coetenei "della via Pal", indimenticabile capolavoro dell'ungherese Ferenc Molnar.
Con i libri, e la lettura, si cercava un collegamento con il mondo che stava al di là del mare, sprovincializzando la propria anima prima ancora che la propria vita fisica. S'andava a teatro - prosa, lirica e operette erano le opzioni più gettonate - anche per vivere emozioni differenti da quelle possibili nel "piccolo mondo" cittadino, emozioni che - per dirla con le memorie di un cagliaritano d'allora - erano poi delle vere e proprie evasioni culturali, cioè dei viaggi virtuali verso un mondo diverso, affascinante ed intrigante.
Cagliari, quindi, si sprovincializzava, guardando più al mondo della cultura e della conoscenza che a quello delle corti e delle loro pittoresche ma sterili liturgie, tanto prediletto dalle classe aristocratiche del passato. Si faceva politica non più come conquista di poteri personali, ma come strumento per una crescita collettiva, cercando sempre di conciliare il proprio particolare con gli interessi generali della gente. E con la politica si cercava di armonizzare sempre più la città con la campagna, non dividendone più, come un tempo, interessi e privilegi, ma ricercandone motivi e legami di unità.
Il fatto poi che i nuovi cagliaritani (quegli oltre 20 mila giunti in città in meno di vent'anni) fossero in gran parte provenienti dai villaggi dell'interno, sarà la controprova che l'evoluzione borghese, con
la sua politica, aveva fatto di Cagliari la città dove trovare lavoro e buon vivere, dove era possibile riscattarsi dalle miserie e dalle angustie del villaggio. Dove, lo si dica senza arrossire, era possibile imparare un mestiere moderno (quanti bastascius e giornaderis, ad esempio, sarebbero divenuti esperti tornitori e provetti saldatori nelle officine di Rocca o di Doglio o manovratori e fuochisti nelle ferrovie!) e, soprattutto, liberarsi da quell'avvilente condizione di rimanere serbidori a vita, sempre carichi di doveri e privi di diritti, alla corte de is meris.
Saranno quindi quei primi anni del Novecento il vero ed importante turningpoint, il punto di svolta di Cagliari per l'entrata nella modernità. E da allora, lo si voglia o meno riconoscere, la città sarebbe divenuta il faro su cui tutta l'isola dei villaggi avrebbe cominciato ad indirizzare la propria rotta.
Devi accedere per poter commentare.


