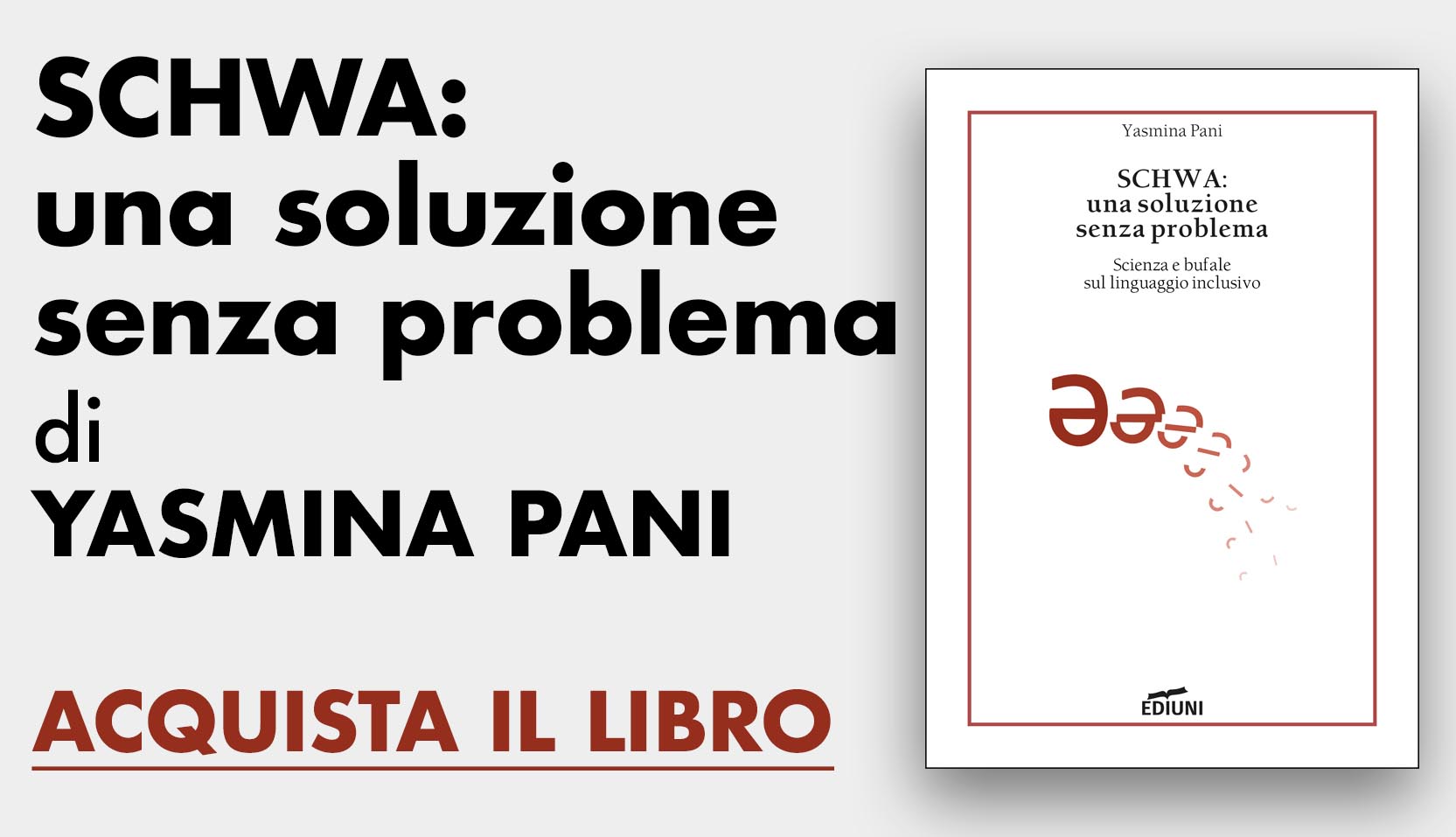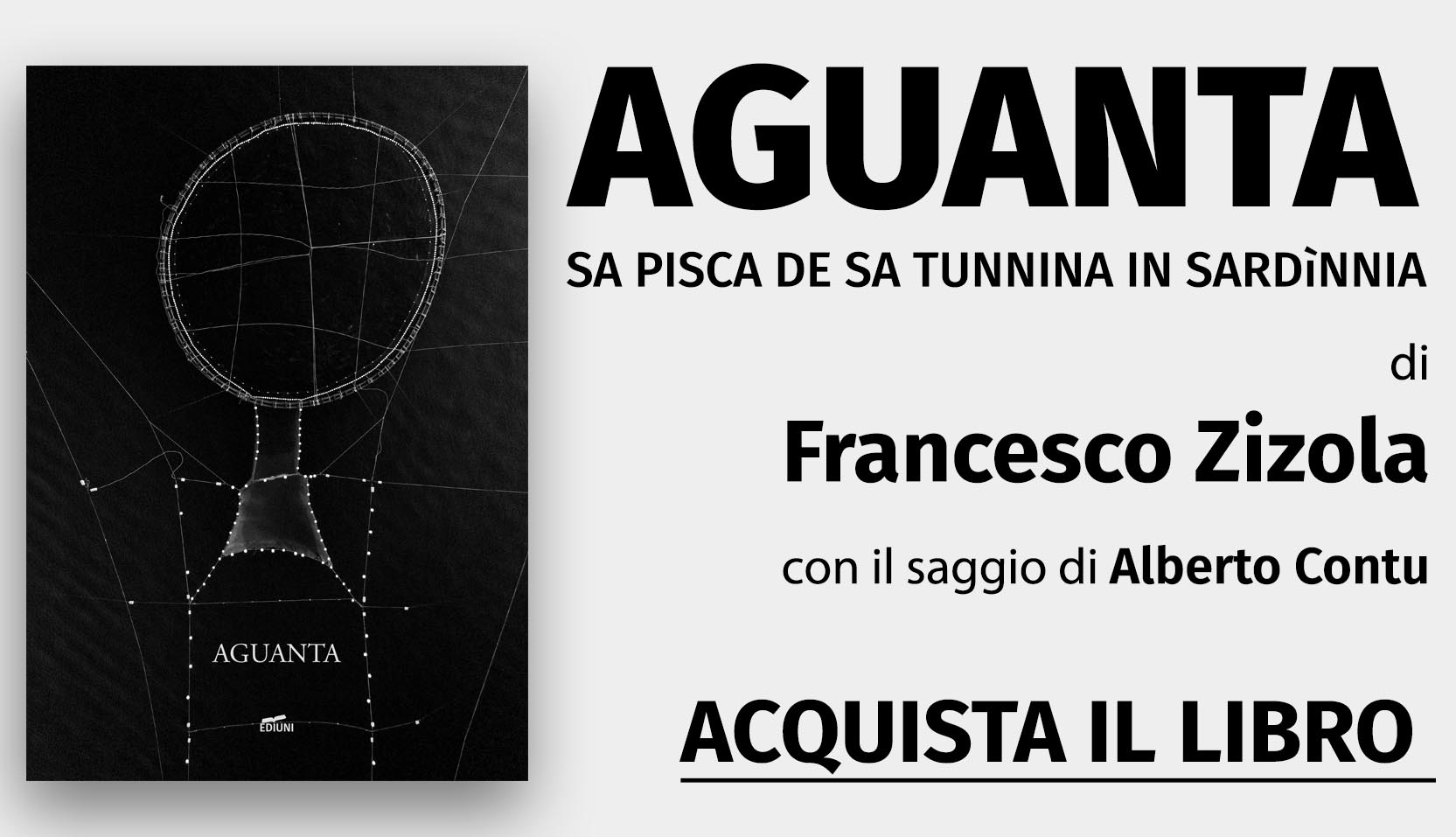Sa Die de sa Sardigna, le radici e le ali
di Antonello Angioni

Pubblico il testo del mio intervento svolto la mattina del 28 aprile, in Consiglio regionale, in rappresentanza del Comitato per “Sa Die de sa Sardigna”.
Signora Presidente della Regione, Signor Presidente del Consiglio, consigliere e consiglieri, assessore e assessori, autorità presenti,
Il titolo di questo intervento - Sa Die de sa Sardigna, le radici e le ali - richiama l’endiadi radici/ali che, con grande efficacia espressiva, crea un rapporto dialettico e una relazione necessaria tra la memoria storica e l’apertura verso la modernità: relazione importante perché, come diceva il prof. Lilliu, “senza radici non si vola”. Le radici e le ali sono dunque simboli che rispettivamente evocano ciò che del passato permane nel presente, come sedimento e fondamento d’identità, e esprimono la necessità di collegare la nostra soggettività collettiva (di popolo) a esperienze, culture e mondi anche distanti.
Le radici le ritroviamo nella nostra storia, nella memoria del popolo sardo e nella sua peculiare identità. Una storia che, nel corso dei secoli e nel fluire non sempre lineare del tempo, a tratti, è stata gloriosa e fatta di progresso perché la Sardegna non ha rappresentato solo il terreno di dominazioni esterne e di arretratezza. Una storia peraltro poco conosciuta, soprattutto dalle giovani generazioni, e che dovrà essere rivalutata nel presente, anche attraverso un lavoro capillare nelle scuole, quale base dell’agire politico e premessa per uscire dalla nostra condizione di subalternità, sottosviluppo e insicurezza, per diversi aspetti tuttora presente.
Le ali le ritroviamo invece nella nostra aspirazione verso un mondo migliore che potrebbe - e perché no - realizzarsi anche attraverso un rapporto privilegiato di scambi tra la Sardegna e l’area euro-mediterranea, in chiave di cooperazione e di sviluppo pacifico, laddove l’insularità dovrà rappresentare un punto di partenza per impostare la “Questione Sarda” su basi nuove. “Questione” che, sempre attingendo da Lilliu, potremmo più correttamente definire “Nazionale Sarda” e che - pur essendo stata approfondita solo da epoca relativamente recente (penso in particolare a G.B. Tuveri che, per la prima volta, diede forma compiuta e moderna a tale espressione) - rimanda a un passato molto lontano, a un fascio di questioni irrisolte da molti secoli e alle istanze di un popolo, distinto dai dominatori di turno, che non ha ancora completato il proprio processo politico di autodeterminazione e di autogoverno.
In siffatto contesto, la celebrazione de “Sa Die” rappresenta sicuramente un momento di festa del popolo sardo, ma anche - nello spirito della legge istitutiva - di riflessione: uno sforzo teso a cogliere, nei molteplici segni del passato, la dimensione politica che ci aiuta a capire il presente e a progettare, attraverso uno sforzo di creatività, il futuro.
È in questa prospettiva che la civiltà prenuragica e, ancor più, quella nuragica possono acquisire un valore che va ben oltre il dato statico delle opere materiali: dolmen, menhir, domus dei janas, pozzi sacri, nuraghi. Perché quelle opere - che ci riportano al ciclo del megalitismo che si sviluppò in ambito mediterraneo (e non solo) - testimoniano le vicende di un popolo che ha vissuto in questa terra, si è espresso, si è organizzato (dotandosi di regole e gerarchie) e, soprattutto, ha lottato per la sua affermazione sino all’incontro-scontro con le culture dei popoli venuti dal mare che, più risoluti e dotati di una soverchiante forza militare, nel corso della sua lunga storia, l’hanno conquistato e hanno impresso nel territorio i segni della loro egemonia: dai punici ai romani, dai vandali ai bizantini, dai pisani ai genovesi, dai catalano-aragonesi ai piemontesi.
Ed è proprio attraverso il contatto con le diverse civiltà venute dal mare che si è instaurato un continuo rapporto dialettico - fatto di aspri conflitti ma anche di graduali integrazioni - tra le forze “autoctone” e le forze “esterne”. I segni che l’uomo, in ogni tempo della sua presenza, ha lasciato sul territorio documentano ancora come si è svolta nel corso dei secoli la storia della Sardegna. Oggi, qualsiasi villaggio dell’Isola è custode di memorie storiche e talvolta di tesori d’arte d’inestimabile valore. E la lingua, con prorompente vitalità, esprime il lungo cammino dei sardi, le origini e i diversi apporti culturali.
La Sardegna è terra di lunghe persistenze, di radici forti, che racchiude i segni di una civiltà millenaria: terra a lungo infestata da pirati, oggetto di continue occupazioni e di baratti di dominio che hanno dato vita a incroci di etnie che si sono via via innestate su un fondo autoctono, occulto e misterioso. Nel corso della loro plurisecolare vicenda, spesso i Sardi hanno dovuto piegarsi ai propositi egemonici di entità statuali, economiche e culturali “esterne”, non solo sul piano geografico ma anche dal punto di vista politico, perché diversamente orientate rispetto a quanto andava maturando nell’Isola: tendenza questa favorita dalla situazione locale, assai debole e frammentaria per poter organizzare forme di resistenza adeguata.
La Sardegna è quindi rimasta una “Nazione” incompiuta, aperta all’influsso di stirpi opposte, di genti e culture diverse, spesso contrastanti e ostili tra loro. Dopo la lunga e complessa fase protostorica, più di tremila anni di storia, di cultura e di tradizioni hanno determinato una stratificazione di civiltà difficilmente riscontrabile altrove: oggi abbiamo un’Isola ricca di bellezze archeologiche, artistiche e paesaggistiche che costituiscono una componente essenziale della nostra identità e affascinano il visitatore sin dal primo incontro.
Questa terra, grembo di un’antica civiltà che l’isolamento e il tempo hanno frantumato e disperso in mille cantoni mai ricondotti a unità, nel corso della sua tormentata vicenda, a volte ha brillato di luce propria (penso alla civiltà nuragica ma anche all’età giudicale), a volte è scomparsa quando il cielo della storia si è offuscato per lasciar spazio alle dominazioni esterne. Tuttavia, ogni popolo che è sbarcato in questa terra ha portato non solo segni di potere e desideri di egemonia ma anche pezzi di vita, radici, cultura e talvolta speranze di libertà e di progresso. In ogni caso, l’elemento esterno si è sempre dovuto misurare col carattere fortemente conservativo della civiltà sarda e delle sue genti. Anche in ciò risiede la grande forza, il fascino e la vitalità della Sardegna, la sua “costante resistenziale”, per usare ancora una volta un’efficace espressione del prof. Lilliu.
Ma va anche detto che, nel corso di questo lungo e tormentato cammino, il popolo sardo - pur esprimendo una civiltà dotata dei requisiti positivi per “resistere” allo strapotere delle forze esterne e per conseguire, attraverso una graduale evoluzione, una autonoma “personalità storica” - non seppe mai uscire effettivamente da una condizione tribale per fondersi in uno Stato organizzato, forte e compatto.
Anche la vicenda del triennio della “Sarda Rivoluzione”, che va dal 1793 al 1796 (ma sarei propenso a estendere il periodo rivoluzionario sino al 1812 e dunque per un intero ventennio che si conclude col sacrificio dei martiri di Palabanda), conferma quanto detto. Al riguardo, in via incidentale, ricordo che ieri, per iniziativa del Comune di Cagliari, è stata ripristinata la targa che ricorda l’episodio: proprio ieri, in occasione dell’anniversario della morte di Gramsci, che, studente liceale, per un certo periodo abitò in un appartamento nel corso Vittorio Emanuele, a poche decine di metri da S’Ecca Manna (il portico di Palabanda).
È nell’ambito del ventennio rivoluzionario sardo che si colloca l’insurrezione cagliaritana dell’aprile del 1794 posta dalla Regione Autonoma a fondamento de “Sa Die de sa Sardigna”, che oggi celebriamo in quest’Aula. La vicenda peraltro ci ricorda anche l’assenza di una classe dirigente in grado di tramutare la “Nazione sarda” in uno Stato unitario e coeso: Nazione che non è data solo dall’esistenza di un popolo, stanziato in un territorio e dotato di un’identità condivisa, ma è anche “sentimento” di appartenenza nazionale.
Si rende quindi necessario uno sforzo serio e tenace teso a ricomporre i frammenti, tuttora sparsi, del nostro passato e a disseppellire, dall’oblio e dalle manipolazioni di parte, i passaggi fondamentali che hanno segnato il divenire storico del popolo sardo e ne hanno forgiato la sua attuale fisionomia. In questo contesto, l’analisi storiografica dovrà anche contribuire a dare una risposta ai molteplici problemi del presente in quanto il sapere storico costituisce un’indispensabile premessa a quell’agire politico attraverso il quale si operano scelte che sono influenti per l’avvenire del popolo sardo.
Non vi è dubbio che, in questa prospettiva, il sapere storico debba costituire il sale della ricerca culturale e dell’azione politica contemporanea che, facendo comprendere il passato, illumina il presente e può dare una solida consistenza all’impegno civile delle nuove generazioni. Lo storico è quindi chiamato a rimuovere le zone d’ombra, chiarire i punti ancora controversi e offrire gli anelli mancanti della catena che consentano di capire quei passaggi - e non sono pochi - delle vicende del popolo sardo rimasti ancora senza adeguata spiegazione.
In termini politici vi è l’esigenza, sempre più sentita, di andare verso il recupero dei valori espressi dalla migliore tradizione autonomista e federalista sarda che consenta il rilancio di una moderna “specialità”, con forti connotati di responsabilità e quindi di autogoverno, che dovrà collocarsi nell’orizzonte europeo, mediterraneo e internazionale, dando al rinnovamento della società sarda un marcato carattere di apertura e di tensione verso gli orizzonti più avanzati della cultura, dell’economia e della politica. Perché l’autonomia non può essere solo ricerca dei segni del passato - sia pure molto importanti per la costruzione dell’identità - ma deve rappresentare anche l’assunzione piena della responsabilità storica che un popolo ha rispetto al proprio diritto e dovere di governarsi e quindi lo strumento per la costruzione del proprio futuro.
Bona “Die de sa Sardigna” a tottus.
Devi accedere per poter commentare.